1970-Parte-2-Pp-242-466
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
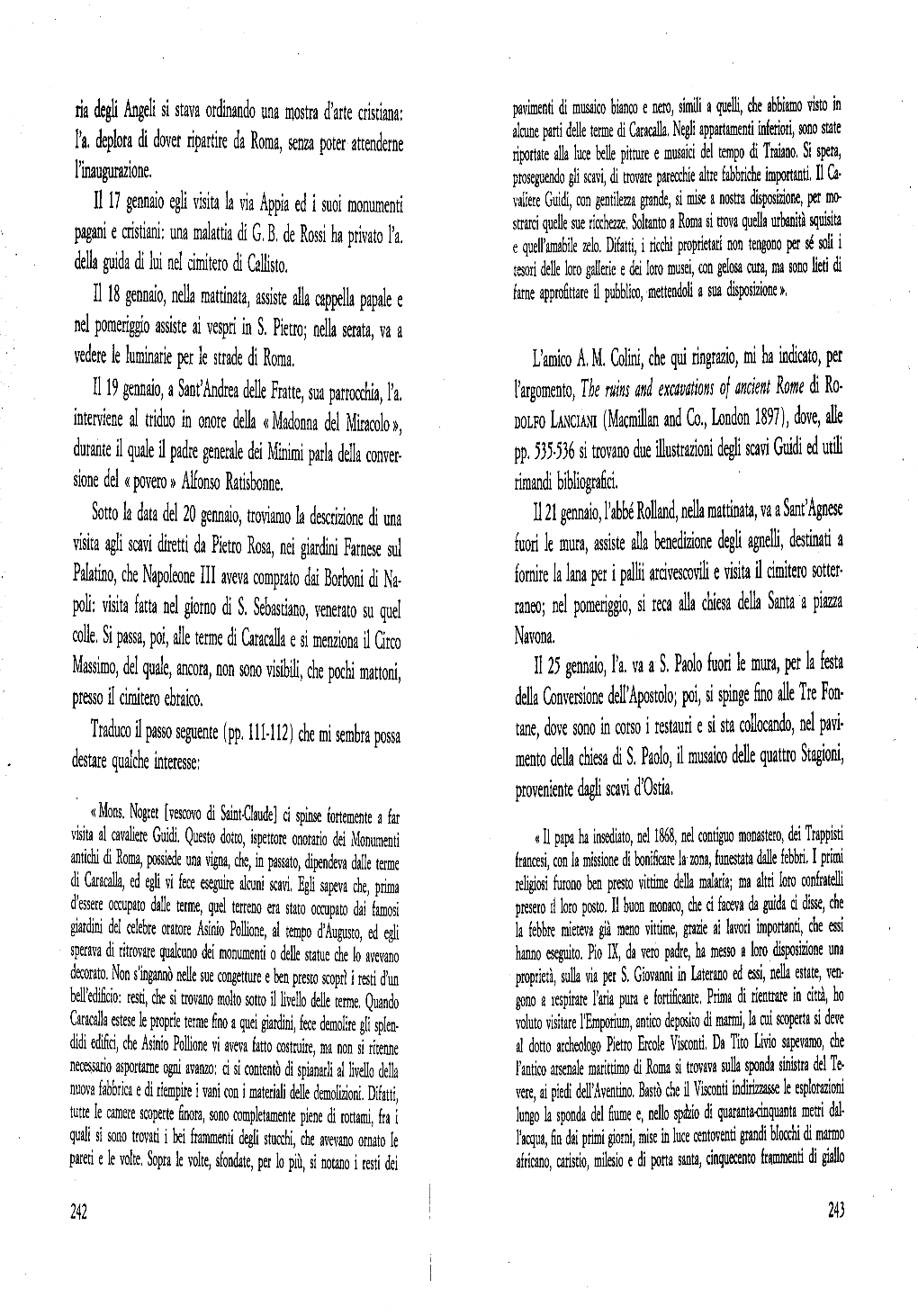
Load more
Recommended publications
-

Scarica Il Pdf Gratuito Del Volume
CARTE SCOPERTE collana dell’Archivio Storico Capitolino 2 Direzione della collana Mariarosaria Senofonte, Laura Francescangeli, Vincenzo Frustaci, Patrizia Gori, Elisabetta Mori Consulenti scientifici Mario Bevilacqua, Marina D’Amelia, Marco De Nicolò, Anna Esposito, Francesco Giovanetti, Simona Lunadei, Paola Pavan, Maria Grazia Pastura, Carlo Maria Travaglini Segreteria di redazione Maria Teresa De Nigris e-mail: [email protected] Laura Francescangeli Politiche culturali e conservazione del patrimonio storico-artistico a Roma dopo l’Unità Il Titolo 12 “Monumenti Scavi Antichità Musei” 1871-1920 viella © 2014 Viella s.r.l. – Archivio Storico Capitolino Tutti i diritti riservati Prima edizione: giugno 2014 ISBN (carta) 978-88-6728-061-2 ISBN (e-book) 978-88-6728-251-7 Alla schedatura della serie Archivio Generale, Titolo 12 “Monumenti Scavi Antichità Musei” (1871 - 1920) hanno collaborato le dottoresse Emilia Cento, Costanza Lisi, Elena Polidori nell’ambito di un’esercitazione condotta in collaborazione con la professoressa Paola Carucci docente di Archivistica Generale presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università La Sapienza, nell’anno accademico 1993-1994. Copertina: Studio Polo 1116 viella libreria editrice via delle Alpi, 32 I-00198 ROMA tel. 06 84 17 758 fax 06 85 35 39 60 www.viella.it Indice Flavia Barca, Presentazione 7 Marco De Nicolò, Il patrimonio storico-culturale e artistico di Roma e la classe dirigente: le fonti per nuove ricerche 9 INTRODUZ I ONE 13 1. L’ Archivio Generale (1871-1922) del Comune postunitario e la serie documentaria del Titolo 12 “Monumenti Scavi Antichità Musei” 17 2. Le strutture per la tutela delle antichità e belle arti: lo Stato unitario e il Municipio di Roma Capitale 30 3. -

Giovanna Capitelli Associated Professor in Museology and History
Giovanna Capitelli Associated Professor in Museology and History of Art Criticism Dipartimento di Studi Umanistici Università degli Studi Roma Tre [email protected] Via Ostiense, 234, Roma, Italy CURRICULUM VITAE Education 2000 PhD in the History of Modern Art (70/70 cum laude), Università di Roma Tre; supervisor: Prof. Stefano Susinno. 1995 Diploma of Specialization in the History of Modern Art, Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’; supervisor: Prof. Orietta Pinelli. 1992 Laurea in the History of Modern Art (110/110 cum laude), Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’; supervisors: Prof. Silvia Danesi Squarzina and Prof. Maurizio Calvesi. 1990 Courtauld Institute (University of London), Short Term Fellow. 1986 Classical Diploma Gymnasium ‘Ugo Foscolo’, Rome (60/60). Academic Employment 2019 - Associate Professor in Museology and History of Art Criticism – Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi Umanistici. 2017- Habilitation as ‘Professore Ordinario’ in the History of Art 2012- Coordinator of the School of History of Art (laurea magistrale in storia dell’arte), Università della Calabria 2010-12 President of the School of History of Art (laurea magistrale in storia e conservazione del patrimonio artistico), Università della Calabria 2006- Associate Professor (‘Professore Associato’) in the History of Early Modern Art – Università della Calabria. 2006- Member of the steering committee of the Dottorato internazionale in studi umanistici - Università della Calabria 2002-06 Assistant Professor in the -

Presidenti Dell'accademia Di San Luca
Presidenti dell’Accademia di San Luca 1814-16 ANDREA VICI romano, architetto 1817-19 GASPARE LANDI piacentino, pittore 1820-22 FRANCESCO MASSIMILIANO LABOUREUR romano, scultore 1823-25 GIROLAMO SCACCIA romano, architetto 1826 VINCENZO CAMUCCINI romano, pittore 1827-28 ALBERTO THORVALDSEN da Copenaghen, scultore 1829 GIULIO CAMPORESE romano, architetto 1830-31 ANDREA POZZI romano, pittore 1832 ANTONIO D ’E STE veneziano, scultore 1833-36 GASPARE SALVI romano, architetto 1837 TOMMASO MINARDI faentino, pittore 1838-40 ANTONIO SOLÀ da Barcellona, scultore 1841-43 CLEMENTE FOLCHI romano, architetto 1844-46 GIOVANNI SILVAGNI romano, pittore 1847-49 GIUSEPPE DE FABRIS da Nove di Bassano, scultore 1849-53 LUIGI POLETTI modenese, architetto 1854-55 FILIPPO AGRICOLA romano, pittore 1856-59 PIETRO TENERANI romano, scultore 1860-63 ANTONIO SARTI da Budrio, architetto 1864-66 FRANCESCO PODESTI anconitano, pittore 1867-69 PIETRO TENERANI romano, scultore 1870 VIRGINIO VESPIGNANI romano, architetto 1871-73 FRANCESCO COGHETTI bergamasco, pittore 1874-75 EMILIO WOLFF da Berlino, scultore 1876-77 VIRGINIO VESPIGNANI romano, architetto 1878 NICOLA CONSONI da Ceprano, pittore 1879 IGNAZIO JACOMETTI romano, scultore 1880-82 FRANCESCO AZZURRI romano, architetto 1883 NICOLA CONSONI da Ceprano, pittore 1884-85 FRANCESCO FABJ ALTINI da Fabriano, scultore 1884-1900 S. M. U MBERTO I Presidente onorario perpetuo 1886-87 ANDREA BUSIRI VICI romano, architetto 1888-90 CESARE MARIANI romano, pittore 1891-92 SARO ZAGARI messinese, scultore 1893-95 FRANCESCO AZZURRI romano, architetto 1896-98 ROBERTO BOMPIANI romano, pittore 1899-1900 STEFANO GALLETTI da Cento, scultore 1901 S. M. VITTORIO EMANUELE III Principe perpetuo 1901-02 ENRICO GUJ romano, architetto 1903 ROBERTO BOMPIANI romano, pittore 1904-05 GIULIO MONTEVERDE da Bistagno, scultore 1906-07 CARLO TENERANI romano, architetto 1908 CESARE MACCARI senese, pittore 1909-10 GIULIO TADOLINI romano, scultore 1911-12 GIO . -

Selected Works from 18Th to 20Th Century
SELECTED WORKS From 18th to 20th CENTURY GALLERIA CARLO VIRGILIO & C0. GALLERIA CARLO VIRGILIO & Co. ARTE ANTICA MODERNA E CONTEMPORANEA Edition curated by Stefano Grandesso in collaboration with Eugenio Maria Costantini Aknowledgements Franco Barbieri, Bernardo Falconi, Massimo Negri English Translations Daniel Godfrey, Michael Sullivan Photo Credits Photographs were provided by the owners of the works, both institutions and individuals. Additional information on photograph sources follows. Arte Fotografica, Rome, pp. 4, 7, 9, 13-19, 25, 27, 29, 31, 33, 43, 45, 47, 57, 61-63, 67, 69, 71, 73, 75, 77-79, 81, 83, 85, 88 Foto Claudio Falcucci, p. 25 Foto Giusti Claudio, Lastra a Signa, p. 35 Giulio Archinà per StudioPrimoPiano, p. 23 Paolo e Federico Manusardi, Milano, pp. 39, 41 The editor will be pleased to honor any outstanding royalties concerning the use of photographic images that it has so far not been possible to ascertain. ISBN 978-88-942099-4-5 © Edizioni del Borghetto Tel. + 39 06 6871093 - Fax +39 06 68130028 e-mail: [email protected] http//www.carlovirgilio.it SELECTED WORKS From 18th to 20th CENTURY Catalogue entries Adriano Amendola, Manuel Carrera, Eugenio Maria Costantini, Federica Giacomini, Cristiano Giometti, Stefano Grandesso, Silvia Massari, Fernando Mazzocca, Hermann Mildenberger, Giuseppe Porzio, Serenella Rolfi Ožvald, Valeria Rotili, Annalisa Scarpa, Ilaria Sgarbozza, Ettore Spalletti, Nicola Spinosa TEFAF Maastricht March 16–24, 2019 e GALLERIA CARLO VIRGILIO & Co. ARTE ANTICA MODERNA E CONTEMPORANEA ISBN 978-88-942099-4-5 Via della Lupa, 10 - 00186 Roma 59 Jermyn Street, Flat 5 - London SW1Y 6LX Tel. +39 06 6871093 [email protected] - [email protected] www.carlovirgilio.it Detail of cat. -

«La Città Più Ornata Di Tutto Il Mondo»
Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca interateneo Ca' Foscari-IUAV-Verona in Storia delle Arti Ciclo XXVIII Anno di discussione 2016 «LA CITTÀ PIÙ ORNATA DI TUTTO IL MONDO». FACCIATE DECORATE A ROMA FRA XV E XVI SECOLO SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI AFFERENZA: L-ART/02 Tesi di Dottorato di: Arianna Farina, matricola 831002 Coordinatore del Dottorato Tutore del Dottorando Prof. Giuseppe Barbieri Prof. Giuseppe Barbieri Indice INTRODUZIONE………………………………………………………………1 1. STATUS QUAESTIONIS, UN BILANCIO RAGIONATO………………………….8 2. IL RAPPORTO TRA DECORAZIONE E SVILUPPO URBANO NELLA PRIMA ETÀ MODERNA………………………………………………..45 2.1. Renovatio urbis Romae e facciate dipinte 2.2. Il graffito e l’edilizia minore. Nuova committenza e iniziativa privata. 3. PER UNA RICOGNIZIONE DELLA ROMA PICTA…………………………….83 3.1. Problemi metodologici 3.2. Un inventario topografico 3.2.1 Borgo 3.2.2. Ponte, Parione, Regola, Sant’Eustachio: il quartiere del Rinascimento nelle sue strade principali 3.2.3. Campo Marzio. Il momento di Leone X 3.3. Conclusioni 4. DECORAZIONE PITTORICA E GUSTO ANTIQUARIO………………………122 4.1. Dai testi ai bassorilievi antichi. Le citazioni su facciata 4.2. Il caso di via della Maschera d’Oro, 9 5. LE DECLINAZIONI ROMANE DI UN GENERE E IL RUOLO DEI GRANDI ARTISTI……………………………………………………………………150 5.1. Dalla Loggia vaticana alla decorazione della città: la scuola di Raffaello alle prese con i prospetti urbani 5.2. La mediazione di Peruzzi e l’affermazione del chiaroscuro 5.3. Facciate come quinte: la relazione con gli apparati effimeri per feste e rappresentazioni teatrali 5.4. La conclusione di una stagione del gusto 6. -

2013 Parte 1 Pp. 1-337
FONDAZIONE• ROMA ARTE-MUSEI STRENNA ·DEI ROMANISTI NATALE DI ROMA 2013 ab U. c. MMDCCLXVI APOLLONI - ARRIGHJfBORGHESE - BARI - BARTOLONI - BATTAFARANO - BENOCCI BERRI - BIANCINI - BONADONNA Russo - BORGHETTI - BURKHART - CARRANNANTE CARRO - CELLA - CERESA - CIAMPAGLIA - COLESANTI - CORRADO/SAN MARTINO CR!ELESI - DAINOTTO - DELLA SETA - DI CASTRO - DIGILIO!BIGNAMI - DOMACAVALLI FRAPISELLI - GIGLIIMARCHETTIISIMONETTA - GRJONI - GUERRIERJ BORSOI HARTMANNIPARMA - LALLI - LODOLINI - LOTTI - MAMMUCARJ MONCADA DI PATERNÒ - ONORATI - PANELLA - PANFILI - PASQUINI - PIERGUIDI QUINTA VALLE - RANDOLFI - ROTELLA - SICARJ - STACCIOLI - TAMBLÉ -TOSCANI - VIAN MATUltlSNISlll.JS In copertina: FRANCESCO ZuccARELLI, Fuga in Egitto, olio su tela, cm 78,5xl25,5, 1750 ca. (O' """"°' Collezione Fondazione Roma, inv. n. 490. lOMA1980 """'' ROMA AMOR LA STRENNA DEI ROMANISTI DAL 1940 SU WWW.UNICUSANO . IT Comitato dei curatori: LAURA BIANCINI MARIA TERESA BoNADONNA Russo TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI PAOLA PAVAN LAURA GIGLI ELIA MARCACCI ANTONIO MARTIN! FRANCO ONORATI FRANCESCO PICCOLO _y~ {;--<~,f Cd;;f<W~H6· Finalini GEMMA HARTMANN Coordinamento e impaginazione: AMEDEO INNOCENTI GIUSEPPE SCIROCCO MMDCCLXVI AB VRBE CONDITA Consulenza editoriale: ANDREA MARINI Si ringraziano: La Fondazione Roma-Arte-Musei e la Fondazione Sorgente Group per aver sostenuto l'edizione 2013. GRUPPO DEI ROMANISTI www.gruppodeiromanisti.it [email protected] © ROMAAMOR FONDAZIONE TEL. 06 32 34 375 [email protected] SORGENTE GROUP www.unicusano.it «J:S-titLtziMwF /'Arto ok (/a/Lara www.fondazionesorgentegroup.com Street Art a Roma LETIZIA APOLLONI Diceva bene Plinio il Vecchio riferendosi ad Apelle, pittore diligente della Grecia antica che si esercitava quotidianamente: nulla dies sine linea. E senza soluzione di continuità, dal tem po dell'arte rupestre ad oggi l'uomo ha tracciato le sue linee lasciando sempre il segno - o il disegno- della sua presenza nei luoghi da lui abitati. -

Universidade Federal Do Pará Faculdade De História Programa De Pós-Graduação Em História Social Da Amazônia
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ FACULDADE DE HISTÓRIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA SOCIAL DA AMAZÔNIA SILVIO FERREIRA RODRIGUES TODOS OS CAMINHOS PARTEM DE ROMA: ARTE ITALIANA E ROMANIZAÇÃO ENTRE O IMPÉRIO E A REPÚBLICA EM BELÉM DO PARÁ (1867-1892) Belém-PA, 2015 2 SILVIO FERREIRA RODRIGUES TODOS OS CAMINHOS PARTEM DE ROMA: ARTE ITALIANA E ROMANIZAÇÃO ENTRE O IMPÉRIO E A REPÚBLICA EM BELÉM DO PARÁ (1867-1892) Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em História Social da Amazônia da Universidade Federal do Pará, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em História. Orientador: Prof. Dr. Aldrin Moura de Figueiredo Belém-PA, 2015 3 Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) Sistema de Bibliotecas da UFPA _______________________________________________ Rodrigues, Silvio Ferreira, 1974- Todos os caminhos partem de Roma: arte italiana e romanização entre o império e a república em Belém do Pará (1867-1892) / Silvio Ferreira Rodrigues. - 2015. Orientador: Aldrin Moura de Figueiredo. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Belém, 2015. 1. Decoração e ornamento das igrejas - Belém (PA). 2. Arte italiana - Influência (Literária, artística, etc.). 3. Arte sacra. 4. Igrejas - Belém (PA). 5. Belém (PA) - História. I. Título. CDD 22. ed. 747.865098115 _______________________________________________ 4 SILVIO FERREIRA RODRIGUES TODOS OS CAMINHOS PARTEM DE ROMA: ARTE ITALIANA E ROMANIZAÇÃO ENTRE O IMPÉRIO E A REPÚBLICA EM BELÉM DO PARÁ (1867-1892) BANCA EXAMINADORA ________________________________________________________ Prof. Dr. Aldrin Moura de Figueiredo (Orientador) __________________________________________________________ Prof. Dr. Fernando Arthur de Freitas Neves (PPHIST/UFPA) _________________________________________________________ Prof. -

Um Altar Romano Na Baía Do Guajará: Programa Iconológico E Reforma
Temática Livre - Artigo Original DOI – 10.5752/P.2175-5841.2016v14n43p975 Um altar romano na baía do Guajará: programa iconológico e reforma católica na Catedral da Sé de Belém do Pará (1867-1892) A Roman altar in the bay of Guajará: An iconological programme and Catholic reform in the Cathedral of Belém do Pará (1867-1892) Aldrin Moura de Figueiredo * Silvio Ferreira Rodrigues** Resumo Este artigo analisa o papel da arte sacra e religiosa na Amazônia no contexto do movimento de renovação do catolicismo brasileiro no século XIX, conhecido como reforma católica Para isso, toma, como objeto de análise, a encomenda do altar mor de Nossa Senhora de Belém pelo bispo do Pará D. Antônio de Macedo Costa (1830-1891) para o escultor e arquiteto italiano Luca Carimini (1830-1890). Essa obra, juntamente com outras realizadas no mesmo período do pontificado de Pio IX, perfaz um programa iconológico e um corpus narrativo de fundo artístico e sagrado, que são testemunhos da pedagogia e dos debates políticos na história do catolicismo romano e brasileiro do século XIX. Além disso, movimenta artistas que atuaram sob o mecenato do papa Pio IX para cidades latino- americanas como Santiago, no Chile, e Belém do Pará, no Brasil, evidenciando conexões artísticas, intelectuais e religiosas entre o Vaticano e a América do Sul, como parte do movimento internacional de renovação do catolicismo. Palavras-chave: D. Macedo Costa, Luca Carimini, Arte italiana, Programa iconológico e Reforma católica. Abstract This article analyses the role of sacred and religious art in Amazonia in the context of the catholic renovation movement of the 19th century, known as Catholic Reform. -

6 - Arte Dell’Ottocento - Italia/Francia
6 - ARTE DELL’OTTOCENTO - ITALIA/FRANCIA Faldone CLXXVIII. OTTOCENTO ITALIANO CLXXVIII,1 E. Cecchi, Giovanni Fattori e la pittura toscana nel 1860, in “Il Convegno. Rivista di letteratura e di Arte”, a. VI, n. 8, 30 agosto 1925, pp. 377-386. CLXXVIII,2 D. Martelli, Al Prof. Pietro Sbarbaro, Pisa, 1869. CLXXVIII,3 F. Russoli, Appunti sui macchiaioli, estratto dalla Rivista “Arti figurative”, n. 3-4, 1946 (con dedica dell’A.). CLXXVIII,4 G. Saviotti, I “Macchiaioli” e il rinnovamento dell’arte nell’Ottocento, estratto dalle “Pagine critiche”, a. III, fasc. 4, dicembre 1922. CLXXVIII,5 Fascicolo "Per la raccolta di diapositive" al cui interno appunti manoscritti. CLXXVIII,6 B. Becca, Pittori italiani dell’Ottocento. Giuseppe De Nittis, estratto da “Il Quindicinale”, a. I, n. 4, 1 marzo 1926. CLXXVIII,7 R. Giolli, Pittori italiani del Risorgimento. Daniele Ranzoni a Venezia, estratto da “Il Quindicinale”, a. I, n. 6, 31 marzo 1926. CLXXVIII,8 E. Cecchi, Pittori italiani dell’Ottocento. Antonio Puccinelli, in “Il Quindicinale”, a. I, n. 11-12, 15 giugno-15 luglio 1926 (doppia copia). CLXXVIII,9 B. Becca, L’arte italiana dell’Ottocento. Una mostra di pittori macchiaioli a Milano, estratto da “Il Quindicinale”, a. I, n. 1, 15 gennaio 1926. CLXXVIII,10 Fascicolo "Canova" al cui interno: estratto di giornale A. Margotti, Cincinnato Baruzzi allievo del Canova, in “L’Avvenire d’Italia”, 17 marzo 1950 e n. 45 foto-cartoline di dipinti e sculture di artisti dell’Ottocento. CLXXVIII,11 L. Bosisio, Luigi Cavenaghi pittore nella luce del primo centenario della nascita, 1944. CLXXVIII,12 T. -
Meirelles, Zeferino, Bernardelli E Outros Mais: a Trajetória Dos Pensionistas Da Academia Imperial Em Roma
Meirelles, Zeferino, Bernardelli e outros mais: a trajetória dos pensionistas da Academia Imperial em Roma Meirelles, Zeferino, Bernardelli and others: the trajectory of the pensioners of the Imperial Academy in Rome CAMILA DAZZI Doutoranda em Teoria da Arte pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Mestre em História da Arte pelo IFCH/UNICAMP. Professora substituta do Instituto de Artes da UERJ. Coordenadora do projeto-site DezenoveVinte – Arte Brasileira PhD student in History and Art Theory at the School of Fine Arts/UFRJ. MA in Art History/IFCH/UNICAMP. Assistant professor in the department of Art History/UERJ. Coordinator of the web-site DezenoveVinte – Brazilian Art of the 19th Century RESUMO Questionando a concepção da França como detentora máxima da Modernidade no século XIX, o presente artigo procura demonstrar, com base na recente fortuna crítica sobre o período, que tal teoria é historicamente construída. O texto busca, ainda, apresentar como se deu a trajetória artística dos pintores e escultores brasileiros que optaram por Roma como sede de seus estudos. Em que instituições estudaram? A que movimentos artísticos se filiaram? Que acesso tiveram à produção histórica de arte? São essas algumas das per- guntas que buscamos responder, com o intuito de compreender os componentes que dão materialidade específica às suas produções. PALAVRAS-CHAVE Academia Imperial de Belas Artes, ensino artístico, arte italiana. ABSTRACT The present article deals with the conception of France as a maximum source of Modernity in the Nineteenth Century, trying to demonstrate that it is historically constructed. The text also aims a better understanding of the artistic trajectory of Brazilian painters and sculptors who complemented their studies in Rome. -
Pietro Gagliardi Trionfo Della Chiesa Militante, Maria Madre Del Redentore, Profeti, Storie Dell’Antico Testamento, Episodi Della Passione Di Cristo
1835 -1847 VILLA TORLONIA CASINO NOBILE Giovan Battista Carretti Decorazioni a grottesca e in stile eclettico, figure panneggiate e tromp l’oeil (attualmente coperti), fregi con stucchi bianchi e dorati a tema marino e mitologico, le Ore del Giorno Pietro Paoletti Amori divini a tema acquatico ed erotico, Dante guidato da Virgilio, Storie di Psiche, Ritratti di artisti e poeti, episodi tratti dalla Gerusalemme Liberata Francesco Coghetti Il Parnaso, Storie di Alessandro, figure allegoriche Leonardo Messabò, Domenico Tojetti Storie di Amore Decio Trabalza Aurora Francesco Podesti Storie di Bacco, le Stagioni, i Continenti Luigi Cochetti Toletta di Venere, Giudizio di Paride Luigi Fioroni Storie di Cleopatra, i Fiumi Bertel Thorvaldsen Il Trionfo di Alessandro (bassorilievo) Carlo Seni Mosaici pavimentali con figure mitologiche e allegoriche F. Coghetti, Sala di Alessandro - Particolare della volta con Alessandro F. Coghetti, Sala da Ballo - Il Parnaso, L. Massabò, D. Tojetti, deriso da Clito nel banchetto, Il medico Filippo legge la lettera Storie di Amore, particolare della volta di Parmenione, Alessandro e la famiglia di Dario G.B. Carretti - Particolare della decorazione della B. Thorvaldsen, Sala di Alessandro - Il trionfo di Alessandro (fregio in marmo) volta del Bagno 1835 -1840 CASINO DEI PRINCIPI Giovan Battista Carretti Tromp l’oeil con vedute del Golfo di Napoli 1841-1874 TEATRO Giovan Battista Carretti Decorazioni all’antica con stemmi delle famiglie Torlonia e Colonna Costantino Brumidi Episodi tratti dall’Iliade, la Stagioni, trompe l’oeil, decorazioni in stile eclettico Artista sconosciuto Apollo e le Dodici Ore, lo Zodiaco, la Fama e uomini illustri con stemma Torlonia 1894 -1897 CHIESA DEL SACRO CUORE DEL SUFFRAGIO Giovan Battista Conti Pala di S. -

Studies of a Reclining Female Nude Black Chalk, Heightened with White Chalk, on Deep Blue Paper
Cesare MARIANI (Rome 1826 - Rome 1901) Studies of a Reclining Female Nude Black chalk, heightened with white chalk, on deep blue paper. Signed Cesare Mariani at the lower right centre. 328 x 435 mm. (12 7/8 x 17 1/8 in.) The present sheet, perhaps a study for a figure in an allegorical painting or fresco, provides a fine example of Cesare Mariani’s gifts as a draughtsman. As has been noted of this large drawing, ‘These Rubensian academic studies of a reclining female nude display a baroque lushness and an attention to light which Mariani derived from his teacher, [Tomasso] Minardi. Mariani has studied the model from three different angles, adding a detailed study of her feet and, at the left of the sheet, a partial outline of her hands. The several areas of pentimenti suggest that the artist quickly sketched the poses and then reworked the contours in a more complete manner. Mariani concentrated on the more highly finished figure of the model at the bottom of the page.’ Mariani seems to have favoured blue paper for his studies from life. A stylistically comparable sheet of studies of hands and feet, also drawn on blue paper, was in a private Florentine collection and appeared at auction in Italy in 2014. The present sheet has also been likened, in stylistic terms, to three similarly large-scale drawings of allegorical female figures, datable to around 1885 and perhaps intended for the decoration of a theatre, which are part of a group of 244 drawings, oil sketches and paintings by Mariani acquired by the Museo di Roma in 1966.