Le Stragi E Lo Stato. Narrazioni Su
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
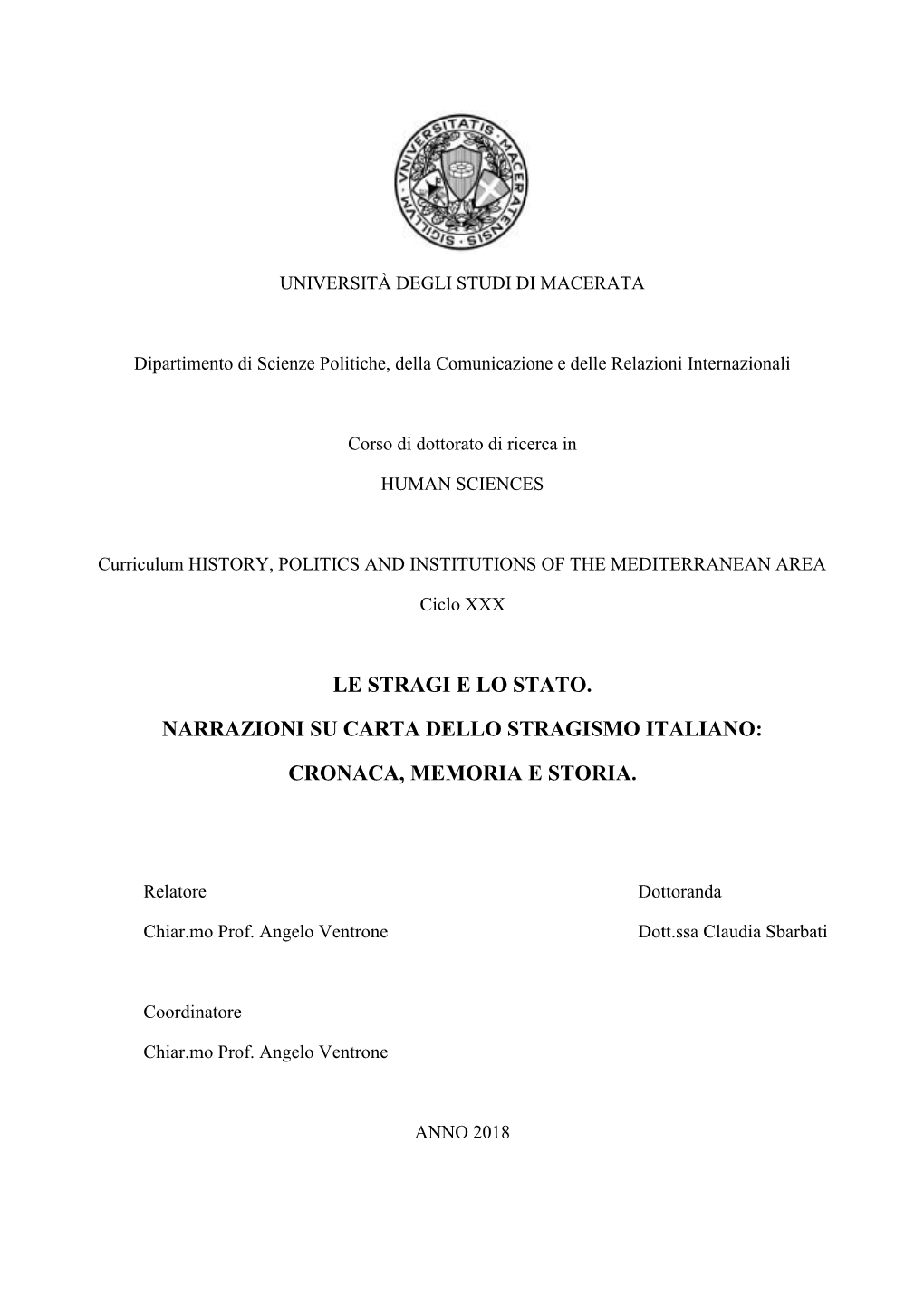
Load more
Recommended publications
-

Università Degli Studi Della Tuscia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali - DISBEC Corso di Dottorato di Ricerca in STORIA D’EUROPA: SOCIETÀ, POLITICA, ISTITUZIONI, XIX-XX SECOLO – XXV Ciclo I 55 GIORNI DEL CASO MORO: L’EVENTO MEDIATICO NELLA RICOSTRUZIONE STORICA S.s.d. SPS / 08 Tesi di dottorato di Dott.ssa Ilenia Imperi Coordinatore del corso Tutor Prof.ssa Gabriella Ciampi Prof. Giovanni Fiorentino Viterbo, 17 giugno 2013 A Matilde che ha condiviso con questa tesi la sua gestazione e i suoi primi mesi diI 55vita, GIORNI accompagnandomi DEL CASO dolcemente MORO: nelle lunghe nottateL’EVENTO di studio e diMEDIATICO scrittura. NELLA RICOSTRUZIONE STORICA A Martina che in questi anni mi ha costantemente fatto dono di spazio e tempo, cedendomi spesso parte del suo spazio e tantissimo del nostro tempo. A Marco Perché senza il suo sostegno questo lavoro e tutto il mio percorso di ricerca non avrebbero neanche avuto inizio. Perché senza di lui niente sarebbe stato possibile. 2 INDICE Ringraziamenti ………………………………….………………………………………….5 Introduzione ……………………………………………………………………………...7 Capitolo I Alcune premesse …………………………………………………………. 19 1.1 14 aprile 1975: la legge di riforma della Rai …………………………………..…19 1.2 19 febbraio 1978: l’intervista di McLuhan ……………………………………….28 1.3 28 febbraio 1978: l’ultimo discorso di Moro ……………………………………..36 Capitolo II 16 marzo 1978: via Fani. CRONOLOGIA: 17 MARZO – 17 APRILE 1978 ………………………..……….. .53 2.1 Giovedì, 16 marzo 1978: via Fani ………………………………………………..53 2.2 Cronologia: 17 marzo – 17 aprile 1978 …………………………………………..67 -

The History and Memory of 1968 in Italy by Rosaria Carbotti a Dissertation Submitted in Partial Satisfa
Of Ghosts and Survivors: The History and Memory of 1968 in Italy By Rosaria Carbotti A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Italian Studies and the Designated Emphasis in Critical Theory and the Designated Emphasis in Film Studies in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Barbara Spackman, Chair Professor Mia Fuller Professor Linda Williams Fall 2015 Abstract Of Ghosts and Survivors: The History and Memory of 1968 in Italy by Rosaria Carbotti Doctor of Philosophy in Italian Studies and the Designated Emphasis in Critical Theory and the Designated Emphasis in Film Studies University of California, Berkeley Professor Barbara Spackman, Chair The year 1968 saw the rise of a manifold protest movement among Italian university students that evolved well into the late 1970s and spread to all segments of society. Today, the memory of this collective experience represents one of the most haunting episodes of the 20th century. Torn between celebrating national events and giving in to cultural amnesia, the Italian cultural discourse around ’68 appears deliberately opaque. In recent historiography, fiction, and film this momentous year appears to be condensed in a puzzle of contrasting snapshots that do not fit well together. On one hand, it is remembered as a watershed event that altered the course of the nation’s history and the lives of individuals in radical ways. On the other hand, many ’68 storytellers mourn the complete erasure of their experience from contemporary culture and criticize the moral wasteland that is associated with the current political arena when contrasted with the vanished hopes of the past. -

CONSTRUCTING a COLLECTIVE MEMORY of ALDO MORO in ITALIAN CINEMA Katherine Greenburg Gilliom a Dissertation
SEARCHING FOR TRUTH: CONSTRUCTING A COLLECTIVE MEMORY OF ALDO MORO IN ITALIAN CINEMA Katherine Greenburg Gilliom A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Studies Chapel Hill 2016 Approved by: Marisa Escolar Federico Luisetti Samuel Amago Ennio Rao Amy Chambless © 2016 Katherine Greenburg Gilliom ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Katherine Greenburg Gilliom: Searching for Truth: Constructing a Collective Memory of Aldo Moro in Italian Cinema (Under the Direction of Marisa Escolar) This dissertation will address Aldo Moro’s presence in film and the changing manifestations of the politician in film throughout the years. I will argue that through film a comprehensive collective memory can be formed from examining what is known of the statesman, before and after his death, helping to ease the continuing sense of guilt felt by the Italian people in regards to his tragic end. In the first chapter of my dissertation I will discuss the concept of martyrdom in two films that depict Aldo Moro before his death; Elio Petri’s Todo Modo (1976) and Marco Tulio Giordana’s Romanzo di una strage (2012). Although two totally different films, historically and stylistically, both films portray a devoutly Catholic Moro and a rhetoric dealing with political martyrdom. In the second chapter of my dissertation I will address the conspiracy theories surrounding Aldo Moro’s death depicted in the films Il caso Moro (Ferrara 1986) and Piazza delle cinque lune (Martinelli 2003). Both films present their retellings of the Moro affair as revelations of the truth, focusing on the possible involvement of the Italian government, as well as the United States, in Moro’s death. -

ARMI in PUGNO 22 7 10 2-09-2010 11:53 Pagina 1
ARMI IN PUGNO 22_7_10 2-09-2010 11:53 Pagina 1 ARMI IN PUGNO di PINO CASAMASSIMA ARMI IN PUGNO 22_7_10 2-09-2010 11:53 Pagina 2 PINO CASAMASSIMA giornalista e scrittore di lungo corso, collabora con la trasmissione “La storia siamo noi” di Giovanni Minoli. Autore teatrale, è stato opinionista del network statunitense CBS e consulente per Rizzoli. Nella sua bibliografia compare una ventina di titoli, tra cui Il libro nero delle Brigate Rosse (Newton&Compton), 68, l’anno che ritorna con Franco Piperno (Rizzoli) e Il sangue dei rossi. Morire di politica negli anni Settanta (Cairo). Ha inoltre curato Il dizionario della musica leggera (Le Lettere). © 2010 Pino Casamassima © 2010 Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri Questo libro è rilasciato con licenza Creative Commons-Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Ita- lia. Il testo integrale della licenza è disponibile all’indirizzo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/. L’autore e l’editore inoltre riconoscono il principio della gratuità del prestito bibliotecario e sono contrari a norme o direttive che, monetizzando tale servizio, limitino l’accesso alla cultura. Dunque l’autore e l’editore rinunciano a ri- scuotere eventuali introiti derivanti dal prestito bibliotecario di quest’opera. Per maggiori informazioni, si consulti il sito «Non Pago di Leggere», campagna europea contro il prestito a pagamento in biblioteca <http://www.nopa- go.org/>. ARMI IN PUGNO 22_7_10 2-09-2010 11:53 Pagina 3 INTRODUZIONE La fame, la miseria, l’indigenza: altro che Nord Est dei tanti miracoli. Per decenni i veneti hanno dovuto lasciare le loro terre e raggiungere il Nuovo Mondo: quell’America che accoglieva anche lombardi e friulani, calabresi e pugliesi. -

Dal '68 Fascista Alla Strage Di Bologna: L'evoluzione Della
Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra di Teoria e Storia dei Movimenti e dei Partiti Politici DAL ’68 FASCISTA ALLA STRAGE DI BOLOGNA: L’EVOLUZIONE DELLA DESTRA VIOLENTA IN ITALIA RELATORE CANDIDATO Prof.ssa Vera Capperucci Arianna Pepponi Matr. 073472 1 A i miei genitori che mi hanno insegnato ad essere libera e forte, senza dimenticare le mie radici. Ad A. che ogni giorno sceglie di accompagnarmi lungo questo cammino. 2 INDICE INTRODUZIONE……………………………………………………………………..…..4 Capitolo I………………………………………………………………………………..…..6 I gruppi extraparlamentari di estrema destra 1.1 Ideologia e nuovi miti del neofascismo: tra ascetismo e rivoluzione...............................7 1.2 Ordine nuovo...................................................................................................................12 1.3 Fronte nazionale..............................................................................................................15 Capitolo II………………………………………………………………………………….17 L'autunno caldo tra estremismo e violenza politica 2.1 Il contesto storico e sociale....………………..................................................................18 2.2 La partecipazione dei giovani fascisti..............................................................................23 2.3 L’Msi e il recupero del ribellismo giovanile....................................................................26 Capitolo III………………………………………………………………………………….31 Lo stragismo 3.1 Il contesto storico e politico.............................................................................................31 -

L'eversione Nera Negli Anni Di Piombo: Lo Spontaneismo
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE CATTEDRA DI STORIA DELLE ISTITUZIONI IN EUROPA L’EVERSIONE NERA NEGLI ANNI DI PIOMBO: LO SPONTANEISMO ARMATO RELATORE: CORRELATORE: Chiar.mo Prof. Lorenzo Castellani Chiar.mo Prof. Alessandro Orsini CANDIDATO: Enrico Forlino ANNO ACCADEMICO 2019/2020 A mio fratello. Alla mia famiglia. 2 Indice: - Introduzione………………………………………………………………………..2 - Capitolo I - Fino agli anni di piombo I.I I blocchi ideologici……………………………………………………………….. 5 I.II L’Italia dei partiti…………………………………………………………………9 I.III Gli effetti del miracolo…………………………………………………………12 I.IV La diaspora del Movimento Sociale Italiano…………………………………...15 I.V Dai preparativi a Piazza Fontana………………………………………………..24 I.VI Tora Tora e la nuova eversione………………………………………………...30 - Capitolo II - L’albero del neofascismo II.I Ordine Nuovo……………………………………………………………………45 II.II Avanguardia Nazionale………………………………………………………...63 II.III I movimenti spontaneisti………………………………………………………77 - Capitolo III - I Nuclei Armati Rivoluzionari III.I L’avvento dello spontaneismo …………………………………………………81 III.II L’assalto al cielo……………………………………………………………….87 III.III Lo spirito di vendetta…………………………………………………………94 III.IV L’ideologia ………………………………………………………………….103 3 - Capitolo IV - La risposta delle istituzioni IV.I Le forze in gioco e le problematiche………………………………………….108 IV.II La normativa anti-terrorismo………………………………………………...112 Conclusione…………………………………………………………………...…...116 Bibliografia..………………………………………………………………...…….122 4 Introduzione Lo scopo del presente lavoro è quello di ricostruire i punti chiave -

Literary Modes of Representation in Dino Buzzati's Journalism
1 Royal Holloway, University of London School of Modern Languages, Literatures and Cultures Italian ‘Fantastic News’: Literary Modes of Representation in Dino Buzzati’s Journalism by Francesco Schiavon Supervisor: Dr. Fabrizio De Donno Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Royal Holloway, University of London 2013 2 Declaration I Francesco Schiavon hereby declare that this thesis and the work presented in it is entirely my own. Where I have consulted the work of others, this is always clearly stated. Francesco Schiavon 27.4.2013 3 To Melania and Concetta, equally beautiful creatures 4 Abstract My main purpose is to investigate the characteristics of the merging of the literary mode of the fantastic and journalism that constitutes the most original element within Buzzati’s non-fictional production. I intend to analyze the modes of representation that his journalism borrowed from fiction in order to demonstrate that Buzzati’s journalism forces us to challenge our idea of objectivity and that the fictional element of representation which characterizes his articles provides a further option to investigate the ambivalence of the real. In order to understand Buzzati’s contribution to the creation of this new hybrid prose that I will define ‘fantastic news’ I intend to focus on the cultural role of Buzzati’s journalistic production, his relationship with his historical, cultural and social time, and the readership effected by Buzzati’s distinctive narrative between the 1940s and 1970s. I will ground my discussion on journalistic and literary theory, by taking in particular consideration those works which deal with the fantastic and the relationship between journalism and fiction. -

MAFIA CAPITALE. ANATOMIA DEI PROTAGONISTI1 Martina Mazzeo
La ricerca 1 MAFIA CAPITALE. ANATOMIA DEI PROTAGONISTI1 Martina Mazzeo Ricostruire le storie dei principali protagonisti di Mafia Capitale e focalizzarne gli intrecci può probabilmente aiutare ad arricchire la conoscenza dello scenario criminale e del sistema di potere messi in luce dall’Operazione Mondo di Mezzo.2 A partire dalla Banda della Magliana, è infatti possibile individuare lo sviluppo a Roma di una storia criminale in cui si affollano, si ripropongono e si rigenerano in modo ininterrotto ambienti, attori e metodi, talora corruttivi, talora mafiosi, spesso efficacemente miscelati, e riconoscere la presenza retrostante di un humus in grado di riprodursi con continuità. Pertanto, proprio cercando di cogliere gli elementi di questa continuità, si proporrà un’analisi di Mafia Capitale che cerchi di catturare le diverse soggettività e di comprendere l’orientamento all’azione dei vari protagonisti. Per meglio soddisfare tale obiettivo, si considereranno separatamente due sistemi d’azione, quello criminale e quello imprenditoriale, tra loro comunicanti. Come anticipato da Nando dalla Chiesa,3 il network denominato Mafia Capitale si articola in una composita serie di attori, individuali e collettivi, operanti sul territorio di Roma Capitale, entro i confini del Grande Raccordo Anulare e nel contesto di Ostia (X Municipio). Sul piano degli attori individuali, spiccano le figure di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi: il rapporto che intercorre tra i due rappresenta “il centro del centro” su cui si regge la complessa organizzazione di Mafia Capitale. Bisogna poi considerare l’intervento di una quota di “popolazione influente”: non solo criminali in senso proprio, quindi, ma anche personale politico, 1 Come è ovvio, tutte le persone indagate qui citate sono da considerare non colpevoli sino a sentenza definitiva. -
Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari) Dirigenti: Giuseppe Valerio (Detto
Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari) Dirigenti: Giuseppe Valerio (detto "Giusva") Fioravanti, Dario Pedretti, Cristiano Fioravanti, Alessandro Alibrandi, Francesca Mambro. Pubblicazione: gli unici documenti prodotti sono i volantini di rivendicazione. La tradizionale preminenza dell'azione sul pensiero tipico della tradizione fascista, trovò in questa organizzazione, la sua applicazione estrema, negli anni che vanno dal 1978 al 1981. La relazione della Commissione Stragi spiega infatti come "la sigla Nuclei Armati Rivoluzionari, sottenda una realtà di non facile comprensione e si inserisca in un orizzonte volutamente mutabile e in movimento. Tale sigla infatti venne dapprincipio utilizzata dal gruppo formato dai fratelli Fioravanti, Alessandro Alibrandi e Franco Anselmi che si era andato strutturando in un processo di aggregazione per gruppi operanti nei quartieri e attivi in pestaggi e scontri fisici con oppositori politici, ma che già dal suo nascere non intendeva caratterizzarsi come una specifica formazione politica, quanto piuttosto mettere a disposizione di tutta l'area della destra una sorta di parola d'ordine con cui attestare, attraverso i fatti, la condivisione del progetto complessivo. Come si vede l'idea coincide con le quasi contemporanee prese di posizione di Costruiamo l'azione, e la convinzione radicata in Fioravanti e negli altri a lui vicini della superfluità delle parole e della forza rivoluzionaria dell'esempio. Valerio Fioravanti spiegherà il significato della sigla in questi termini: "la sigla N.A.R. è stata usata da molti anni, inizialmente per semplici attentati di danneggiamento, e stava ad indicare soltanto la matrice fascista. Tale sigla peraltro non si riferisce ad una organizzazione stabile e strutturata; bensì soltanto alla matrice degli attentati. -

I Terroristi Della Porta Accanto… Storia Del Terrorismo Nero…
ATTENTI A QUEI DUE Ottobre 2020 I terroristi della porta accanto… Storia del terrorismo nero… Di Raffaele Vacca attualita.it (direttore Salvatore Veltri) I terroristi della porta accanto - copertina Piero Corsini, in Rai dal 1986, collaboratore di Giovanni Minoli è l’ autore di «I terroristi della porta accanto», un interessante libro-inchiesta, Newton Compton editore, pubblicato il 9 luglio scorso; un libro, frutto di anni di lavoro e d’indagine psicologica oltre che giornalistica, con le ultime notizie su uno dei grandi misteri d’Italia, la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Si racconta la vicenda di Fioravanti e Mambro, che furono risucchiati dalla follia di un’epoca e da una concezione violenta e perversa della politica. È la storia del terrorismo nero conosciuto come «spontaneismo armato», uno squarcio di un’epoca difficilissima e travagliata, la follia di lunghi anni difficilissimi e travagliati con una concezione violenta e perversa della politica. Francesca Mambro e Valerio Fioranti sono stati condannati all’ergastolo per la strage di Bologna. Loro hanno ammesso molti altri crimini, ma hanno sempre respinto questa accusa e continuano a dirsi innocenti. È stato un processo basato su indizi che non ha retto al dibattimento. Anche per Francesca Mambro e Giusva Fioravanti, da anni liberi, come per gli altri detenuti, “la libertà condizionale è un vero e proprio diritto e non una concessione né una non giustificabile rinuncia dello Stato all’ulteriore esecuzione della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna”. Sono le parole con cui alla Camera il Sottosegretario alla Giustizia rispose alle obiezioni di legittimità di Paolo Bolognesi, Presidente dell’ “Associazione vittime del due Agosto”.Per la libertà condizionale, dopo la condanna all’ergastolo, bisogna aver scontato almeno 26 anni della pena inflitta e avere avuto un comportamento che faccia “ritenere sicuro” il ravvedimento. -

Cronologia Europea
Cronologia Europea Questa cronologia vorrebbe essere una prima base per chi intenda studiare la violenza politica e/o il terrorismo europei . La cronologia non ha evidentemente la pretesa di essere esaustiva, ha delimitato il suo campo di indagine alla cosiddetta violenza politica, ovvero agli atti di violenza compiuti per motivi politici o che abbiano avuto rilevanza politica anche al di là delle intenzioni originali. In essa sono stati indicati unicamente gli attentati che hanno provocato vittime mortali. Questa cronologia è per vari motivi incompleta, molti fatti rimangono ignoti mentre altri avrebbero richiesto un lavoro molto più lungo (si pensi per esempio alle migliaia di vittime del conflitto nord-irlandese). Le notizie prelevate dalla stampa quotidiana (fonte fondamentale per un lavoro di questo tipo) sono state verificate attraverso testi specifici e alcuni preziosi e precisi siti internet (entrambi elencati nelle fonti) ma, naturalmente, alcuni fatti possono essere sfuggiti, mentre altri possono contenere inesattezze. Invitiamo, perciò, coloro che consulteranno la cronologia a segnalarci eventuali errori ed omissioni per aiutarci a rendere questo lavoro il più preciso possibile. Si è scelto di partire dal 1969 perché è l’anno in cui in Italia prende il via la strategia della tensione, in Irlanda del nord si moltiplicano i Riots (le rivolte di piazza) e un po’ in tutta Europa incominciano a moltiplicarsi gli atti di violenza politica. Il lavoro termina nel 1989 perché il crollo del muro di Berlino cambia completamente lo scenario di questa ricerca. Da questa cronologia è nata la pubblicazione di Massimiliano Boschi, La violenza politica in Europa, 1969-1989, Modena, Yema, 2005 Massimiliano Boschi 1969 1969 19/1 Cecoslovacchia Lo studente di filosofia Jan Palach si da fuoco in Piazza 19/1 Czechoslovakia. -
1 \ Set. 2016 1
All'Onorevole Presidente della Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. CÀMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO 1 \ SET. 2016 1. PREMESSA. ARRIVO Nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza..del.. 2.9.0.6.20.16... veniva convenuto di incaricare lo scrivente a compiere un approfondimento sui rapporti tra Toni Chichiarelli e Massimo Sparti, nonché sui rapporti tra Chichiarelli e gli ambienti di Autonomia Operaia di via dei Voi sci. Al riguardo si rappresenta quanto emerso. Il G.I. dr. Monastero, nella seduta del 23.05.1995 della Commissione Stragi, riferì sulle indagini svolte riguardo all'omicidio di Toni Chichiarelli e su altre vicende criminali connesse sulle quali l'omicidio aveva consentito di fare luce. Nel ripercorrere i rapporti del soggetto, il magistrato affermava che "vi erano altri personaggi che gravitavano intorno a Chichiarelli: in particolare, penso possa interessare la Commissione, ricordo Massimo Sparti e Giacomo Comacchio. Si trattava dei due personaggi naturalmente già noti all'epoca. Particolarmente importante per il mio ufficio è stato seguire questa pista, in quanto soprattutto per Massimo Sparti vi era un significativo rapporto con i fratelli Fioravanti che - come sapete - poi sono stati indiziati per l'omicidio Pecorelli. Vi era quindi un collegamento significativo che non ha prodotto frutti, ma che appariva estremamente importante proprio per capire il tessuto sociale nel quale si muoveva questo Chichiarelli, che a sua volta apparentemente mostrava (chiaramente depistando) di essere un brigatista, quando invece tutti i brigatisti in seguito sentiti dall'ufficio, compresi Moretti, Morucci e Faranda, hanno negato qualsiasi rapporto con il soggetto in questione.