Giovanni Savonuzzi Il Designer Dei Due Mondi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
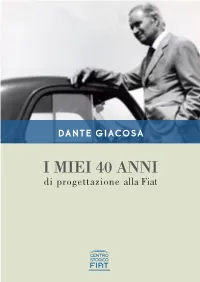
I MIEI 40 ANNI Di Progettazione Alla Fiat I Miei 40 Anni Di Progettazione Alla Fiat DANTE GIACOSA
DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat I miei 40 anni di progettazione alla Fiat DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat Editing e apparati a cura di: Angelo Tito Anselmi Progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino Due precedenti edizioni di questo volume, I miei 40 anni di progettazione alla Fiat e Progetti alla Fiat prima del computer, sono state pubblicate da Automobilia rispettivamente nel 1979 e nel 1988. Per volere della signora Mariella Zanon di Valgiurata, figlia di Dante Giacosa, questa pubblicazione ricalca fedelmente la prima edizione del 1979, anche per quanto riguarda le biografie dei protagonisti di questa storia (in cui l’unico aggiornamento è quello fornito tra parentesi quadre con la data della scomparsa laddove avve- nuta dopo il 1979). © Mariella Giacosa Zanon di Valgiurata, 1979 Ristampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. … ”Noi siamo ciò di cui ci inebriamo” dice Jerry Rubin in Do it! “In ogni caso nulla ci fa più felici che parlare di noi stessi, in bene o in male. La nostra esperienza, la nostra memoria è divenuta fonte di estasi. Ed eccomi qua, io pure” Saul Bellow, Gerusalemme andata e ritorno Desidero esprimere la mia gratitudine alle persone che mi hanno incoraggiato a scrivere questo libro della mia vita di lavoro e a quelle che con il loro aiuto ne hanno reso possibile la pubblicazione. Per la sua previdente iniziativa di prender nota di incontri e fatti significativi e conservare documenti, Wanda Vigliano Mundula che mi fu vicina come segretaria dal 1946 al 1975. -

Hitlers GP in England.Pdf
HITLER’S GRAND PRIX IN ENGLAND HITLER’S GRAND PRIX IN ENGLAND Donington 1937 and 1938 Christopher Hilton FOREWORD BY TOM WHEATCROFT Haynes Publishing Contents Introduction and acknowledgements 6 Foreword by Tom Wheatcroft 9 1. From a distance 11 2. Friends - and enemies 30 3. The master’s last win 36 4. Life - and death 72 5. Each dangerous day 90 6. Crisis 121 7. High noon 137 8. The day before yesterday 166 Notes 175 Images 191 Introduction and acknowledgements POLITICS AND SPORT are by definition incompatible, and they're combustible when mixed. The 1930s proved that: the Winter Olympics in Germany in 1936, when the President of the International Olympic Committee threatened to cancel the Games unless the anti-semitic posters were all taken down now, whatever Adolf Hitler decrees; the 1936 Summer Games in Berlin and Hitler's look of utter disgust when Jesse Owens, a negro, won the 100 metres; the World Heavyweight title fight in 1938 between Joe Louis, a negro, and Germany's Max Schmeling which carried racial undertones and overtones. The fight lasted 2 minutes 4 seconds, and in that time Louis knocked Schmeling down four times. They say that some of Schmeling's teeth were found embedded in Louis's glove... Motor racing, a dangerous but genteel activity in the 1920s and early 1930s, was touched by this, too, and touched hard. The combustible mixture produced two Grand Prix races at Donington Park, in 1937 and 1938, which were just as dramatic, just as sinister and just as full of foreboding. This is the full story of those races. -

Combined VSCC Index - Car Marques - Revised Alphabetical Sequence
Code: File 2 - Excel - Combined VSCC Index - Car Marques - Revised Alphabetical Sequence. - 28.5.20. Vintage Sports Car-Club Ltd. - Bulletin Index 1935 to 2009 Bulletin No.264 Combined Car Marques - plus Aeroplanes, Bicycles, Motorcycles, Odds and Ends. Go to the Miscellaneous Section after the Z entries Code Marque Details No.87-3-65-35 A. B. C. 1922 front & offside views JS 1478 Cameron's car No.176-4-87-69 ABC 1923 offside and front views KB 7084 Aston Clinton No.215-2-97-77 A B C offside and front view - Hakan Sandberg car No.220-3-98-77 ABC Rally 1928 leads cars through the chicane at Montlhery - Yves Millot No.71-2-61-35 A. C. Anzani two seater Peter Spreadbury No.71-2-61-38 A. C. Six front and side view Roger McDonald No.88-4-65-21 A. C. nearside view of Pollard's car at Silverstone No.116-4-72-64 AC offside view of broken con rod and crankcase No.119-3-73-16 AC front & nearside view at Shelsley Walsh, Willoughby & Mays up No.119-3-73-64 AC Nash BMX 72 and Delahaye behind, offside views No.123-3-74-26 AC front view of car with Jenks driving at Brooklands No.139-3-78-13 AC front and offside view pursues Mann's Monza Alfa No.141-1-79-13 A.C. front aerial view of BM 6678 with Hamish Moffat visible No.143-3-79-11 A.C Cognac front view out of Cascades No.154-2-82-10 AC front & offside view 373 PPG with Bowyer driving No.154-2-82-27 AC replica 200 Mile Race Car front & nearside views No.158-2-83-24 AC in the water Northern Rally 373 PPO No.169-1-86-25 AC 16/80 1935 front view with David Hescroff No.173-1-87-78 AC 16/80 DPD 40 David Hescroff rear offside view No.176-4-87-65 AC single seater, o.h.c. -

I Camion Italiani Dalle Origini Agli Anni Ottanta
I camion italiani dalle origini agli anni Ottanta AISA Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile MONOGRAFIA AISA 124 I I camion italiani dalle origini agli anni Ottanta AISA - Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile Brescia, Fondazione Negri, 19 ottobre 2019 3 Prefazione Lorenzo Boscarelli 4 I camion italiani Massimo Condolo 15 Nasce l’autocarro italiano Antonio Amadelli Didascalia MONOGRAFIA AISA 124 1 Prefazione Lorenzo Boscarelli l camion è nato pochi anni dopo l’automobile e se di rado frutto di progetti originali, ma fruitori in buo- Ine è ben presto differenziato, per soluzioni costrut- na parte di componenti – innanzitutto il motore – di tive, dimensioni e quant’altro. Potremmo chiederci origine camionistica. Un comparto particolare sono perché si ebbe quel sia pur breve “ritardo”; un motivo le macchine movimento terra, per l’iniziale sviluppo con ogni probabilità fu che per i pionieri dell’auto- dei quali tra i paesi europei un ruolo importante ha mobile era molto più attraente fornire un mezzo di avuto l’Italia. trasporto a persone, suscitando curiosità e di diverti- La varietà degli utilizzi dei camion, da veicolo com- mento, piuttosto che offrire uno strumento per il tra- patto per consegne cittadine o di prossimità a mezzo sporto di cose. Un secondo motivo fu senza dubbio la per trasporti di grande portata, da veicolo stradale a limitatissima potenza che avevano i primi motori per mezzo da cantiere, da antincendio a cisterna aeropor- automobili, a fine Ottocento, a stento in grado di por- tuale, e chi più ne ha più ne metta, ha prodotto una tare due o quattro passeggeri, di certo non un carico varietà di soluzioni tecniche e progettuali senza pari, significativo. -

Design with Va-Va-Vroom Ron Arad's Pressed Flowers Exhibition Perfectly Embodies the Extraordinary Power and Emotional Impact of Car Design
Roddy Giacosa 2013 Design with va-va-vroom Ron Arad's Pressed Flowers exhibition perfectly embodies the extraordinary power and emotional impact of car design BY HENRIETTA THOMPSON DECEMBER 12, 2013 09:00 Over the past week or so, I’ve been struck repeatedly by the fact that cars have an extraordinary power to move people. It’s the emotional impact of a car that I’m talking about, not its physical one. A car with a strong enough brand, and a clever enough designer behind the wheel, can take a person to places that horsepower alone can never reach. Thompson, Henrietta. “Design with va-va-vroom”, Telegraph. December 12, 2013. In the beginning, there was the Aston Martin. We borrowed a Vanquish Volante in bright racing red for the weekend and were astounded as we were transformed Cinderella-style from our scruffpot selves into a sleek, sexy couple in sports mode. It sounded like a tiger, drove like a dream, and everyone we passed stopped and stared as we swooshed past. It was at once embarrassing and fabulous, a feeling that can be yours for just £200,000. The Vanquish experience made me think about design and how the feeling of a car can be extended, or not, into other products. “I want an Aston Martin office chair,” my boyfriend said at one point, a little overexcited. Also the Aston Martin desk, sofa, jacket, the coffee pot, the works. But did we really? Aston Martin doesn’t make office chairs, and hopefully it won’t ever feel the need. -

EMILIO PUGNO” CGIL Regionale Del Piemonte Camera Del Lavoro Di Torino FIOM CGIL Del Piemonte
1 ASSOCIAZIONE “EMILIO PUGNO” CGIL Regionale del Piemonte Camera del Lavoro di Torino FIOM CGIL del Piemonte Il racconto della memoria Storia della SCA a cura di Ruggero Pugno Dopo la fase decisiva di crescita degli anni ’60, il Sindacato si rinnova nei Consigli. Ma nei Consigli stessi, e, a maggior ragione, nelle strutture esterne ai luoghi di lavoro, la CGIL, e il Sindacato nella sua fase unitaria, rimane strutturalmente ambiguo. A Torino, un nucleo dirigente fondamentale attraversa queste contraddizioni mantenendo a lungo un equilibrio organizzativo e politico di forte carattere progressivo …… il cui fondamento è il potere contrattuale sui luoghi di lavoro ed una estensione dell’intervento del movimento sindacale sui temi delle riforme sociali e della programmazione economica…… su un indirizzo strategico nel quale lo sviluppo del potere contrattuale si associ, si integri con la politica delle riforme, il cui successo è legato precisamente a questa associazione e integrazione Sergio Garavini 2 Questo libro è dedicato: all’amico Michele Giannatempo, all’amico Valentino Formaggi, all’amico Franco Isnardi, ad Alessandro Tarzariol, al Signor Oddone e alla Signora Oddone Un ringraziamento a quelli che hanno contribuito e creduto alla sua realizzazione ed uno in particolare all’amico e storico Donato Antoniello 3 PREFAZIONE Il lavoro del disegnatore tecnico di carrozzeria è un’attività che nasce e si costruisce con una buona dose di perseveranza e di volontà. Deve piacere; poiché è molto selettivo ti può far stare al palo o diventare un progettista. Non esiste una laurea per il progettista di carrozzeria, esiste quella da ingegnere di meccanica, motorista, aeronautica, architettura, per cui, in carrozzeria, ti devi creare il mestiere e perfezionarlo sempre più da solo. -

Zeithaus-Automobile Klassiker Fiat Topolino
ZeitHaus Automobile Klassiker Fiat 500 Topolino – das erste italienische Volks-Automobil 1936-1955 Automobile Meilensteine sind das Thema des ZeitHauses in der Autostadt – dies ungeachtet ihrer Herkunft. ZeitHaus-Philosophie ist es, Trendsetter zu präsentieren: Automobile, die Maßstäbe definierten und anderen Herstellern als Vorbild dienten, sei es technologisch, konzeptionell, im Design oder in der Produktionsweise. Der Fiat „Topolino“ gehört zweifellos zu diesem elitären Kreis. Er leitete in Italien die Massen-Motorisierung ein – so, wie der Volkswagen Käfer in Deutschland. „Giacosa, Senator Agnelli möchte ein kleines Automobil herstellen, ein ökonomisches Modell, das für 5.000 Lire verkauft werden kann. Glaubst Du, dafür ein Chassis und einen Motor konstruieren zu können?“ – so erinnerte sich „Topolino“-Schöpfer Dante Giacosa später in seinen Memoiren an die Worte seines Vorgesetzten. Dieser Antonio Fessia hatte Mitte der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts bei Fiat das Amt des Technischen Direktors inne. Beider Arbeitgeber wiederum war Senator Giovanni Agnelli Senior, 1866 geborener Mitgründer und Präsident der Fabbrica Italiana Automobili Torino – kurz FIAT. Jungingenieur Giacosa war damals, 1933, erst 28 Jahre alt. Seit 1926 hatte er bei Fiat Flugmotoren kons- truiert und dabei gehöriges Know-how erworben – und Selbstbewusstsein. Deshalb kam seine Antwort ohne Zö- gern: „Natürlich kann ich das!“ Erst danach wurde ihm klar, was die wesentliche Vor- gabe Agnellis bedeutete: 5.000 Lire – weniger als die Hälfte, die Fiat für das bis dahin kleinste Modell, den Balilla, for- derte. Giacosa später: „Uns stand ein unvergesslicher Kraftakt bevor.“ Schnell gefunden war indessen ein Name für den Prototyp des Turiner Kleinwagens, neben dem sich Giacosa 1934 stolz von seinem Chef Fessia fotografieren ließ (siehe Foto): „Zero A“. -

Bentley Speed Six the Ultimate in Power, Luxury and Competition Pedigree
FORD MODEL T MAZDA COSMO FORD XR6 TF R47.00 incl VAT May 2017 BENTLEY SPEED SIX THE ULTIMATE IN POWER, LUXURY AND COMPETITION PEDIGREE STYLE & SUBSTANCE COMMEMORATING ENZO RENAULT’S CARAVELLE AND R8/10 FERRARI ENZO – FRENCH FLAIR THE MAN AND THE CAR DICKON DAGGITT | BMW 2002 RESTORED | DENNIS GUSCOTT PCC_Porsche Classic_210x276.qxp_Porsche 210x275 2017/04/05 11:46 AM Page 1 www.porschecapetown.com The first Porsche built boasted exceptional everyday practicality. Nothing has changed. Porsche Centre Cape Town. As a Porsche Classic Partner, our goal is the maintenance and care of historic Porsche vehicles. With expertise on site, Porsche Centre Cape Town is dedicated to ensuring your vehicle continues to be what it has always been: 100% Porsche. Our services include: • Classic Sales • Classic Body Repair • Genuine Classic Parts • Classic Service Porsche Centre Cape Town Corner Century Avenue and Summer Greens Drive, Century City Tel: 021 555 6800 CONTENTS — CARS BIKES PEOPLE AFRICA — MAY 2017 WORK & PLAY THE ROTARY CLUB 03 Editor’s point of view 64 Mazda Cosmo turns 50 CLASSIC CALENDAR DYNAMIC BEST-SELLER 06 Upcoming events for 2017 70 A modern classic – Mazda MX-5 NEWS & EVENTS PADKOS 08 All the latest from the classic scene 72 Backseat Driver – a female perspective THE MAGIC FORMULA 18 50 years of Formula Ford racing A CLASSIC RACER 74 Bike racer and tuner Dennis Guscott CARBS & COFFEE 22 All the ingredients THE FAMOUS FELINE’S FOUNDER 78 Sir William Lyons COMMEMORATING ENZO 24 Celebrating Ferrari’s 70th THE PERFECT CLASSIC with an Enzo -

The Charm of Heritage Looks to the Future
THE CHARM OF HERITAGE LOOKS TO THE FUTURE The first “real” Ferrari and the first production Lamborghini Touring Superleggera; the jewels of Lamborghini from the Miura to the Super Trofeo; the first vehicle ever built in Italy; the joy of experiencing the 1950s of the Nicolis Museum; the pink Jaguar that took over the first page of Car Life and the cutting edge models that marked turning points in the history of cars. Just a few days from the inauguration on 20 October, Auto e Moto d’Epoca in Padua reveals the marvels of the past and the common thread linking heritage to the present day. Link Foto Gallery From 20 to 23 October 2016, 4500 cars, 500 motorbikes and 1600 exhibitors will be meeting in Padua for the biggest Classic market in Europe. At Auto e Moto d’Epoca the charm of heritage is united with previews of contemporary cars based on passion that unites past and future and the continuous innovation that keeps them united. So, the show, which has become the most important in Italy - will be opening with 16 international brands, the cars that have made history and those that will do so in the future. The national previews and new products from Alfa Romeo, Abarth, Audi, Citroën, DS, Maserati, Land Rover, Jaguar, Mercedes, Pagani, Porsche, Tesla, Volkswagen and Volvo will be alongside vintage models that have marked the evolution and created the legend of each car manufacturer. Among the top pavilions are the three souls of Lamborghini’s heritage, united in a large single stand with the Lamborghini Museum, the “Polo Storico”, the Lamborghini Club Italia and an exiting panorama from the Miura to the Super Trofeo of the jewels from Sant’Agata. -

Feisty Fiats! Trofeo Racer in Action
ABARTH ● ALFA ROMEO ● FERRARI ● FIAT ● LANCIA ● MASERATI Issue 292 June 2020 £4.99 ALFASUD FEISTY FIATS! TROFEO RACER IN ACTION ALFA 6C GILCO GHIA 500 ZAGATO 131 ABARTH PININFARINA 90 years of design LOST LAMBORGHINIS I I Prototypes revealed I RALLIES & EVENTS Reports in detail FERRARI 225 S 1952 Vignale www.auto-italia.co.uk www.auto-italia.co.uk £80,000 FERRARI FF – SHOULD YOU TAKE THE PLUNGE? Alfa Romeo GTV Cup Alfa Romeo 147 V6 24V GTA 53,854 miles. One owner for the last 16 years. GTV Cup number 79. Full Just completed a major service including cambelts, service history and is completely original. Last serviced in September 2019 and water pump and brakes. 127,598 miles. had a new timing belt in September 2017. £11,995 Price: £9,490 * No 1 out of 180 Fiat, Alfa Romeo and Chrysler Jeep dealers for customer satisfaction in the UK. Oct-Dec 2018 * No 1 out of 165 Fiat, Alfa Romeo and Chrysler Jeep dealers for customer satisfaction in the UK. July-Sep 2018 * No 1 out of 165 Fiat, Alfa Romeo and Chrysler Jeep dealers for customer satisfaction in the UK. April–June 2018 * No 1 out of 165 Fiat, Alfa Romeo and Chrysler Jeep dealers for customer satisfaction in the UK. Jan-Mar 2018 WELCOME www.auto-italia.net Editor Chris Rees [email protected] Photographic Editor Michael Ward [email protected] Events Director Phil Ward [email protected] Editor at Large Peter Collins Contributors Peter Collins, Richard Heseltine, Andy Heywood, Martin Buckley, Peter Nunn, Simon Park, Steve Berry, Simon Charlesworth, Mike Rysiecki, Tim Pitt, Richard Dredge, Bryan McCarthy, and Phil Ward Art Editor Michael Ward Tel: 01462 811115 Back Issues Tel: 01462 811115 Subscriptions www.auto-italia.net [email protected] Managing Director Michael Ward General Manager Claire Prior [email protected] Advertisement Managers David Lerpiniere [email protected] Simon Hyland o here I sit, like millions of us, working from home. -

Karl E. Ludvigsen Papers, 1905-2011. Archival Collection 26
Karl E. Ludvigsen papers, 1905-2011. Archival Collection 26 Karl E. Ludvigsen papers, 1905-2011. Archival Collection 26 Miles Collier Collections Page 1 of 203 Karl E. Ludvigsen papers, 1905-2011. Archival Collection 26 Title: Karl E. Ludvigsen papers, 1905-2011. Creator: Ludvigsen, Karl E. Call Number: Archival Collection 26 Quantity: 931 cubic feet (514 flat archival boxes, 98 clamshell boxes, 29 filing cabinets, 18 record center cartons, 15 glass plate boxes, 8 oversize boxes). Abstract: The Karl E. Ludvigsen papers 1905-2011 contain his extensive research files, photographs, and prints on a wide variety of automotive topics. The papers reflect the complexity and breadth of Ludvigsen’s work as an author, researcher, and consultant. Approximately 70,000 of his photographic negatives have been digitized and are available on the Revs Digital Library. Thousands of undigitized prints in several series are also available but the copyright of the prints is unclear for many of the images. Ludvigsen’s research files are divided into two series: Subjects and Marques, each focusing on technical aspects, and were clipped or copied from newspapers, trade publications, and manufacturer’s literature, but there are occasional blueprints and photographs. Some of the files include Ludvigsen’s consulting research and the records of his Ludvigsen Library. Scope and Content Note: The Karl E. Ludvigsen papers are organized into eight series. The series largely reflects Ludvigsen’s original filing structure for paper and photographic materials. Series 1. Subject Files [11 filing cabinets and 18 record center cartons] The Subject Files contain documents compiled by Ludvigsen on a wide variety of automotive topics, and are in general alphabetical order. -

FIAT Brings Back 500 1957 Edition
Contact: Jordan Wasylyk Bryan Zvibleman FIAT Brings Back 500 1957 Edition Back by popular demand, the Fiat 500 1957 Edition celebrates iconic Italian style and fun-to-drive dynamics inspired by the original 1957 Fiat Nuova 500 1957 Edition available in hatchback and carbrio configurations with 1.4-liter MultiAir Turbo engine, which is now standard across the entire Fiat 500 lineup and delivers 135 horsepower and 150 lb.-ft. of torque Based on Lounge model, which starts at a U.S. manufacturer’s suggested retail price (MSRP) of $19,745, the 1957 Edition package for the Fiat 500 is available for $995 The 500 1957 Edition includes: Three new 16-inch retro-inspired wheel options (White, Green or Blue) Exterior highlights with vintage elements, such as retro fascia with bright inserts and retro FIAT badging, retro Ivory door-trim panels, White exterior mirrors, two-toned paint with White roof on hatchback models and Black soft top on cabrio models Three retro-inspired paint colors: Celeste Blue (Retro Light Blue), Chiaro (Light Green) and Bianco Ice (White) Elegant interior features with Italian style: Ivory door-trim panels and Marrone leather shift boot, Avorio/Marrone leather-wrapped steering wheel and retro "FIAT" badge Fiat 500 is available in three models: Pop, Lounge and the high-performance Abarth Fiat 500 starts at $16,245 MSRP – the most affordable turbocharged vehicle in the United States New Fiat 500 1957 Edition arrives in FIAT studios this fall September 26, 2018, Auburn Hills, Mich. - Celebrating its legendary past, the FIAT brand announced today the new Fiat 500 1957 Edition in both hatchback and cabrio configurations – last available for the 2016 model year.