Fabio Giannini, La Mafia E Gli Aspetti Criminologici
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mafia Motifs in Andrea Camilleri's Detective
MAFIA MOTIFS IN ANDREA CAMILLERI’S DETECTIVE MONTALBANO NOVELS: FROM THE CULTURE AND BREAKDOWN OF OMERTÀ TO MAFIA AS A SCAPEGOAT FOR THE FAILURE OF STATE Adriana Nicole Cerami A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Languages and Literatures (Italian). Chapel Hill 2015 Approved by: Dino S. Cervigni Amy Chambless Roberto Dainotto Federico Luisetti Ennio I. Rao © 2015 Adriana Nicole Cerami ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Adriana Nicole Cerami: Mafia Motifs in Andrea Camilleri’s Detective Montalbano Novels: From the Culture and Breakdown of Omertà to Mafia as a Scapegoat for the Failure of State (Under the direction of Ennio I. Rao) Twenty out of twenty-six of Andrea Camilleri’s detective Montalbano novels feature three motifs related to the mafia. First, although the mafia is not necessarily the main subject of the narratives, mafioso behavior and communication are present in all novels through both mafia and non-mafia-affiliated characters and dialogue. Second, within the narratives there is a distinction between the old and the new generations of the mafia, and a preference for the old mafia ways. Last, the mafia is illustrated as the usual suspect in everyday crime, consequentially diverting attention and accountability away from government authorities. Few critics have focused on Camilleri’s representations of the mafia and their literary significance in mafia and detective fiction. The purpose of the present study is to cast light on these three motifs through a close reading and analysis of the detective Montalbano novels, lending a new twist to the genre of detective fiction. -

Intervista a Caponnetto £R^H&**?*Cheraccob*Rfeditl
DOMENICA 2 AGOSTO 1992 IN ITALIA PAGINA 9 L'UNITÀ Intervista a Caponnetto £R^h&**?*cheraccob*rfeditl " ******* •* vu|/w«iivtw ^ Q1innicl toma in campo contro la mafia «Persi dieci anni e Cosa Nostra ha avuto il tempo di diventare una potenza finanziaria» La fatica e le amarezze di Falcone e Borsellino, la pista tedesca e i veleni di Palermo «La mìa sfida all'impero del male» Toma in prima linea, per mettere a disposizione dei giovani magistrati, quelli che operano in Sicilia innanzitutto, la sua saggezza, la sua Antonino Caponnetto' ha esperienza, la sua lucida accettato di determinazione nella lotta contro la lavorare come mafia. Avrà un ufficio a Roma e uno a consulente del Firenze, lavorerà «senza prendere una governo nella lira» e fino a quando «potrò esprimere lotta alla malia: le mie idee». In questa intervista nella foto grande, una Antonino Caponnetto, creatore del Immagine di pool antimafia a Palermo, ricorda, via D'Amelio giudica, spiega; parla di Falcone e dopo l'agguato Borsellino, di Lima e Giammanco. E 3 Borsellino e riflette con durezza su questi dieci alla sua scorta anni persi, regalati a Cosa Nostra. ANDREABARBATO •i «Diecianni.. Si sono persi dieci anni. Eco- mentale di Cosa Nostra, dove il principio fonda si si è dato tempo alla mafia di diventare una mentale è quello di dire sempre e dovunque la potenza finanziaria, un impero. Ora forse è tardi La Falange armata verità. Anche davanU al giudice i pentiti si sono per npulire quella fogna che è la Palermo sotter attenuti a questo principio, e del resto non han ranea». -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

Società E Cultura 65
Società e Cultura Collana promossa dalla Fondazione di studi storici “Filippo Turati” diretta da Maurizio Degl’Innocenti 65 1 Manica.indd 1 19-11-2010 12:16:48 2 Manica.indd 2 19-11-2010 12:16:48 Giustina Manica 3 Manica.indd 3 19-11-2010 12:16:53 Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo di fondi di ricerca del Dipartimento di studi sullo stato dell’Università de- gli Studi di Firenze. © Piero Lacaita Editore - Manduria-Bari-Roma - 2010 Sede legale: Manduria - Vico degli Albanesi, 4 - Tel.-Fax 099/9711124 www.lacaita.com - [email protected] 4 Manica.indd 4 19-11-2010 12:16:54 La mafia non è affatto invincibile; è un fatto uma- no e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fe- nomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze mi- gliori delle istituzioni. Giovanni Falcone La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un mo- vimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità… Paolo Borsellino 5 Manica.indd 5 19-11-2010 12:16:54 6 Manica.indd 6 19-11-2010 12:16:54 Alla mia famiglia 7 Manica.indd 7 19-11-2010 12:16:54 Leggenda Archivio centrale dello stato: Acs Archivio di stato di Palermo: Asp Public record office, Foreign office: Pro, Fo Gabinetto prefettura: Gab. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -

Giuseppe Montana Nasce Ad Agrigento L'8 Ottobre 1951
BEPPE MONTANA Giuseppe Montana nasce ad Agrigento l’8 ottobre 1951. Trasferitosi con la famiglia a Catania, si laurea alla Facoltà di Giurisprudenza di Palermo. Dopo aver superato il concorso per Commissario di P.S., è assegnato alla Squadra Mobile di Palermo presso la sezione investigativa. Durante questa esperienza collabora con il giudice Rocco Chinnici ed instaura un proficuo rapporto professionale con Ninni Cassarà, anch’egli in servizio presso la Squadra Mobile. Dopo breve tempo il Commissario Montana è a capo della neonata sezione “catturandi” della Squadra Mobile di Palermo, deputata ad eseguire gli ordini di custodia cautelare nonché alla ricerca dei latitanti della criminalità organizzata. Grazie alle spiccate capacità investigative riesce a disarticolare numerosi nuclei mafiosi della città, sequestrando depositi di armi e di droga oltre ad arrestare numerosi boss locali. Insieme al collega Cassarà utilizza metodi più dinamici di investigazione, mettendo a punto un sistema innovativo di controllo del territorio capace di intimorire e minacciare seriamente gli interessi di “Cosa nostra”. Solo qualche giorno prima, il 25 luglio 1985, il Commissario Montana con la sua squadra aveva condotto un’operazione portando all’arresto ben 8 uomini del capo mafia Michele Greco, riuscito invece a sfuggire alla cattura. Come ritorsione, il 28 luglio 1985, nei pressi del porto turistico di Porticciolo (PA), di ritorno da una gita con la fidanzata e gli amici, due sicari si avvicinarono al Commissario Montana freddandolo con una serie di colpi di pistola a distanza ravvicinata. Il 17 febbraio 1995 la Corte di Assise di Palermo ha condannato i mandanti dell’omicidio del Commissario Montana, tra i quali, Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. -
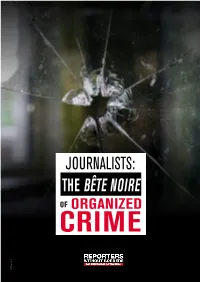
THE BÊTE NOIRE of ORGANIZED CRIME © Pexel.Com © Pexel.Com CONTENTS CONTENTS
1 JOURNALISTS: THE BÊTE NOIRE OF ORGANIZED CRIME © Pexel.com CONTENTS Foreword 4 Shut up or die Crime terminology 6 Mafias and cartels Disturbing figures 1. Emergence of a European mafia 8 Murders in three EU countries in less than a year 8 • Slovakia: Ján Kuciak wasn’t just annoying the ‘Ndrangheta • Malta: symbol of persecution of investigative journalists • Bulgaria: journalist’s murder under investigation Organized crime tightens hold on many European countries 12 • In Italy: Saviano, Borrometi and 194 others • Two journalists protected around the clock in the Netherlands • France not spared Balkan journalists and Russian mob 19 • Jovo Martinovic in Montenegro • Albania: smeared, hounded and threatened, Alida Tota keeps going Soft control: infiltrating the media 20 • A Bulgarian deputy and oligarch’s media empire 2. Take care, subject off limits 22 Drug cartels show no pity towards journalists 22 • At least 32 Mexican journalists killed by cartels since 2012 • Colombia: no-go areas Environmental journalists targeted by local gangs 24 • India’s sand mafia sows death • Journalists versus Cambodia’s sand cartels • John Grobler runs into Cosa Nostra in Namibia © Pexel.com Organized crime allied with corrupt businessmen and politicians 27 • Poland: Tomasz Piatek versus Russian mafia • Russia: politicians and hitmen • Turkey: pro-government gangster’s blacklist Japanese media keep mum about the yakuza 30 • Yakuza – they who shall not be named 3 • Interview with US journalist Jake Adelstein: “The yakuza use the media as an instrument of -

Brief History of Sicilian Mafia
For centuries, there had been banditry in southern Italy. It is not surprising when we consider that the area south of Rome was ruled for hundreds of years by foreign powers and the land was generally (mis)managed by absentee landlords. In their absence, the bandits stepped in to enforce the payment of dues or meagre profits from the peasants to the landowners, creaming a lot off the top. Stealing from the rich to give to the poor was no part of their raison d’etre. Over time, they became the landowners’ enforcers and then began to take over large tracts but it was the unification of Italy, following Garibaldi’s march through Sicily and up through southern Italy defeating and forcing the capitulation of the Spanish Bourbons, rulers of the Kingdom of the Two Sicilies, which gave them their greatest opportunity . If you have read “The Leopard” by Giuseppe di Lampedusa or seen the film, you will have recognised that the Mafia were gaining an important role in the running of Sicilian cities, towns and regions; they were gaining election as mayors and they were marrying into families of the nobility of the island. The Risorgimento whilst unifying the country also exaggerated the division between the north and the south. Sicilians often used to dispute (at least publicly) the existence of the Mafia or La Cosa Nostra (Our Thing) as the organisation names itself. They claimed that it was a northern construct. However, there is an excellent book by Gianni Riotta, “Prince of the Clouds”, which describes how the mafia, acting as a private army on behalf of the landowner against her peasants, uses force and murder to keep the poor of Sicily under control. -

Magisterarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES Magisterarbeit Titel der Magisterarbeit La Cosa Nostra – Struktur, Funktionen und mediale Berichterstattung im Zuge des Maxiprozesses von Palermo (10.2.1986 – 17.12.1987) Verfasser Fabio Arienti BA angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 236 349 Studienrichtung lt. Studienblatt: Italienisch Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Robert Tanzmeister Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis S.1 1. Fragestellung S.3 2. Methode S.6 3. Aktueller Forschungsstand S.9 4. Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte S.12 4.1. Etymologie S.13 4.2. Glossar S.13 4.3. Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert S.16 4.3.1. Die Einigung Italiens S.17 4.3.2. Implementierung einer lokalen Verwaltung S.19 4.3.3. Der Erste Weltkrieg S.22 4.3.4. Faschismus S.22 4.3.5. Die Nachkriegsjahre S.23 4.3.6. Wirtschaftlicher Aufschwung S.26 4.3.7. Der Drogenhandel S.27 4.3.8. Änderungen in der öffentlichen Wahrnehmung S.29 4.3.9. Wiederbelebung und zweite Phase des Drogenhandels S.31 4.3.10. Die Machtergreifung der Mafia aus Corleone S.33 4.3.11. Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino und der Antimafia Pool S.34 4.3.12. Revolutionierung der politischen Landschaft Italiens S.36 5. Struktur und soziale Funktionen S.38 5.1. Ihre Struktur nach Giovanni Falcone S.38 5.2. Ihre Funktionen nach Raimondo Catanzaro S.46 5.2.1. Die Mafia als Vermittler zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen S.48 1 5.2.2. -
![Il Dizionario Della Mafia [Archivioantimafia]](https://docslib.b-cdn.net/cover/1755/il-dizionario-della-mafia-archivioantimafia-1511755.webp)
Il Dizionario Della Mafia [Archivioantimafia]
27 MARTEDÌ 1DICEMBRE 2009 IL DIZIONARIO DELLA MAFIA CORAGGIO/1 Falcone e Borsellino Due giudici contro Amici d’infanzia, coetanei e colleghi Foto Ansa AMANINUDE CONTRO LA VIOLENZA IL COLPO PIÙ DURO ACOSANOSTRA Nicola Tranfaglia STORICO oraggio è una parola che non è faci- le usare quando si scrive di mafia. Il C mondo mafioso, infatti, per rag- giungere i suoi obiettivi, piuttosto che il coraggio utilizza l’astuzia e, contro chi non si adegua, la violenza. Una violenza im- provvisa e oscura. Ma di coraggio bisogna parlare quando raccontiamo la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che hanno perduto la vita perché hanno combattuto fino all’ultimo la mafia siciliana. Erano coscienti di quello che li aspettava. Sapevano per l’esperienza accumulata nella loro breve vita che non c’era da farsi illusio- ni. Cosa Nostra, questo è il nome che in Sici- lia è stato assunto dalla mafia, aveva identifi- cato in quei due giudici i nemici principali dell’organizzazione. Questo perché negli an- ni Ottanta il cosiddetto «maxi-processo» - che da Falcone e Borsellino era stato istruito -avevasferratoaCosaNostrauncolpodeci- sivo: decine di capi e sottocapi erano stati condannati come agenti di un potere che comminava pene anche mortali, senza ap- pello, a chi provava a opporsi. Anche a don- ne e bambini se si ribellavano o, semplice- mente, avevano avuto la sfortuna di vedere qualcosa che non avrebbero dovuto vedere. Falcone e Borsellino lottarono fino all’ulti- mo, in un certo senso attesero la morte, con- tro un’organizzazione che ormai era diventa- ta parte dello Stato e delle istituzioni pubbli- che. -

Le SENTINELLE DI NONNO Nino
Periodico fondato nel 2020 Diple Edizioni di Domenico Bilotta via Forese 7 – Figline e Incisa Valdarno (FI) [email protected] - Tel. 075 9157095 www.dipleedizioni.it - Cell. 3334875190 Partner della Fondazione Antonino Caponnetto www.giovanisentinelledellalegalita.org [email protected] Caporedattore Sergio Tamborrino Direttore Responsabile Claudio Gherardini Le SENTINELLEgazzetta delle giovani sentinelle DI dellaNONNO legalità Nino Lunedì 31 Agosto 2020 - Anno I n. 6 copia omaggio 22.500 copie inviate EDIZIONE SPECIALE Antonino Caponnetto, il padre del pool antimafia di Palermo, è morto il 6 dicembre 2002, a 82 anni, in una clinica fiorentina, dopo una lunga malattia. Per volere del Comune di Firenze la salma è stata esposta in Palazzo Vecchio nel Salone de’ Cinquecento, mentre le esequie si sono tenute nella basilica della Santissima Annunziata. A dare l’ultimo saluto a nonno Nino un affollatissimo pubblico di giovani, insegnanti, parenti, amici, collaboratori e gente per bene che hanno riempito la piazza antistante e la basilica per manifestare stima, ammirazione, gratitudine, affetto a colui che, lui sì di certo degnamente, in nome del popolo italiano aveva parlato, giudicato, vissuto, lottato, sofferto, amato. Dall’altra ...a rappresentante il Popolo italiano nessuna istituzioni presente! Era nato il 5 settembre 1920 a Caltanissetta ed era entrato in magistratura nel 1954. Nel 1983 quando cosa nostra uccide Rocco Chinnici, capo dell’Ufficio istruzione di Palermo, Caponnetto chiede e ottiene di essere assegnato a quell’ufficio e, poche settimane dopo il suo arrivo costituisce il primo pool antimafia. Ne fanno parte Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Il loro lavoro ha come ri- sultato il primo maxiprocesso contro cosa nostra. -

2. the Godfather Returns.Pdf
The Godfather Returns Mark Winegardner alla mia famiglia "Whoever forsakes the old way for the new knows what he is losing, but not what he will find. " Sicilian proverb "They were killing my friends." AUDIE MURPHY, most decorated U.S. soldier of World War II, when asked how he had found the courage to fight an entire German infantry company *The Godfather II also covers the early life of Vito Corleone (1910-1939) in flashback scenes. **The second half of The Godfather Returns also covers the early life of Michael Corleone (1920-1945) in flashback scenes. THE CORLEONE FAMILY Vito Corleone, the first godfather of New York's most powerful crime family Carmela Corleone, Vito Corleone's wife and mother of their four children Sonny Corleone, Vito and Carmela Corleone's oldest son Sandra Corleone, Sonny's wife, now living in Florida Francesca, Kathy, Frankie, and Chip Corleone, Sonny and Sandra Corleone's children Tom Hagen, consigliere and unofficially adopted son Theresa Hagen, Tom's wife and mother of their three children Andrew, Frank, and Gianna Frederico "Fredo" Corleone, Vito and Carmela's second-born son (underboss 1955-1959) Deanna Dunn, Oscar-winning actress and Fredo's wife Michael Corleone, Vito's youngest son and the reigning Don of the Corleone Family Kay Adams Corleone, Michael's second wife Anthony and Mary Corleone, children of Michael and Kay Corleone Connie Corleone, Vito and Carmela's daughter Carlo Rizzi, Connie Corleone's deceased husband Ed Federici, Connie Corleone's second husband THE CORLEONE FAMILY ORGANIZATION Cosimo "Momo the Roach" Barone, soldato under Geraci and nephew of Sally Tessio Pete Clemenza, caporegime Fausto Dominick "Nick" Geraci, Jr.