Evoluzione Della 'Ndrangheta: Un Percorso Storico-Sociologico
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Irrompono in Ospedale E Uccidono Boss Della Mafia E Suo Figlio Sotto Inchiesta Ex Presidente Agip
GIOVEDÌ 24 APRILE 1986 l'Unità - CRONACHE Anche Celli potrà D pentito Fragomeni: «Don Stilo Slitta la ratifica dell'accordo appellarsi contro il partecipava alle riunioni dei Italia-S. Marino. Maggioranza mandato di cattura capomafia ogni fine del mese » divisa dopo gli attacchi dei de ROMA — Nel giudizio sollecitato alla Corte costituzionale sul* Dal nostro Inviato Salomone e anche di suo fratello Antonino che , ROMA — La ratifica dell'accordo tra la Repub coprire In parte gli effetti negativi dell'inflazio l'art 263 del codice di procedura penale, i «nomi eccellenti» LOCRI — Il grande accusatore di don Stilo, il Tommaso Buscetta indica come capo del man blica di San Marino e l'Italia ha subito ieri, in ne. Se cadono quelle rinunce il canone può esse (Ortolani, Terruzzl, Gelli) l'hanno avuta vinta. La Corte ha di* rapinatore torinese Franco Drunero, che affer damento di San Giuseppe Iato e membro della Senato, un breve rinvio. Appena una settima re rivisto ma ovviamente sono necessari appo ma di aver visto il prete di Africo in un summit «cupola». Proprio sui rapporti con Antonino Sa na: la commissione Esteri voterà mercoledì siti negoziati. Ma a tutt'oggl — ha detto VA' chiarato l'illegittimità dell'articolo in questione. La norma non lomone — che si costituì ai carabinieri di Africo gnelli — quelle rinunce restano valide per l'Ita riconosceva, finora, agli imputati latitanti, la possibilità di pro della cosca mafiosa dei Ruga, non intende ri prossimo e l'aula nei primi giorni di maggio . spondere. Prolesta per il trattamento a cui è Nuovo dopo una visita a don Stilo, proveniente Lo slittamento è stato provocato dalla divisione lia e per San Marino che le osserva e che non le porre appello di merito contro l'ordinanza che rigetta l'istanza sottoposto in carcere: «Sono malato di cirrosi dal Brasile — le domande del presidente della nella maggioranza: i de vogliono rimettere in ha denunciate. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

'Ndrangheta: Anatomia Di Un Potere
Numero 1 - 2014 DOSSIER - ‘NDRANGHETA: ANATOMIA DI UN POTERE ‘Ndrangheta: anatomia di un potere Analisi e prospettive di un magistrato in prima linea Intervista al pm Giuseppe Lombardo di Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo “La ‘Ndrangheta va oltre quei personaggi a cui è attribuita la carica di ‘capo crimine’: ciò significa che tutto ciò che si trova al di sopra di queste figure non solo non deve essere considerato estraneo alla struttura dell’organizzazione ma va correttamente identificato con quella componente occulta che in realtà costituisce la testa pensante, il centro decisionale effettivo”. Giuseppe Lombardo è il pm titolare di alcune delle inchieste più delicate condotte contro le cosche di Reggio Calabria, considerate le più potenti dell’intera regione. Al processo “Meta” ha fatto condannare boss del calibro di Giuseppe De Stefano, Pasquale Condello, Giovanni Tegano e Pasquale Libri. Ma le sue indagini affondano le radici anche nei rapporti tra l’organizzazione criminale calabrese e le istituzioni, tra la ‘Ndrangheta e la Massoneria, la politica e l’imprenditoria. Un coacervo di poteri più o meno occulti all’interno di un sistema criminale integrato. Il magistrato, minacciato di morte dalla ‘Ndrangheta, ha istruito altresì il filone calabrese dell’inchiesta sulla Lega nord che ha visto coinvolto l’ex tesoriere Francesco Belsito, ed è tra i titolari dell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola. La prima domanda è necessaria, anche se può sembrare banale. Che significa oggi fare il magistrato antimafia in Calabria? Per risponderle devo partire dalla storia della mia famiglia: sono nato a Reggio Calabria ma ho vissuto sempre nella Locride, fino a quando non ho deciso di andare a studiare fuori sede. -
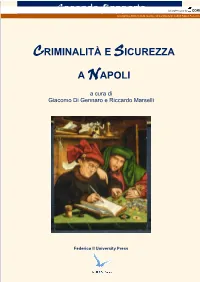
Secondo Rapporto
Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche, Giuridiche, e Sociali View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk econdo apporto brought to you by CORE 2 S R provided by Archivio della ricerca - Università degli studi di Napoli Federico II 2 Questo Secondo Rapporto su “Criminalità e sicurezza a Napoli” si è posto l’obiet- tivo, questa volta, di indagare le ragioni della persistenza di alcuni fenomeni crimi- nali che caratterizzano la città di Napoli rispetto ad altre metropoli del Paese. Nelle prime due sezioni gli interrogativi affrontati riguardano alcuni temi quali la persi- stenza dell’agire deviante grave di minori e criminale di adulti, la formazione di ag- RIMINALITÀ E ICUREZZA gregazioni violente giovanili, la ferocia dei clan camorristici e l’adeguatezza delle politiche di deterrenza, nonostante in Italia il 41-bis e le diverse sperimentazioni in C S tema di controllo e sicurezza del territorio attive in diverse città, tra cui Napoli. La terza sezione, invece, è dedicata all’analisi del fenomeno dell’usura alla luce di una C riflessione civilistica, penalistica e vittimologica. Il filo che unisce le parti è l’interpre- RIMINALITÀ E A APOLI tazione della dinamica e dei fattori connessi a crimini che sono trasversali ai diversi N strati sociali l’esito dei quali è la produzione di una trappola della criminalità che Gennaro Di Giacomo deprime le opportunità legali e favorisce la convinzione in molti che le carriere cri- a cura di minali siano più convenienti. Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli Oltre ai curatori del volume Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli, hanno con- tribuito: Aldo Corvino, Maria Di Pascale, Giuseppina Donnarumma, Debora Amelia Elce, Filomena Gaudino, Fausto Lamparelli, Elia Lombardo, Elisabetta Morazio, S - ICUREZZA A Andrea Procaccini, Francesco Rattà, Luigi Rinella, Rodolfo Ruperti, Riccardo Marselli Riccardo Sgobbo, Michele Maria Spina, Pasquale Troncone. -

Le Origini Della 'Ndrangheta – (Anno 2010)
1 OSSERVATORIO PER LA LEGALITA’ E LA SICUREZZA CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE Via Vincenzo Ricchioni, 1 - 70123 Bari LE ORIGINI DELLA ‘NDRANGHETA a cura di Nisio Palmieri 2 LE ORIGINI DELLA ‘NDRANGHETA INTRODUZIONE Anche per questa monografia abbiamo scelto un accreditato storico della ‘ndrangheta, il prof. Enzo Ciconte dell’Università di Roma, per farci condurre nei meandri della storia di una organizzazione criminale, oggi considerata tra le più agguerrite e ricche in campo internazionale. Non abbiamo trascurato, così come per le monografie dedicate alla camorra e alla mafia, la consultazione dei tanti testi, certamente non tutti, che sono fioriti intorno alla ‘ndrangheta, per alcuni tratti salienti della sua attività. Ci è parsa indispensabile la scelta di un solido punto di riferimento perché dovendo tratteggiare soprattutto i dati essenziali della sua nascita era necessario seguire un percorso già scandagliato che tra l’altro assicurava un approfondimento incomparabile perché sottoposto negli anni a un serrato confronto, non solo accademico tra specialisti, che, pur non ancora concluso, ha assunto una condivisa visione sulle sue origini, il che, ci pare, non sia poca cosa. La ‘ndrangheta è considerata in maniera concorde l’organizzazione non eccessivamente appariscente nel territorio in cui è presente; tuttavia ha raggiunto apprezzabili livelli di organizzazione strutturata e diffusa sia su scala nazionale che internazionale, le cui diramazioni hanno sempre dei legami di partenza con il luogo di origine. Fonti autorevoli l’hanno qualificata come organizzazione criminale che si caratterizza, più delle altre, per la sua straordinaria rapidità nell’adeguare valori arcaici alle esigenze del presente, sapendo gestire, con spiccata modernità, il cambiamento. -

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Foreword
I I EUROPEAN COMMISSION I FORWARD STUDIES UNIT I I I I I Organized Criminality I Security in Europe I European commission Delegation U,..iJI .. {"a ..j ·1I 2300 f;,1 Slrcct, NW I Washington, DC 20037 I I Fondazione Rosselli I I I ~ I f\l WORKING PAPER, 1999 ·~.~ ,,.,,,l,1 j ll. /, lI :) ! ,, ) I I Contents I I. Mafia(s) in the mediterranean and the fight against organised crime in Italy I By Maurizio FIASCO 3 1 Mafia(s) in the Mediterranean: a geopolitical picture 7 I 1.1 Mafia as a mediterranean phenomenon 7 1.2 From "made in Sicily" to universal model: crime as a substitute for modernisation 8 1.3 The effects of war 9 I 1.3.1 Apulian versatility: from smuggling to arms and drug trafficking 11 1.3.2 The pendulum of war: the mafias as instrument of the balance of power in the Mediterranean? 12 I 1.3.3 The scale of the interests involved 13 2 The fight against organized crime in Italy: a national priority 14 2.1 The fight against mafia: the limits of traditional investigation? 14 I 2.2 Organized crime and political and administrative corruption 14 2.3 Cosa Nostra's new organizational set-up 15 I 2.4 Building a portrait of the mafia 15 2.5 Drugs: the forgotten problem? 16 I 2.6 Ways forward: better knowledge, better coordination 16 II. The New Mafia I By Pier Luigi Vigna 17 3 The end of the Cold War and the blurring of external and internal security threats 17 I 4 The Russian Mafia 18 4.1 Organized crime in the Russian Federation 18 4.2 The expansion of Russian criminal activities in the USA 21 I 4.3 The activities of Russian criminal organizations in Europe 22 4.4 The expansion of Italian criminal organizations into Eastern Europe 23 I Ill. -
Antonino Scopelliti, Parlano Due Pentiti
domenica24 casa24 moda24 food24 motori24 job24 stream24 viaggi24 salute24 shopping24 radio24 altri CERCA Accedi How To Spend It NEW! IL Magazine Business School ed eventi Milano NEW! Archivio storico Strumenti di lavoro 9° (cambia) Giovedì • 10 Settembre 2015 • Aggiornato alle 14:54 Versione digitale HOME ITALIA MONDO NORME & FINANZA & IMPRESA & NOVA24 PLUS24 COMMENTI & STORE24 TRIBUTI MERCATI TERRITORI TECH RISPARMIO INCHIESTE Acquista & abbonati Italia Scenari Imprese Lavoro & Pensioni Fisco Europa Mercati Credito Euro & Valute Mondo Gli Economisti Lettera al risparmiatore Commenti&Inchieste Scenari Sull'omicidio Scopelliti due pentiti IN QUESTO ARTICOLO Media ora parlano Argomenti: Cosa Nostra | Antonino Scopelliti | Udine | dal nostro inviato Roberto Galullo 09 agosto 2012 Angiolo Pellegrini | Vibo Valentia | Giovanni Falcone | Rosarno | Roma | Pippo Calò Tweet Consiglia 59 2 My24 ULTIMI DI SEZIONE ITALIA Giugno 1991, Nicotera. Questa cittadina di seimila abitanti in Agenzia delle Entrate sotto scacco, provincia di Vibo Valentia è il regno della 'ndrina Mancuso rischio «default fiscale» che sulle rotte dei cartelli colombiani del narcotraffico ha di Stefano Simontacchi creato un impero economico in grado di corrompere tutto e tutti. L'ANALISI / EUROPA L'Unione non deve essere solo un È una giornata calda e non solo per la temperatura. È la prima contenitore ma soggetto politico volta che a Nicotera si riunisce in un luogo al riparo da occhi Montesquieu indiscreti e sorvegliato a vista il gotha di Cosa Nostra e quello della 'ndrangheta. Da una parte i Corleonesi di Totò Riina, dall'altra le famiglie NO A GREXIT IL MINISTRO Commisso, Aquino, Pesce, Piromalli, i padroni di casa Mancuso, Ficara, Latella, Tegano, L’Europa eviti il DELL'ECONOMIA Condello, Rosmini e Imerti. -
Impaginato ANIMA NERA PAGINE 3-30.Pdf
LO STATO DEL MONDO I legami occulti tra la mafia e la destra eversiva Mattia Fossati Anima nera I legami occulti tra la mafia e la destra eversiva Asterios Editore Trieste, 2018 Prima edizione nella collana: Lo stato del mondo, Gennaio 2018 ©Mattia Fossati ©Asterios Abiblio Editore 2017 p0sta: [email protected] www.asterios.it I diritti di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati. Stampato in UE ISBN: 978-88-9313-079-0 Indice PREMESSA L’annozero , 11 INTRODUZIONE Missini e Massoni , 13 CAPITOLO PRIMO 1970, 27 CAPITOLO SECONDO Cosa resterà di questi anni ‘80? Il cambio di strategia , 45 I nuovi Re di Roma e l’omicidio Pecorelli, 49 Il caso Mattarella , 61 CAPITOLO TERZO Bologna e gli ultimi fuochi La strage della stazione , 71 Il treno della morte , 81 CAPITOLO QUARTO La Trattativa Fare la guerra per fare la pace , 89 L’estorsione , 120 1994-...: la Mafia al Governo , 125 CAPITOLO QUINTO Il Nero della Magliana Il Mondo di Sopra , 129 Il Mondo di Sotto , 142 CAPITOLO SESTO Mafia 2.0 Il sistema criminale, 159 BIBLIOGRAFIA , 165 Io so. Ma non ho le prove... Io so. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chia - mato golpe (e che in realtà è una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del potere). Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e Bo - logna dei primi mesi del 1974 … io so i nomi di coloro che, tra una messa e l’altra, hanno dato le disposizioni e assi - curato la protezione politica a vecchi generali … Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle isti - tuzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli. -

I Risultati Conseguiti Non Debbdebboooonono Far Dimenticare Che La Mafia Ha Enormi Cca-A-A-A- Pacità Di Tenuta E Di Manovra
"I risultati conseguiti non debbdebboooonono far dimenticare che la mafia ha enormi cca-a-a-a- pacità di tenuta e di manovra. E' peperrrrciòciò indispensabile continuare a denudenunnnnciareciare le infiltrazioni e le pressioni mafiose, rre-e-e-e- sistere alle intimidaintimidazioni,zioni, stimolstimolaaaarere --- nei giovani e in tutto il Paese --- la crescita della coscienza civica e nella fiducia nenel-l-l-l- lo StStaaaatoto di diritto". Messaggio del Presidente della Repub- blica, Giorgio Napolitano, in occasione dell'inaugurazione di una sala del Mini- stero della Giustizia al magistrato Rosa- rio Livatino, ucciso dalla mafia il 21 set- tembre 1990 Settembre 2009 Le mani della criminalità sulle imprese – XII Rapporto 2009 INDICE PRESENTAZIONE PAG 3 MAFIA SPA . TRA LOCALISMO E GLOBALIZZAZIONE PAG 5 Un bilancio sempre in attivo pag 7 Giro d’affari dei reati del ramo commerciale pag 8 La mesata pag 9 Dinasty mafiosa ovvero la crime caste pag 11 La mafia in tempo di crisi pag 11 PARTE I – LE TASSE DELLA MAFIA PAG 14 Anonima estorsioni pag 14 “O’ Sistema” si evolve pag 16 Il picciotto ha aperto Partita Iva pag 16 Il sistema del pizzo non da più le certezze della volta pag 16 LA MAPPA DEL PIZZO PAG 19 Sicilia – la “normalizzazione di Palermo: Cosa Nostra si riorganizza PAG 19 Calabria - Dalla colla di Palermo al fuoco di Reggio Calabria pag. 28 Campania – Camorra casertana e napoletana: gli affari prima di tutto pag 33 Puglia – Anche la Scu si fa impresa pag 35 La quinta mafia: i Basilischi pag 37 Non solo Sud pag 38 Nuovi attori entrano in scena pag 45 Le “Mafie in Gonnella” pag 45 La geografia delle denunce pag 48 L’indice di intimidazione pag 50 Sos Impresa: 18 anni di attività pag 52 OPERAZIONI ANTI ESTORSIONE 2007-2009 PAG . -

Politiek En Georganiseerde Misdaad 3 | 09
3 | 09 Justitiële verkenningen Politiek en georganiseerde misdaad verschijnt 8 maal per jaar • jaargang 35 • mei Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2 Justitiële verkenningen, jrg. 35, nr. 3, 2009 Colofon www.bju‑tijdschriften.nl. Of neem Justitiële verkenningen is een contact op met Boom distributie‑ gezamenlijke uitgave van het centrum via 0522‑23 75 55 of Wetenschappelijk Onderzoek‑ en [email protected]. Documentatiecentrum van het minis‑ Abonnementen kunnen op elk gewenst terie van Justitie en Boom Juridische tijdstip ingaan. Valt de aanvang van uitgevers. Het tijdschrift verschijnt een abonnement niet samen met acht keer per jaar. het kalenderjaar, dan wordt over het resterende gedeelte van het jaar een Redactieraad evenredig deel van de abonnementsprijs drs. A.C. Berghuis in rekening gebracht. Het abonnement mr. dr. M. Malsch kan alleen schriftelijk tot uiterlijk prof. dr. mr. L.M. Moerings 1 december van het lopende prof. dr. mr. E. Niemeijer kalenderjaar worden opgezegd. Bij dr. C.J. de Poot niet‑tijdige opzegging wordt het mr. drs. M. Schuilenburg abonnement automatisch voor een jaar dr. B.M.J. Slot verlengd. Gratis abonnementen kunnen mr. drs. P.J.J. van Voorst desgevraagd te allen tijde beëindigd worden. Redactie drs. M.P.C. Scheepmaker Administratie De abonnementenadministratie wordt Redactiesecretariaat verzorgd door Boom Juridische uit‑ tel. 070‑370 65 54 gevers, Postbus 85576, 2508 CG Den E‑mail: [email protected] Haag, tel. 070‑330 70 33, fax 070‑330 70 30, e‑mail [email protected], Redactieadres internet: www.bju.nl. Ministerie van Justitie, WODC Redactie Justitiële verkenningen Ontwerp Postbus 20301 Tappan, Den Haag 2500 EH Den Haag fax 070‑370 79 48 Omslagfoto tel. -

Doc. Xxiii, N. 5
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA Doc. XXIII N. 5 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITA` ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE (istituita con legge 27 ottobre 2006, n. 277) (composta dai deputati: Forgione, Presidente; Astore, Bono, Bordo, Burtone, Cirino Pomicino, D’Ippolito Vitale, Incostante, Lagana` Fortugno, Licandro, Lo Monte, Lumia, Vice Presidente, Mancini, Marchi, Misuraca, Angela Napoli, Pellegrino, Segretario, Picano, Rotondo, Santelli, Tagliatatela, Tassone, Vice Presidente, Villari, Vitali, Alfredo Vito; e dai senatori: Adragna, Baccini, Massimo Brutti, Buccico, Calvi, Castelli, Curto, Di Lello Finuoli, Garraffa, Gentile, Segretario, Giambrone, Iovene, Malvano, Montalbano, Mugnai, Nar- dini, Novi, Palma, Palumbo, Pellegatta, Pistorio, Procacci, Ruggeri, Villecco Calipari, Vizzini) RELAZIONE ANNUALE SULLA ’NDRANGHETA (Relatore: on. Francesco FORGIONE) Approvata dalla Commissione nella seduta del 19 febbraio 2008 Trasmessa alle Presidenze delle Camere il 20 febbraio 2008 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n), della legge 27 ottobre 2006, n. 277 STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO Camera dei Deputati —2— Senato della Repubblica XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Camera dei Deputati —3— Senato della Repubblica XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PAGINA BIANCA Camera dei Deputati —5— Senato della Repubblica XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI INDICE CAPITOLO I Una mafia liquida .............................................................................. -

Secondo Rapporto Criminalità E Sicurezza a Napoli
tudi e icerche in cienze riminologiche, iuridiche, e ociali S R S C G S econdo apporto 2 S R 2 Questo Secondo Rapporto su “Criminalità e sicurezza a Napoli” si è posto l’obiet- tivo, questa volta, di indagare le ragioni della persistenza di alcuni fenomeni crimi- nali che caratterizzano la città di Napoli rispetto ad altre metropoli del Paese. Nelle prime due sezioni gli interrogativi affrontati riguardano alcuni temi quali la persi- stenza dell’agire deviante grave di minori e criminale di adulti, la formazione di ag- RIMINALITÀ E ICUREZZA gregazioni violente giovanili, la ferocia dei clan camorristici e l’adeguatezza delle politiche di deterrenza, nonostante in Italia il 41-bis e le diverse sperimentazioni in C S tema di controllo e sicurezza del territorio attive in diverse città, tra cui Napoli. La terza sezione, invece, è dedicata all’analisi del fenomeno dell’usura alla luce di una C riflessione civilistica, penalistica e vittimologica. Il filo che unisce le parti è l’interpre- RIMINALITÀ E A APOLI tazione della dinamica e dei fattori connessi a crimini che sono trasversali ai diversi N strati sociali l’esito dei quali è la produzione di una trappola della criminalità che Gennaro Di Giacomo deprime le opportunità legali e favorisce la convinzione in molti che le carriere cri- a cura di minali siano più convenienti. Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli Oltre ai curatori del volume Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli, hanno con- tribuito: Aldo Corvino, Maria Di Pascale, Giuseppina Donnarumma, Debora Amelia Elce, Filomena Gaudino, Fausto Lamparelli, Elia Lombardo, Elisabetta Morazio, S - ICUREZZA A Andrea Procaccini, Francesco Rattà, Luigi Rinella, Rodolfo Ruperti, Riccardo Marselli Riccardo Sgobbo, Michele Maria Spina, Pasquale Troncone.