'Ndrangheta: Anatomia Di Un Potere
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Irrompono in Ospedale E Uccidono Boss Della Mafia E Suo Figlio Sotto Inchiesta Ex Presidente Agip
GIOVEDÌ 24 APRILE 1986 l'Unità - CRONACHE Anche Celli potrà D pentito Fragomeni: «Don Stilo Slitta la ratifica dell'accordo appellarsi contro il partecipava alle riunioni dei Italia-S. Marino. Maggioranza mandato di cattura capomafia ogni fine del mese » divisa dopo gli attacchi dei de ROMA — Nel giudizio sollecitato alla Corte costituzionale sul* Dal nostro Inviato Salomone e anche di suo fratello Antonino che , ROMA — La ratifica dell'accordo tra la Repub coprire In parte gli effetti negativi dell'inflazio l'art 263 del codice di procedura penale, i «nomi eccellenti» LOCRI — Il grande accusatore di don Stilo, il Tommaso Buscetta indica come capo del man blica di San Marino e l'Italia ha subito ieri, in ne. Se cadono quelle rinunce il canone può esse (Ortolani, Terruzzl, Gelli) l'hanno avuta vinta. La Corte ha di* rapinatore torinese Franco Drunero, che affer damento di San Giuseppe Iato e membro della Senato, un breve rinvio. Appena una settima re rivisto ma ovviamente sono necessari appo ma di aver visto il prete di Africo in un summit «cupola». Proprio sui rapporti con Antonino Sa na: la commissione Esteri voterà mercoledì siti negoziati. Ma a tutt'oggl — ha detto VA' chiarato l'illegittimità dell'articolo in questione. La norma non lomone — che si costituì ai carabinieri di Africo gnelli — quelle rinunce restano valide per l'Ita riconosceva, finora, agli imputati latitanti, la possibilità di pro della cosca mafiosa dei Ruga, non intende ri prossimo e l'aula nei primi giorni di maggio . spondere. Prolesta per il trattamento a cui è Nuovo dopo una visita a don Stilo, proveniente Lo slittamento è stato provocato dalla divisione lia e per San Marino che le osserva e che non le porre appello di merito contro l'ordinanza che rigetta l'istanza sottoposto in carcere: «Sono malato di cirrosi dal Brasile — le domande del presidente della nella maggioranza: i de vogliono rimettere in ha denunciate. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -
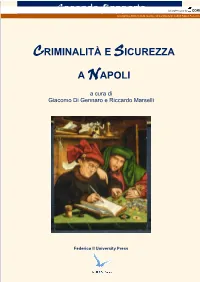
Secondo Rapporto
Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche, Giuridiche, e Sociali View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk econdo apporto brought to you by CORE 2 S R provided by Archivio della ricerca - Università degli studi di Napoli Federico II 2 Questo Secondo Rapporto su “Criminalità e sicurezza a Napoli” si è posto l’obiet- tivo, questa volta, di indagare le ragioni della persistenza di alcuni fenomeni crimi- nali che caratterizzano la città di Napoli rispetto ad altre metropoli del Paese. Nelle prime due sezioni gli interrogativi affrontati riguardano alcuni temi quali la persi- stenza dell’agire deviante grave di minori e criminale di adulti, la formazione di ag- RIMINALITÀ E ICUREZZA gregazioni violente giovanili, la ferocia dei clan camorristici e l’adeguatezza delle politiche di deterrenza, nonostante in Italia il 41-bis e le diverse sperimentazioni in C S tema di controllo e sicurezza del territorio attive in diverse città, tra cui Napoli. La terza sezione, invece, è dedicata all’analisi del fenomeno dell’usura alla luce di una C riflessione civilistica, penalistica e vittimologica. Il filo che unisce le parti è l’interpre- RIMINALITÀ E A APOLI tazione della dinamica e dei fattori connessi a crimini che sono trasversali ai diversi N strati sociali l’esito dei quali è la produzione di una trappola della criminalità che Gennaro Di Giacomo deprime le opportunità legali e favorisce la convinzione in molti che le carriere cri- a cura di minali siano più convenienti. Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli Oltre ai curatori del volume Giacomo Di Gennaro e Riccardo Marselli, hanno con- tribuito: Aldo Corvino, Maria Di Pascale, Giuseppina Donnarumma, Debora Amelia Elce, Filomena Gaudino, Fausto Lamparelli, Elia Lombardo, Elisabetta Morazio, S - ICUREZZA A Andrea Procaccini, Francesco Rattà, Luigi Rinella, Rodolfo Ruperti, Riccardo Marselli Riccardo Sgobbo, Michele Maria Spina, Pasquale Troncone. -

MAFIA and DRUGS Organized Crime and Drug Trafficking in Italy
MAFIA AND DRUGS Organized Crime and Drug Trafficking in Italy FABIO BERNABEI 44th Carnegie seminar 2º WORLD FORUM AGAINST DRUGS Stockholm May 25 2010 TOPICS • Historical origins and characters of: • Cosa Nostra • Camorra • Sacra Corona Unita • ‘Ndrangheta (Calabrian Mafia) • The Fifth Mafia: all roads lead to Rome COSA NOSTRA • "Cosa Nostra" is a Sicilian criminal society. the first document was in 1864, when Niccolò Turrisi Colonna, leader of the Palermo National Guard, wrote of a "sect of thieves" that operated across Sicily. • An 1865 dispatch from the prefect of Palermo first officially described the criminal phenomenon as a "Mafia". • Other than its members, Cosa Nostra makes extensive use of "associates". These are people who work for or aid a clan (or even multiple clans) but are not treated as true members. These include corrupt officials and prospective mafiosi. COSA NOSTRA / 2 Clan hierarchy • For many years, the power apparatuses of the individual clans were the sole ruling bodies within the association, and they have remained the real centers of power even after superordinate bodies were created in Cosa Nostra beginning in the late 1950s (the Sicilian Mafia Commission also known as Commissione). • Protection rackets - Arms trafficking - Loan sharking - Extortion - Control of contracting - Drug trafficking COSA NOSTRA / 3 • Starting in 1975, Cosa Nostra set up heroin refineries across the island. As well as refining heroin, Cosa Nostra also sought to control its distribution. Sicilian mafiosi moved to the United States to personally control distribution networks there. • By 1982, the Sicilian Mafia controlled about 80% of the heroin trade in the north-eastern United States. -

Le Origini Della 'Ndrangheta – (Anno 2010)
1 OSSERVATORIO PER LA LEGALITA’ E LA SICUREZZA CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE Via Vincenzo Ricchioni, 1 - 70123 Bari LE ORIGINI DELLA ‘NDRANGHETA a cura di Nisio Palmieri 2 LE ORIGINI DELLA ‘NDRANGHETA INTRODUZIONE Anche per questa monografia abbiamo scelto un accreditato storico della ‘ndrangheta, il prof. Enzo Ciconte dell’Università di Roma, per farci condurre nei meandri della storia di una organizzazione criminale, oggi considerata tra le più agguerrite e ricche in campo internazionale. Non abbiamo trascurato, così come per le monografie dedicate alla camorra e alla mafia, la consultazione dei tanti testi, certamente non tutti, che sono fioriti intorno alla ‘ndrangheta, per alcuni tratti salienti della sua attività. Ci è parsa indispensabile la scelta di un solido punto di riferimento perché dovendo tratteggiare soprattutto i dati essenziali della sua nascita era necessario seguire un percorso già scandagliato che tra l’altro assicurava un approfondimento incomparabile perché sottoposto negli anni a un serrato confronto, non solo accademico tra specialisti, che, pur non ancora concluso, ha assunto una condivisa visione sulle sue origini, il che, ci pare, non sia poca cosa. La ‘ndrangheta è considerata in maniera concorde l’organizzazione non eccessivamente appariscente nel territorio in cui è presente; tuttavia ha raggiunto apprezzabili livelli di organizzazione strutturata e diffusa sia su scala nazionale che internazionale, le cui diramazioni hanno sempre dei legami di partenza con il luogo di origine. Fonti autorevoli l’hanno qualificata come organizzazione criminale che si caratterizza, più delle altre, per la sua straordinaria rapidità nell’adeguare valori arcaici alle esigenze del presente, sapendo gestire, con spiccata modernità, il cambiamento. -

Mafia E Libertà Di Stampa: I Giornalisti Minacciati Dalla 'Ndrangheta
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali Corso di laurea in Giornalismo e Cultura Editoriale MAFIA E LIBERTÀ DI STAMPA: I GIORNALISTI MINACCIATI DALLA ‘NDRANGHETA Relatore: Chiar.mo Prof. Paolo Ferrandi Correlatore: Chiar.mo Prof. Marco Deriu Laureanda: Chiara Fazio matr. 271230 Anno Accademico 2017/2018 Introduzione Gran parte degli studiosi contemporanei concorda nel considerare la ‘ndrangheta l’organizzazione criminale più potente al mondo: agendo sotto traccia, riuscendo quasi a far passare inosservata la sua intrinseca pericolosità e approfittando di un clima di silenzio e di omertà, essa è stata in grado nel volgere degli ultimi due secoli di trasformarsi da fenomeno delinquenziale rurale e prevalentemente locale a «multinazionale del crimine organizzato»1, la cui potenza è oggi assimilabile a quella della camorra e della mafia. Il suo ampio spettro di interessi va dall’appalto al subappalto di opere pubbliche, alla politica, al traffico internazionale di droga, all’estorsione, al riciclaggio, all’usura: è possibile sostenere, a ragione, che non vi sia oggi un aspetto della vita pubblica immune alla presenza della ‘ndrangheta. L’obiettivo che ci si è posti con questo lavoro di ricerca, in particolare, è stato analizzare il complesso rapporto tra la ‘ndrangheta - nei territori che da essa sono permeati - e la libertà di stampa, cercando di capire se e in che misura essa rappresenti un reale ostacolo alla libera circolazione dell’informazione nel nostro Paese, e non solo, oltre che un pericolo per l’incolumità, ed in certi casi la vita, dei cronisti che se ne sono occupati e continuano ad occuparsene. Partendo dallo studio del contesto storico-culturale in cui la mafia calabrese è nata e si è sviluppata, sono state delineate le tappe della sua genesi ed evoluzione. -

CHAPTER I – Bloody Saturday………………………………………………………………
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY SCHREYER HONORS COLLEGE DEPARTMENT OF JOURNALISM ITALIAN WHITE-COLLAR CRIME IN THE GLOBALIZATION ERA RICCARDO M. GHIA Spring 2010 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for a baccalaureate degree in Journalism with honors in Journalism Reviewed and approved by Russell Frank Associate Professor Honors Adviser Thesis Supervisor Russ Eshleman Senior Lecturer Second Faculty Reader ABSTRACT At the beginning of the 2000s, three factories in Asti, a small Italian town, went broke and closed in quick succession. Hundreds of men were laid off. After some time, an investigation mounted by local prosecutors began to reveal what led to bankruptcy. A group of Italian and Spanish entrepreneurs organized a scheme to fraudulently bankrupt their own factories. Globalization made production more profitable where manpower and machinery are cheaper. A well-planned fraudulent bankruptcy would kill three birds with one stone: disposing of non- competitive facilities, fleecing creditors and sidestepping Italian labor laws. These managers hired a former labor union leader, Silvano Sordi, who is also a notorious “fixer.” According to the prosecutors, Sordi bribed prominent labor union leaders of the CGIL (Italian General Confederation of Labor), the major Italian labor union. My investigation shows that smaller, local scandals were part of a larger scheme that led to the divestments of relevant sectors of the Italian industry. Sordi also played a key role in many shady businesses – varying from awarding bogus university degrees to toxic waste trafficking. My research unveils an expanded, loose network that highlights the multiple connections between political, economic and criminal forces in the Italian system. -

De 'Ndrangheta in Nederland
De ’Ndrangheta in Nederland Aard, criminele activiteiten en werkwijze op Nederlandse bodem KLPD - Dienst Nationale Recherche De ’Ndrangheta in Nederland Aard, criminele activiteiten en werkwijze op Nederlandse bodem Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD) Dienst Nationale Recherche Hoofdstraat 54 3972 LB Driebergen Driebergen, juni 2011 Copyright © 2011 KLPD - Dienst Nationale Recherche Copyright Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen, alsmede behoudens voor zover in deze uitgave nadrukkelijk anders is aangegeven, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het KLPD. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), redactie en het KLPD geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen. Inhoud Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Achtergrond 13 1.3 Doelstelling 14 1.4 Leeswijzer 14 2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 15 3 Methoden van onderzoek 16 3.1 Deskresearch 16 3.1.1. Politiebronnen 16 3.1.2. Open bronnen 19 3.2 Interviews 20 3.3 Definiëring en operationalisering van begrippen 21 4 De achtergrond van de ’Ndrangheta 25 4.1 Organisatiekenmerken van de ’Ndrangheta 25 4.1.1. Bloed- en regiobanden, inwijding en rangen 27 4.1.2. Structuur en bestendigheid 32 4.2 Internationale spreiding 35 4.2.1. Samenwerking met andere criminelen, clans en maffiaorganisaties 36 4.2.2. Geografische spreiding 37 5 Aard van de ’Ndrangheta in Nederland 42 5.1. -

Evoluzione Della 'Ndrangheta: Un Percorso Storico-Sociologico
EVOLUZIONE DELLA ‘NDRANGHETA: UN PERCORSO STORICO-SOCIOLOGICO F������� G��������� * S�������: 1 - Sviluppi storici e subcultura criminale; 2 - Le guerre di ‘Ndrangheta; 3 – La stru�ura organizzativa della ‘Ndrangheta; 4 - Analogia con altre forme di organizzazioni criminali; 5 - Le a�ività criminali e le proiezioni al di fuori della Regione; 6 - Sviluppi internazionali; 7 - Rapporti tra ‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra e Sacra Corona Unita; 8 – Conclusione. 1. Sviluppi storici e subcultura criminale. È oramai opinione comune e popolare, sopra�u�o alla luce dei più recenti sanguinari avvenimenti occorsi in Germania, in una ci�adina apparentemente tranquilla come Duisburg, dove si è con- sumata una strage che ha mietuto sei vi�ime, quella che riconosce alla ‘Ndrangheta – nome con il quale è colle�ivamente identificata la mafia calabrese - un posto di rilievo sullo scacchiere internazio- nale criminale. Suggestionato dal clamore del fa�o, il pubblico mediatico ha espresso tu�o il suo stupore per la ridondanza e l’ac- canito cinismo del deli�o, mentre una folla di analisti si affannava a rispondere alle consuete puntuali interviste sullo stato della mafia al giorno d’oggi, come se quella violenza fosse una triste esplosa novità dell’ultima estate. In realtà, se dobbiamo a�enerci alle con- siderazioni degli scri�ori e, in misura maggiore, alla storia vissuta, l’organizzazione di malavita calabrese sta progredendo velocemen- te nel suo percorso delinquenziale da almeno un quarantennio. E pensare che all’incipit di tu�a la sua lunga evoluzione, l’Onorata Società, come veniva anche chiamata l’associazione, si industriava prevalentemente in a�ività dal sapore spiccatamente arcaico e rustico, quali gli abigeati, le ruberie nei campi, le rapine, i danneggiamenti dell’altrui proprietà terriera, in specie quando qualcuno non acce�ava la sua imposta protezione, e in particolar * Do�ore in giurisprudenza. -

Ribellarsi a Rosarno: La Costruzione Di Una Nuova Cultura Civile Nella Piana Di Gioia Tauro
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E ISTITUZIONI EUROPEE RIBELLARSI A ROSARNO: LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CULTURA CIVILE NELLA PIANA DI GIOIA TAURO Elaborato finale di: Claudio Campesi Relatore: Prof. Fernando dalla Chiesa Anno accademico: 2014/2015 1 INDICE INTRODUZIONE .......................................................................................................... 3 CAPITOLO 1- IL CASO VALARIOTI .................................................................... 6 1.1 UNA BREVE PANORAMICA DELL‟EVOLUZIONE STORICO-ECONOMICA DI ROSARNO E L‟ASCESA DELLA „NDRANGHETA LOCALE DALL‟ „800 AGLI ANNI ‟60 DEL „900. ............................................................................................ 6 1.2 GIUSEPPE VALARIOTI: DAL QUARTIERE COREA ALL‟IMPEGNO POLITICO .................................................................................................................... 12 1.3 MUTAMENTO DELLA „NDRANGHETA CALABRESE NEGLI ANNI 70-80: IL SALTO DI QUALITA‟. ........................................................................................... 17 1.4 “SE VOGLIONO INTIMIDIRCI NON CI RIUSCIRANNO, I COMUNISTI NON SI PIEGHERANNO MAI”: LOTTE POLITICHE DI GIUSEPPE VALARIOTI. ...... 28 1.5 ELEZIONI, OMICIDIO E GIUSTIZIA NEGATA. ............................................... 40 CAPITOLO 2- GIUSEPPE LAVORATO: IL SINDACO DELLA “PRIMAVERA DI ROSARNO” .............................................................................. 50 2.1 IL RINNOVATO IMPEGNO ANTIMAFIA ......................................................... -

Italian Organised Crime
Europol Public Information THREAT ASSESSMENT ITALIAN ORGANISED CRIME The Hague, June 2013 FILE NO: EDOC#667574 v8 This Europol product analyses and evaluates the threat posed by types of serious or organised crime. The assessment of threats is based on defined indicators. Page 1 of 18 Table of Contents 1 KEY JUDGEMENTS ................................................................................................. 3 2 INTRODUCTION .................................................................................................... 4 2.1 BACKGROUND .............................................................................................. 4 2.2 AIMS AND OBJECTIVES .................................................................................... 4 3 ITALIAN ORGANISED CRIME: COMMON FEATURES ............................................... 5 3.1 FAMILY ...................................................................................................... 5 3.2 POWER ...................................................................................................... 5 3.3 RESPECT .................................................................................................... 7 3.4 TERRITORY .................................................................................................. 7 4 SICILIAN MAFIA ................................................................................................... 9 5 CALABRIAN ‘NDRANGHETA ................................................................................. 10 6 NEAPOLITAN CAMORRA -

Condello Il Supremo Catturato a Pellaro Sorpreso in Un’Abitazione Di San Leo Con Altre Tre Persone Che Sono State Arrestate Per Favoreggiamento
10 Martedì 19 Febbraio 2008 Gazzetta del Sud Attualità . Colpo grosso dei carabinieri del Ros che hanno scovato il numero uno dei latitanti calabresi, inseguito dalle forze dell’ordine dal 1988 Condello il Supremo catturato a Pellaro Sorpreso in un’abitazione di San Leo con altre tre persone che sono state arrestate per favoreggiamento Paolo Toscano REGGIO CALABRIA In sintesi Boemi esultante L’epopea dell’ultima “primula Il boss. Pasquale Condel- rossa” della ’ndrangheta si è chiu- lo, 58 anni, di Archi, de- «La vittoria sa ieri sera. Nel rione San Leo di finito il Supremo, era il Pellaro, nella zona Sud della città, capo della cosca Condel- del gruppo, è stato catturato Pasquale Con- lo-Imerti-Serraino in op- dello, “il supremo”. Cinquantotto posizione a quella De Ste- una caccia anni, capo indiscusso dello schie- fano-Tegano. Protagoni- ramento uscito vincitore dalla se- sta delle due guerre di durata conda guerra di mafia combattu- mafia che hanno insan- ta tra il 1985 e il 1991 contro il guinato la provincia di venti anni» cartello “destefaniano”, Condello Reggio. era alla macchia da vent’anni. So- Tonio Licordari no stati i segugi del Ros, guidati La cattura. Dopo venti an- REGGIO CALABRIA dal tenente colonnello Valerio ni di latitanza è stato cat- Giardina, a stanarlo in un appar- turato ieri sera, a San Leo Le sirene di tanto in tanto lace- tamento al secondo piano di uno di Pellaro, in un’abitazio- rano il silenzio della città. Le stabile in via Filici, a poca distan- ne mentre stava parlando auto di magistrati e delle forze za dal torrente omonimo.