Atti Parlamentari
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

'Ndrangheta: Anatomia Di Un Potere
Numero 1 - 2014 DOSSIER - ‘NDRANGHETA: ANATOMIA DI UN POTERE ‘Ndrangheta: anatomia di un potere Analisi e prospettive di un magistrato in prima linea Intervista al pm Giuseppe Lombardo di Giorgio Bongiovanni e Lorenzo Baldo “La ‘Ndrangheta va oltre quei personaggi a cui è attribuita la carica di ‘capo crimine’: ciò significa che tutto ciò che si trova al di sopra di queste figure non solo non deve essere considerato estraneo alla struttura dell’organizzazione ma va correttamente identificato con quella componente occulta che in realtà costituisce la testa pensante, il centro decisionale effettivo”. Giuseppe Lombardo è il pm titolare di alcune delle inchieste più delicate condotte contro le cosche di Reggio Calabria, considerate le più potenti dell’intera regione. Al processo “Meta” ha fatto condannare boss del calibro di Giuseppe De Stefano, Pasquale Condello, Giovanni Tegano e Pasquale Libri. Ma le sue indagini affondano le radici anche nei rapporti tra l’organizzazione criminale calabrese e le istituzioni, tra la ‘Ndrangheta e la Massoneria, la politica e l’imprenditoria. Un coacervo di poteri più o meno occulti all’interno di un sistema criminale integrato. Il magistrato, minacciato di morte dalla ‘Ndrangheta, ha istruito altresì il filone calabrese dell’inchiesta sulla Lega nord che ha visto coinvolto l’ex tesoriere Francesco Belsito, ed è tra i titolari dell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola. La prima domanda è necessaria, anche se può sembrare banale. Che significa oggi fare il magistrato antimafia in Calabria? Per risponderle devo partire dalla storia della mia famiglia: sono nato a Reggio Calabria ma ho vissuto sempre nella Locride, fino a quando non ho deciso di andare a studiare fuori sede. -

Bardellino, Infatti, Viene Legalizzato E Si Lega Con Il Gruppo All'epoca
Camera dei Deputati —33— Senato della Repubblica XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Bardellino, infatti, viene legalizzato e si lega con il gruppo all’epoca dominante in Sicilia facente capo a Stefano Bontade. Lo stesso Bardellino, coadiuvato dall’altro diarca del clan Mario Iovine, accresce notevolmente il suo peso quando si schiera all’interno della Nuova Famiglia con una posizione anche di preminenza, nella lotta ai cutoliani. I cutoliani che pure erano riusciti a fare proseliti nel casertano vengono completamente annientati – ad eccezione di pochi soggetti, lasciati confluire nelle fila dei casalesi (si v. il gruppo Di Girolamo di Aversa) ed ad eccezione del gruppo operante in Marcianise e zone viciniori di cui si parlera` – ed il gruppo dei casalesi acquisisce la forza sufficiente per porsi come il principale referente di tutte le organiz- zazioni delinquenziali casertane. Con Bardellino nasce una struttura di tipo confederativo; i clan anche operanti in realta` piu` distanti – si pensi a quelli dell’area mondragonese o sessana – vengono di fatto risucchiati nella struttura unitaria, che pur lasciando una sua autonomia alle singole entita`si organizza con una sorta di cupola, il cui centro e` proprio nel gruppo dei casalesi. L’organizzazione camorristica casertana ruoto`, unita e compatta, intorno alla figura di Antonio Bardellino fino alla fine del 1987. E con Bardellino che il clan opera il salto di qualita` e comincia ad intessere significativi rapporti con il mondo della locale politica e delle istitu- zioni, controllando, ad esempio, le attivita` dei comuni di Casale e di San Cipriano. Ai primi del 1988, inizio`, con l’omicidio di Domenico Iovine, all’interno di essa, un conflitto tra i gruppi egemoni facenti capo ad Antonio Bardellino e a Mario Iovine, che culmino` nell’uccisione di Bardellino, nel maggio del 1988, in Brasile, da parte di Mario Iovine. -

MAFIA and DRUGS Organized Crime and Drug Trafficking in Italy
MAFIA AND DRUGS Organized Crime and Drug Trafficking in Italy FABIO BERNABEI 44th Carnegie seminar 2º WORLD FORUM AGAINST DRUGS Stockholm May 25 2010 TOPICS • Historical origins and characters of: • Cosa Nostra • Camorra • Sacra Corona Unita • ‘Ndrangheta (Calabrian Mafia) • The Fifth Mafia: all roads lead to Rome COSA NOSTRA • "Cosa Nostra" is a Sicilian criminal society. the first document was in 1864, when Niccolò Turrisi Colonna, leader of the Palermo National Guard, wrote of a "sect of thieves" that operated across Sicily. • An 1865 dispatch from the prefect of Palermo first officially described the criminal phenomenon as a "Mafia". • Other than its members, Cosa Nostra makes extensive use of "associates". These are people who work for or aid a clan (or even multiple clans) but are not treated as true members. These include corrupt officials and prospective mafiosi. COSA NOSTRA / 2 Clan hierarchy • For many years, the power apparatuses of the individual clans were the sole ruling bodies within the association, and they have remained the real centers of power even after superordinate bodies were created in Cosa Nostra beginning in the late 1950s (the Sicilian Mafia Commission also known as Commissione). • Protection rackets - Arms trafficking - Loan sharking - Extortion - Control of contracting - Drug trafficking COSA NOSTRA / 3 • Starting in 1975, Cosa Nostra set up heroin refineries across the island. As well as refining heroin, Cosa Nostra also sought to control its distribution. Sicilian mafiosi moved to the United States to personally control distribution networks there. • By 1982, the Sicilian Mafia controlled about 80% of the heroin trade in the north-eastern United States. -
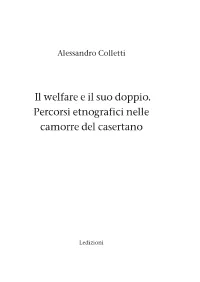
Il Welfare E Il Suo Doppio. Percorsi Etnografici Nelle Camorre Del Casertano
Alessandro Colletti Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Ledizioni © 2016 Ledizioni LediPublishing Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy www.ledizioni.it [email protected] Alessandro Colletti, Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Prima edizione: febbraio 2016 ISBN Cartaceo: 978-88-6705-426-8 Copertina e progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni I ricavi dai diritti d’autore saranno devoluti al Comitato Don Peppe Diana di Casal di Principe Indice Prefazione di Antonio La Spina 5 Introduzione 11 Metodi e fonti 17 Parte Prima. Un’analisi delle forme di egemonia delle mafie: tra controllo e assistenza 27 1. Il controllo territoriale nella storia delle camorre 29 Il riconoscimento istituzionale del potere camorrista 34 Il controllo territoriale nell’area campana 39 2. Forme organizzative e redistributive: la “cassa comune” 49 Le mafie come organizzazioni professionali 50 Il funzionamento della “cassa comune” 53 I capi cambiano, la struttura resta: dal “clan Bardellino-Iovine” al “clan dei casalesi” 63 3. La protezione sociale delle camorre casertane 73 Il clan La Torre 76 Il clan Belforte 82 I clan Schiavone e Bidognetti: alleati, federati, separati 89 Gerarchia e livelli stipendiali: il clan Schiavone 94 Forme di assistenza nei clan del casertano 101 Parte Seconda. Le politiche socio-assistenziali nella provincia di Caserta: un welfare (s)finito 113 1. Analisi delle forme di welfare pubblico: il sistema italiano 115 I territori del welfare: dallo Stato agli enti locali 118 Il livello territoriale dei servizi sociali 123 2. Zona di contatto: servizi alla persona nella provincia casertana 135 La dimensione territoriale dei servizi nella governance regionale 140 Uno sguardo alle pratiche locali di welfare nell’area casertana 143 Il welfare raccontato da chi lo dirige: le interviste ai coordinatori degli Uffici di Piano 148 3. -

CHAPTER I – Bloody Saturday………………………………………………………………
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY SCHREYER HONORS COLLEGE DEPARTMENT OF JOURNALISM ITALIAN WHITE-COLLAR CRIME IN THE GLOBALIZATION ERA RICCARDO M. GHIA Spring 2010 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for a baccalaureate degree in Journalism with honors in Journalism Reviewed and approved by Russell Frank Associate Professor Honors Adviser Thesis Supervisor Russ Eshleman Senior Lecturer Second Faculty Reader ABSTRACT At the beginning of the 2000s, three factories in Asti, a small Italian town, went broke and closed in quick succession. Hundreds of men were laid off. After some time, an investigation mounted by local prosecutors began to reveal what led to bankruptcy. A group of Italian and Spanish entrepreneurs organized a scheme to fraudulently bankrupt their own factories. Globalization made production more profitable where manpower and machinery are cheaper. A well-planned fraudulent bankruptcy would kill three birds with one stone: disposing of non- competitive facilities, fleecing creditors and sidestepping Italian labor laws. These managers hired a former labor union leader, Silvano Sordi, who is also a notorious “fixer.” According to the prosecutors, Sordi bribed prominent labor union leaders of the CGIL (Italian General Confederation of Labor), the major Italian labor union. My investigation shows that smaller, local scandals were part of a larger scheme that led to the divestments of relevant sectors of the Italian industry. Sordi also played a key role in many shady businesses – varying from awarding bogus university degrees to toxic waste trafficking. My research unveils an expanded, loose network that highlights the multiple connections between political, economic and criminal forces in the Italian system. -

De 'Ndrangheta in Nederland
De ’Ndrangheta in Nederland Aard, criminele activiteiten en werkwijze op Nederlandse bodem KLPD - Dienst Nationale Recherche De ’Ndrangheta in Nederland Aard, criminele activiteiten en werkwijze op Nederlandse bodem Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD) Dienst Nationale Recherche Hoofdstraat 54 3972 LB Driebergen Driebergen, juni 2011 Copyright © 2011 KLPD - Dienst Nationale Recherche Copyright Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen, alsmede behoudens voor zover in deze uitgave nadrukkelijk anders is aangegeven, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het KLPD. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), redactie en het KLPD geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen. Inhoud Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Achtergrond 13 1.3 Doelstelling 14 1.4 Leeswijzer 14 2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 15 3 Methoden van onderzoek 16 3.1 Deskresearch 16 3.1.1. Politiebronnen 16 3.1.2. Open bronnen 19 3.2 Interviews 20 3.3 Definiëring en operationalisering van begrippen 21 4 De achtergrond van de ’Ndrangheta 25 4.1 Organisatiekenmerken van de ’Ndrangheta 25 4.1.1. Bloed- en regiobanden, inwijding en rangen 27 4.1.2. Structuur en bestendigheid 32 4.2 Internationale spreiding 35 4.2.1. Samenwerking met andere criminelen, clans en maffiaorganisaties 36 4.2.2. Geografische spreiding 37 5 Aard van de ’Ndrangheta in Nederland 42 5.1. -

Contemporary Archaeological Looting: a Criminological Analysis of Italian Tomb Robbers
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2-2018 Contemporary Archaeological Looting: A Criminological Analysis of Italian Tomb Robbers Marc Balcells Magrans The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/2538 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] CONTEMPORARY ARCHAEOLOGICAL LOOTING: A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF ITALIAN TOMB ROBBERS by MARC BALCELLS MAGRANS A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Criminal Justice in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2018 ©2018 MARC BALCELLS All Rights Reserved ii This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Criminal Justice in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Dr. Jana Arsovska January 11, 2018 Chair of Examining Committee Dr. Deborah Koetzle January 11, 2018 Executive Officer Dr. Jana Arsovska Dr. Rosemary Barberet Dr. Roddrick Colvin Supervisory Committee iii THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK Abstract CONTEMPORARY ARCHAEOLOGICAL LOOTING: A CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF ITALIAN TOMB ROBBERS by Marc Balcells Magrans Chair: Dr. Jana Arsovska Looters (in Italian, tombaroli), whether underground or underwater, have preyed on the Italian archaeology for centuries. The literature on both archaeological looting and, more specifically, the Italian case, has been widely developed by other disciplines, mostly archaeology. -

Ribellarsi a Rosarno: La Costruzione Di Una Nuova Cultura Civile Nella Piana Di Gioia Tauro
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E ISTITUZIONI EUROPEE RIBELLARSI A ROSARNO: LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CULTURA CIVILE NELLA PIANA DI GIOIA TAURO Elaborato finale di: Claudio Campesi Relatore: Prof. Fernando dalla Chiesa Anno accademico: 2014/2015 1 INDICE INTRODUZIONE .......................................................................................................... 3 CAPITOLO 1- IL CASO VALARIOTI .................................................................... 6 1.1 UNA BREVE PANORAMICA DELL‟EVOLUZIONE STORICO-ECONOMICA DI ROSARNO E L‟ASCESA DELLA „NDRANGHETA LOCALE DALL‟ „800 AGLI ANNI ‟60 DEL „900. ............................................................................................ 6 1.2 GIUSEPPE VALARIOTI: DAL QUARTIERE COREA ALL‟IMPEGNO POLITICO .................................................................................................................... 12 1.3 MUTAMENTO DELLA „NDRANGHETA CALABRESE NEGLI ANNI 70-80: IL SALTO DI QUALITA‟. ........................................................................................... 17 1.4 “SE VOGLIONO INTIMIDIRCI NON CI RIUSCIRANNO, I COMUNISTI NON SI PIEGHERANNO MAI”: LOTTE POLITICHE DI GIUSEPPE VALARIOTI. ...... 28 1.5 ELEZIONI, OMICIDIO E GIUSTIZIA NEGATA. ............................................... 40 CAPITOLO 2- GIUSEPPE LAVORATO: IL SINDACO DELLA “PRIMAVERA DI ROSARNO” .............................................................................. 50 2.1 IL RINNOVATO IMPEGNO ANTIMAFIA ......................................................... -

Facilitating the Italian Mafia: the Grey Zone of Complicity and Collusion
South European Society and Politics ISSN: 1360-8746 (Print) 1743-9612 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/fses20 Facilitating the Italian Mafia: The Grey Zone of Complicity and Collusion Felia Allum, Rossella Merlino & Alessandro Colletti To cite this article: Felia Allum, Rossella Merlino & Alessandro Colletti (2019): Facilitating the Italian Mafia: The Grey Zone of Complicity and Collusion, South European Society and Politics, DOI: 10.1080/13608746.2019.1575563 To link to this article: https://doi.org/10.1080/13608746.2019.1575563 Published online: 20 Feb 2019. Submit your article to this journal Article views: 14 View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=fses20 SOUTH EUROPEAN SOCIETY AND POLITICS https://doi.org/10.1080/13608746.2019.1575563 Facilitating the Italian Mafia: The Grey Zone of Complicity and Collusion Felia Allum, Rossella Merlino and Alessandro Colletti ABSTRACT KEYWORDS Despite structural and operational differences, Italian mafias Organised crime; Italy; share an ability to expand and infiltrate global economies whilst Camorra; ‘Ndrangheta; Cosa remaining rooted within their local territory. They are not only Nostra; facilitators the product of specific socio-economic and political conditions but also of the extensive complicity on which they can count. It is this fertile ‘grey zone’ of mafia relations with accomplices identi- fied as enablers, facilitators, sponsors and helpers that is ana- lysed here. Engaging with the existing literature and using a range of new judicial sources, including evidence from mafia trials, this article develops in-depth case studies to identify and examine the hidden face of Italian mafias. -

Italian Organised Crime
Europol Public Information THREAT ASSESSMENT ITALIAN ORGANISED CRIME The Hague, June 2013 FILE NO: EDOC#667574 v8 This Europol product analyses and evaluates the threat posed by types of serious or organised crime. The assessment of threats is based on defined indicators. Page 1 of 18 Table of Contents 1 KEY JUDGEMENTS ................................................................................................. 3 2 INTRODUCTION .................................................................................................... 4 2.1 BACKGROUND .............................................................................................. 4 2.2 AIMS AND OBJECTIVES .................................................................................... 4 3 ITALIAN ORGANISED CRIME: COMMON FEATURES ............................................... 5 3.1 FAMILY ...................................................................................................... 5 3.2 POWER ...................................................................................................... 5 3.3 RESPECT .................................................................................................... 7 3.4 TERRITORY .................................................................................................. 7 4 SICILIAN MAFIA ................................................................................................... 9 5 CALABRIAN ‘NDRANGHETA ................................................................................. 10 6 NEAPOLITAN CAMORRA -

Atti Parlamentari - 129 - Camera Dei Deputati
Atti Parlamentari - 129 - Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. IV N. 12 dichiarazioni rilevanti. Caterino Giacomo è figlio di Caterino Paolo, cugino di lovine Antonio. Egli è un imprenditore di San Cipriano che ha ricoperto delle cariche elettive di rilievo. E’ stato, infatti, un consigliere comunale in San Cipriano d’Aversa, è stato successivamente (dalFaprile 2006) un consigliere provinciale di Caserta ed è stato un esponente significativo in terra casertana del partito politico UDEUR. Egli ha deciso di collaborare con la giustizia a seguito dell’ordine di carcerazione che gli è stato notificato recentemente. • - - . • Il vaglio di credibilità intrinseca del suo racconto è pertanto molto positivo. Collaboratore di giustizia Caterino Giacomo, interrogatorio del 9 aprile 2015: • A.D.R, Conosco Giuseppe FONTANA alias “Pino" da circa IO ami, è un imprenditore di Casapesenna, ho avuto modo scambiare con lui alcuni convenevoli relativi in genere alla politica. Non ho conoscenza diretta sulla sua vicinanza o meno al clan Zagaria. L'ho incontrato quattro o cinque volte nell ‘arco di quattro o cinque anni. Di recente l ’ho incontrato a Caserta. Egli è un imprenditore di Casapesenna. A.D.R. In relazione al ciclo**integrato delle acque della Regione Campania posso riferire che ' .• conosco le questioni attinenti a tale argomentazione in quanto riferitemi da terze persone . Iprincipalmente Fontana Giuseppe), poiché poco interessato all’affare. Tali notizie me le passò il . signor Luciano LICEN2A , imprenditore di San Cipriano, consigliere comunale di San Cipriano, il quale mi informò delle disponibilità di fondi per tali lavori. Ricordo la figura di Tommaso BARBATO, all'epoca consigliere Regionale divenuto successivamente Senatore della Repubblica , il quale era molto vicino a Giuseppe FONTANA e tali informazione la dico c’on certezza dato che li ho visti-personalmente mentre erano insieme a fare degli acquisti nel negozio D ’Anna di Caserta.