Per Leggere Il Libro, Scaricalo Nel Formato
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

200 MOMENTI FOTOGRAFICI DEL “TOUR” 1949. Didascalie Di Emilio De Martino
n. 1 200 MOMENTI FOTOGRAFICI DEL “TOUR” 1949. Didascalie di Emilio De Martino. Selezione fotografica di Ghea. Milano, La Gazzetta Dello Sport, 1949. Album in-16 p. (mm. 170x235), brossura edit. illustrata a colori, frontespi- zio, con 200 bellissime fotografie in seppia che immortalano i momenti più importanti del “Tour de France” 1949 (trentaseiesima edizione della “Grande Boucle”) che si svolse in 21 tappe, tra il 30 giugno e il 24 luglio 1949, su un percorso di complessivi 4808 km. Fu vinto per la prima volta dal passista-cro- noman e scalatore italiano Fausto Coppi. Ben conservato. € 120 n. 2 50° GIRO CICLISTICO D’ITALIA. Collezione completa degli annulli postali relativi alle tappe. A cura della F.D.C. “Roma”. 1967. Album oblungo (mm. 110x190) in similpelle contenente una raccolta comple- ta di 23 buste a colori, con francobolli e relativi annulli postali, dalla prima all’ultima tappa del Giro d’Italia del 1967 (20 Maggio - 11 Giugno): Treviglio Milano. Le tappe sono in effetti 22 + una 22bis, semitappa conclusiva da Ma- donna del Ghisallo a Milano. Inoltre nella ns. raccolta la busta della 15a tappa è doppia (una ha 3 francobolli invece di 1 da lire 40). In ottimo stato. € 220 n. 3 A UMBERTO DEI - NELL’ANNO IX DI SUA PRESIDENZA, I VETE- RANI CICLISTI ITALIANI CON AFFETTO. 25 Ottobre 1931 - Anno IX E.F. Milano, Unione Veterani Ciclisti Italiani, 1931. In-8 gr., brossura edit. figu- rata, legata con cordoncino, pp. 71, con ill. fotografiche in b.n. nel t. Il volume contiene un profilo di Umberto Dei (dapprima corridore ciclista, poi produttore di perfette biciclette da corsa) e una serie di lettere con le quali personaggi del ciclismo ricordano episodi vissuti con lui. -

Federico Meda Giovanni Tarello Daniele Cerino Federico Meda “Ten Years Ago the Gazzetta Had No Record of Who Had the Pink Jerseys, Where They Were, Anything
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX FEDERICO Meda GiovaNNI TARELLO DANIELE CERINO Federico Meda “Ten years ago the Gazzetta had no record of who had the pink jerseys, where they were, anything. The initiative has its origins in a discussion with the late Fiorenzo Magni, who was patron of the Ghisallo Cycling Museum. Ultimately they asked me whether if it might be possible to start searching for them, with a “XXXXXX XXXXX XXXX view to trying to conserve the heritage of the race. XXXXXX XXXXXX XXXXX “Initially we thought about trying to buy XXXXXX XXXXXXX them, but that was problematical in the sense that it would have exposed us to speculation, XXXXX XXXXXX XXXXX and also to potential fraud. We therefore XXXXXXX” decided that it would be better if we made a €500 donation to the cycling museum at Ghisallo for each one we managed to acquire. That way we contribute to the preservation autobiography than Ivan Basso’s…” of the jerseys, and also to the heritage of the Giovanni Tarello is a writer and cycling race itself. The point is that the Giro belongs historian. He has precisely 914 books about the to everybody, and in that sense so too do the sport, the overwhelming majority extremely jerseys. rare. In addition he’s written ten books of his “The process of trying to uncover them own about Italian bike racing history. Amongst can be frustrating, but it’s never less than them are biographies of Giancarlo Astrua and fascinating. The joy of finding them is the great Francesco Camusso, winner of the immense, as you can imagine. -

Aiutateci a Combattere La Pedofilia
27COM01A2710 ZALLCALL 11 21:20:43 10/26/97 Lunedì 27 ottobre 1997 12 l’Unità LE LETTERE UN’IMMAGINE DA... INIZIATIVA VERDE lo di professionalità di questo di guerra, fame e sofferenze, di in Italia viene molto spesso tra- ufficio, sta consentendo ad un privazioni di libertà positive e scurato. Le scrivo questa mia Una moratoria fronte sempre più ampio di poli- negative. Al di là dunque delle lettera nella speranza che que- tici di riprendere gli attacchi situazioni pensionistiche «pato- sta posa servirLe per attuare ri- per gli ipermercati contro una magistratura colpe- logiche» non mi sembra il caso medi per una località che si sta Non pochi commercianti della vole soltanto di indagare senza di infierire sui pensionati: gene- letteralmente sfaldando. Nella zona sud di Firenze si sono mo- fare sconti a nessuno.Una nuo- ralizzare vuol dire fare in modo provincia di Messina vi è la fa- bilitati, di recente, contro il pro- va normativa sui pentiti è certa- che i «piglianiente» di ieri di- mosa località di Taormina la getto di un ipermercato nell’aria mente necessaria, ed i primi ad vengano oggi «piglianiente al quale è, per l’appunto, caratte- «ex Longinotti». Da anni, infat- ammetterlo sono proprio i giu- quadrato». S’accorgerà che di- rizzata dalla presenza di una ti, proprio in quell’aria, in viale dici delle procure, ma dai recen- scettare sullo stato sociale è cosa spettacolare isoletta incastona- Giannotti, il Cpa «Firenze sud» ti fatti di cronaca che hanno molto diversa che partire da pur ta in un golfo che regala un rappresenta un punto di riferi- avuto come protagonisti alcuni nobili enunciazioni teoriche, paesaggio che, come già diceva mento per molti cittadini; la sua cosiddetti pentiti, non si può ri- peraltro assecondando un vezzo Guy de Maupassant nel 1889, intensa attività culturale non cavare l’azzeramento del contri- molto comune a certa destra po- «Seduce gli occhi, la mente e la conosce soste: incontri, concer- buto fondamentale offerto da litica nell’epoca della «parlata» e fantasia». -

1. Místo 1903 Maurice Garin 1904 Henri Cornet 1905 Louis Trousselier 1906 René Pottier 1907 Lucien Petit-Breton 1908 Lucien Pe
VÍT ĚZOVÉ TOUR DE FRANCE 1. místo 2. místo 3. místo 1903 Maurice Garin Lucien Pothier Fernand Augereau 1904 Henri Cornet Jean-Baptiste Dortignacq Alois Catteau 1905 Louis Trousselier Hyppolite Aucouturier Jean-Baptiste Dortignacq 1906 René Pottier Georges Passerieu Louis Trousselier 1907 Lucien Petit-Breton Gustave Garrigou Emile Georget 1908 Lucien Petit-Breton François Faber Georges Passerieu 1909 François Faber Gustave Garrigou Jean Alavoine 1910 Octave Lapize François Faber Gustave Garrigou 1911 Gustave Garrigou Paul Duboc Emile Georget 1912 Odile Defraye Eugene Christophe Gustave Garrigou 1913 Philippe Thys Gustave Garrigou Marcel Buysse 1914 Philippe Thys Henri Pélissier Jean Alavoine 1919 Firmin Lambot Jean Alavoine Eugene Christophe 1920 Philippe Thys Hector Heusghem Firmin Lambot 1921 Léon Scieur Hector Heusghem Honoré Barthelemy 1922 Firmin Lambot Jean Alavoine Félix Seller 1923 Henri Pélissier Ottavio Bottecchia Romain Bellenger 1924 Ottavio Bottecchia Nicolas Frantz Lucien Buysse 1925 Ottavio Bottecchia Lucien Buysse Bartolomeo Aimo 1926 Lucien Buysse Nicolas Frantz Bartolomeo Aimo 1927 Nicolas Frantz Maurice Dewaele Lucien Vervaecke 1928 Nicolas Frantz André Leducq Maurice Dewaele 1929 Maurice Dewaele Giuseppe Pancera Jef Demuysere 1930 André Leducq Learco Guerra Antonin Magne 1931 Antonin Magne Jef Demuysere Antonio Pesenti 1932 André Leducq Kurt Stoepel Francesco Camusso 1933 Georges Speicher Learco Guerra Gius eppe Martano 1934 Antonin Magne Giuseppe Martano Roger Lapébie 1935 Romain Maes Ambrogio Morelli Félicien Vervaecke -

Alla Scoperta Del Giro D'italia
ALLA SCOPERTA DEL GIRO D’ITALIA IL GIRO D’ITALIA E BICISCUOLA Il Giro d’Italia è una corsa a tappe di ciclismo su strada che ogni anno, a partire dal 1909, attraversa il nostro paese nel mese di maggio. Il Giro però è qualcosa di più di un evento sportivo. È un’avventura lunga 23 giorni, che vede i suoi protagonisti (ciclisti, tifosi, giornalisti) darsi appuntamento sulle strade d’Italia per vivere assieme una grande emozione. Un’emozione rosa! BICISCUOLA è un progetto che promuove il Giro d’Italia tra i giovanissimi. In 13 anni, Biciscuola ha insegnato, divertito e incoraggiato l’utilizzo della bicicletta per uno stile di vita sano oltre 1.2 milioni di giovani italiani, assegnando premi e riconoscimenti al Giro ad oltre 22 mila ragazzi. Questa guida, che avete ricevuto grazie all’adesione della vostra classe a BiciScuola, vuole accompagnarvi alla scoperta del magico mondo del Giro d’Italia e della bicicletta in generale. Siete pronti per seguirci assieme in questo viaggio? Allacciate il casco, trattenete il fiato e girate la pagina. Inizia l’avventura! E per ogni dubbio o curiosità…non esitate a contattarci! Segreteria BiciScuola, Casella Postale n° 692 - 43123 Parma Telefono: 0521/1813823 - Fax: 0521/1812572 E-mail: [email protected] - Sito internet: www.biciscuola.it 1 03 I VALORI DEL GIRO Il Giro d’Italia è un grande evento di sport che 04 IL TROFEO SENZA FINE porta con sé alcuni valori molto importanti: 05 LA MAGLIA ROSA E LE ALTRE MAGLIE VALORI 06 I CAMPIONI DEL GIRO 08 LA STORIA DEL GIRO DEL GIRO 09 I MOMENTI PIÙ BELLI DEL -

La Ricerca Della Verità
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere La ricerca della verità a cura di Piero de Gennaro 2010 Università degli Studi di Torino Trauben In copertina, una ‘rosa dei venti’ nell’Atlante catalano di Carlo V di Francia, pergamena miniata a Maiorca nel 1375 circa, attribuita a Abraham Cresques (Parigi, Bibliothèque Nationale de France, MS Espagnol 30) © 2010 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Trauben editrice, via Plana 1 – 10123 Torino www.trauben.it ISBN 9 78-88-89909-829 Ti ho già detto perché io creda tu abbia meritato di avere creato qualcosa: non ti sei inchinato ai potenti del giorno ed hai seguito la via della verità. Nessuno sa quale sia la verità vera; sappiamo solo che essa non è quella che è comandata. Qualunque sia in avvenire la costituzione della nostra società, procura coll’opera tua d’oggi di preservare, nella lettera e nello spirito […], il bene supremo della li- bertà di negare la verità ufficiale, […] di cercare dappertutto la parola di verità, la parola di chi scrive come pensa, anche se quella parola è diversa ed opposta a quella di chi comanda. Luigi Einaudi (lettera del 17 agosto 1944 al figlio) 3 Indice Gerhard FRIEDRICH Georg Büchner zwischen Daseinsethos und Geschichtspessimismus 7 Lucia FOLENA Il pentangolo d’oro. Giochi di verità in Sir Gawain and the Green Knight 19 Valerio FISSORE Agency and Some Related Matters 33 Elisa ARMELLINO Studying Cohesion and Text-Types Through Corpora 43 Paola BRUSASCO Toy Soldiers: Children in Search of Visibility on the Sri Lankan Literary Scene 57 Maria Margherita MATTIODA Le “belle verità”. -

Vainqueurs D'étapes Du Tour D'italie (Le Giro)
Vainqueurs d'étapes du Tour d'Italie (Le Giro) Vainqueurs d'étapes du Tour d'Italie (Le Giro) depuis 1909. Etapes du 08/05 au 30/05/2021 1 Torino - Torino, 8.6 km C.M.Individuel 2 Stupinigi - Novara, 179 km 3 Biella - Canale, 190 km 4 Piacenza - Sestola, 187 km 5 Modena - Cattolica, 177 km 6 Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno, 160 km 7 Notaresco - Termoli, 181 km 8 Foggia - Guardia Sanframondi, 170 km 9 Castel di Sangro - Campo Felice, 158 km 10 L'Aquila - Foligno, 139 km 11 Perugia - Montalcino, 162 km 12 Siena - Bagno di Romagna, 212 km 13 Ravenna - Verona, 198 km 14 Cittadella - Monte Zoncolan, 205 km 15 Grado - Gorizia, 147 km 16 Sacile - Cortina d'Ampezzo, 153 km 17 Canazei - Sega di Ala, 193 km 18 Rovereto - Stradella, 231 km 19 Abbiategrasso - Alpe di Mera, 176 km 20 Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 km 21 Milano - Milano, 30.3 km C.M.Individuel 1ère étape. 1er Filippo Ganna (Ita) C.M.Individuel 2ème étape. 1er Tim Merlier (Bel) 3ème étape. 1er Taco Van Der Hoorn (Hol) 4ème étape. 1er Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) 5ème étape. 1er Caleb Ewan (Aus) 6ème étape. 1er Gino Mäder (Sui) 7ème étape. 1er Caleb Ewan (Aus) 8ème étape. 1er Victor Lafay (Fra) 9ème étape. 1er Egan Arley Bernal Gomez (Col) 10ème étape. 1er Peter Sagan (Svq) 11ème étape. 1er Mauro Schmid (Sui) 12ème étape. 1er Andrea Vendrame (Ita) 13ème étape. 1er Giacomo Nizzolo (Ita) 14ème étape. 1er Lorenzo Fortunato (Ita) 15ème étape. 1er Victor Campenaerts (Bel) 16ème étape. -

Claudio Pacifico
Claudio Pacifico Gender: Male Service: +393397052806 Height: 5 ft. 1 in. E-mail: info@stuntconceptacademy... Weight: 158 pounds Web Site: http://www.claudiopa... Birthdate: 05/09/1963 Hair Length: Regular Waist: 32 Inseam: 30 Shoe Size: no info Physique: Athletic Coat/Dress Size: 40 Ethnicity: Mediterranean Photos Film Credits Pirates of the Caribbean - on stunt double Paul Bazely Rob Marshall / George Marshall strange tides Rouge, Greg Powell Prince of Persia Sands of time Assansin Porcupine Mike Newell / G.A. Aguilar, Greg Powell Angels & Daemons stunt driver Ron Howard / Brad Martin Dhulm, years of torment Stunt coordinator Najdat Anzour Mission Impossible III Stunt Coordinator Italy J.J. Abrams / Vic Armstrong Body of lies double Ali Suliman Ridley Scott / G.A. Aguilar Gangs of New York Stunt coordinator Italy - double DD Martin Scorsese / G.A. Aguilar Lewis U-571 Stunt Coordinator Italy Jonathan Mostow / Pat Romano Casanova double Heath Ledger Lasse Hallstrom / Bill Hobbs Cutthroad Island double Geena Davis Renny Harlin / Vic Armstrong The talented Mr Ripley double Jude law Anthony Minghella 007 tomorrow never dies stunt double Roger Spottiswoode / Vic Armstrong Che - part II - Guerrilla stunt double Steven Soderberg / G.A. Aguilar Generated on 09/25/2021 07:23:05 pm Page 1 of 9 Michael Lehmann / Charlie Picerni Ladyhawke stunt performer Richard Donner / Richard Graydon The godfather part III stunt performer F.F. Coppola / Buddy Joe Hooker The jewel of the Nile stunt performer - double Avner Lewis Teague / Glenn Randall Eisenberg -
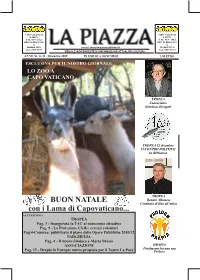
Gianluca Giorgetti
VIBO VALENTIA VIBO VALENTIA E PROV. E PROV. F. M. 93.9 - 106.1 F. M. 93.9 - 106.1 REP. PUBBLICITA’ REP. PUBBLICITA’ & & MARKETING e-mail: [email protected] MARKETING TEL. 0963-45733 TEL. 0963-45733 MENSILE INDIPENDENTE DI INFORMAZIONE-ATTUALITA’-CULTURA ANNO XI n. 11 Dicembre 2009 IN EDICOLA OGNI MESE 1,00 EURO ESCLUSIVA PER IL NOSTRO GIORNALE LO ZOO A CAPO VATICANO TROPEA Conosciamo Gianluca Giorgetti TROPEA 12 dicembre INCONTRO POLITICO In Biblioteca TROPEA BUON NATALE Renato Albanese Centinaia di film all’attivo con i Lama di Capovaticano... ALL’INTERNO: TROPEA Pag. 3 - Inaugurata la TAC al nosocomio cittadino Pag. 9 - La Protezione Civile: cercasi volontari Pag.4-Comune: pubblicato il piano delle Opere Pubbliche 2010/12 PARGHELIA Pag. 4 - Il nuovo Sindaco è Maria Brosio ASSOCIAZIONI DRAPIA Finalmente ha una sua Pag. 15 - Drapia in Europa: nuove proposte per il Teatro La Pace Proloco Pag. 2 - dicembre 2009 - Attualità- LA PIAZZA ESCLUSIVA PER IL NOSTRO GIORNALE GIANLUCA GIORGETTI “Uomo di cultura ed artista capace ed originale” di Daniela Ciccarelli Nato a Roma nel 1955. Nel 1982 si è diplomato con il massimo dei voti presso l'Accademia di Belle arti di Vi t e r b o . L a c o n o s c e n z a anatomica gli deriva anche da e s a m i s o s t e n u t i p r e s s o l'Università degli studi di Bologna, tanto da essere chiamato all'insegnamento di anatomia artistica presso l'Accademia di belle arti di Urbino nel 1983.; in quell'anno è stato chiamato, con regolare contratto, dal Presidente della Biennale di Venezia, Paolo Portoghesi, a prestare la sua collaborazione per ricerche bio-bibliografiche ed iconografiche per la preparazione della 41^ Biennale d'Arte inaugurata nel giugno del 1984. -

The Giro Type — Specimen
Type Specimen / T-Star Pro Version 3.0, 2012 60 Pt. The Giro Type — Specimen binnenland.ch Passo Stelvio / Historic climb of the Giro d’italia 3 The nicknames / T-Star Pro Heavy The first Giro d’Italia / T-Star Pro Regular 60 Pt. 12 Pt. 1909, the first Giro d’Italia. On May 13, 1909, the Giro’s first peloton of 127 riders (41 of the enrollees didn’t show up) met at the Piazzale Loreto in downtown Milan where La Gazzetta’s offices Red Devil, were situated. The eight-stage race went from Milan to Bologna and onward to Chieti, Naples, Rome, Florence, Genoa and Turin, returning to Milan on the 30th. Riders would cover 2,445 kilometers over eight stages, an average stage length of 306 kilometers, the Fist, not far from the Tour’s average. This was to be the shortest Giro ever. It should be noted that in the early years of bike racing distances were approximate. The various lengths we have for the first Giro, 2408, 2448, and 2445 kilometers—each from a dif- ferent but respected Italian writer—are all within the expected and the range of accuracy of the age. To minimize cheating and confusion, each of the riders was King of Mud photographed at the start for later comparison by the judges. Just as in the first couple of editions of the Tour, the Giro would allow several days of recovery between each stage. The riders faced roads that could only be described as menacing, especially in economically disadvantaged southern Italy. -

ECCELLENZE ITALIANE. III. Giro D'italia. Di Rinaldo ROSSINI
ECCELLENZE ITALIANE. III. Giro d'Italia. Di Rinaldo ROSSINI. INDICE GENERALE. 0. Storia anni 1909 – 1930. i pionieri del ciclismo. 1. Storia anni 1931 – 1955. l'epoca d'oro Coppi- Barali. 2. Storia anni 1956 – 1978. il dominio stranero di Merckx e Gimondi. 3. Storia anni 1979 – 1990. il dualismo Saronni- Moser, e l'arrivo di Hinault. 4. Storia 1991 – 1999. da Chiappucci a Induran a Pantani e Gotti. 5. Storia 2000 – 2010. gli anni di Simoni, Savoldelli, Basso. 6. Storia 2011 – 2016. gli anni di Contator e Nibali. 7. Maglie e Trofei. 8. Percorso. 9. Organizzazioni e Podi. LA MAGNIFICA STORIA DEL GIRO D'ITALIA. Informazioni. Ciclismo su strada. Gara Individuale. Organizzazione: RCS sport. Annuale. Corse a tappe. È una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada si svolge lungo, le strada italiane con cadenza annuale. Occasionalmente il percorso può interessare località al di fuori dai confini italiani. Il giro è una delle 3 corse più importanti del calendario dell'Unione Ciclistica Internazionale insieme al Tuor di Francia e alla Vuelta di Spagna. Il record di vittorie è condiviso da tre ciclisti ognuno con 5 vittorie l'italiano Alfredo BINDA anni 1925- 1933. Fausto COPPI. Anni 1940 – 1953. Eddy MERCKX anni 1968 – 1974. record di tappe vinte. 42 Mario CIPOLLINI. Secondo per tappe vinte a quota 41 Alfredo BINDA. La nascita del GIRO venne formalizzata con un annuncio sulla Gazzetta dello Sport nel 1908 con la promessa di 25000 lire di premio al vincitore e la volontà di organizzare una delle prove più ambite e maggiori del ciclismo internazionale. -

Nuovo INV Ugo Pirro
Sheet1 FASCICOLO ESTREMI BUSTANumerazione PEZZI TIPOLOGIA TITOLO FILM TITOLO ROMANZO TITOLO ALTRO TITOLO AMBITI E CONTENUTO CRONOLOGICI provvisoria Colpita da improvviso Sceneggiatura ds., rilegata, pp. 276. Presenti note 1 1.0001 1 SCRIPT Mercati Generali [1975] benessere, 1975 ms. Colpita da improvviso Trattamento ds., carte sciolte, pp. 208. Presenti 1 1.0002 1 SCRIPT Mercati Generali [1975] benessere, 1976 note ms. Colpita da improvviso Trattamento ds., rilegato, pp. 84. Presenti 1 1.0003 1 SCRIPT Mercati Generali (trattamento) [1975] benessere, 1977 annotazioni ms. sul frontespizio. Colpita da improvviso Soggetto di Barbara Alberti e Amedeo Pagani, ds., 1 1.0004 1 SCRIPT Storia Mercati Generali [1975] benessere, 1978 rilegato, pp. 71. Colpita da improvviso Soggetto di Barbara Alberti e Amedeo Pagani, ds., 1 1.0005 1 SCRIPT Mercati Generali [1975] benessere, 1979 rilegato, pp. 64. Colpita da improvviso Appunti, descrizione scene e dialoghi ms.; scaletta 1 1.0006 3 SCRIPT Mercati Generali (originali) [1975] benessere, 1980 ds. e ms.. Soggetto ds., rilegato, pp. 69. Annotazione ms. sul 1 1.0007 1 SCRIPT INEDITI Furti e rapine con brio e amore frontespizio: “1° stesura”. Presenti note ms. e carte sciolte ms.. Soggetto ds., pp. 56. Presenti note ms. e carte 1 1.0008 1 SCRIPT INEDITI Furti e rapine con brio e amore sciolte ms.. (Furti e rapine con brio e amore) 1 1.0009 1 SCRIPT INEDITI Soggetto ms., pp. 37. Originali Piccolo pene Bozza di sceneggiatura, carte sciolte ms. e ds., cc. 2 2.0010 1 SCRIPT INEDITI [1974] (originali) 192. [Paolo Barca, maestro Scaletta, soggetto e trattamento; carte sciolte ms.