“BRAVA GENTE” Alcune Considerazioni Tratte Dai Libri Di
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
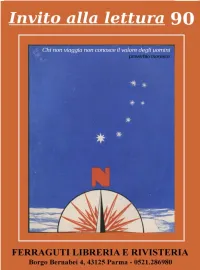
Fn000030.Pdf
1) Viaggi ed esplorazioni- 205 2) Collana Paravia Viaggi- 226 3)Collana Alpes Viaggi- 240 4) Ebraismo- 390 5) Colonialismo Fascista- 513 6) L'Illustrazione Italiana- 522 7) Storia- 546 8) Fascismo- 609 9) Spionaggio- 626 10) Letteratura italiana- 635 11) Letteratura straniera- 648 12) Il Corriere dei Piccoli-658 13) Libri per Ragazzi-693 14) Sport- 701 15) Arte-727 Le immagini di tutti i libri proposti in questo catalogo ( e molti altri) sono disponibili nella sezione RICERCA del sito www.ferraguti.it , continuamente aggiornato, che vi invitiamo a visitare. Preghiamo i gentili clienti di comunicarci l'indirizzo email, al fine di poter inviare, qualora lo gradissero, comunicazioni e cataloghi intermedi rispetto alle "classiche" pubblicazioni trimestrali. Siamo sempre interessati all'acquisto di intere biblioteche e partite o blocchi di libri, riviste e stampe d'epoca, saremo grati a chi ci fornirà opportune segnalazioni. FERRAGUTI SERVICE s.a.s. di Ferraguti Ivo & C. Borgo Bernabei 4 - 43125 Parma Tel. e Fax 0521-286980- [email protected] [email protected] P. IVA 01779470341- C.C.I.A.A. PR Reg. Ditte n. 177878 Iscrizione Tribunale di Parma n. 22291 Conto Corrente Postale n. 11724432 Catalogo numero 90- I semestre 2013- Gennaio,Febbraio, Marzo 2013 Editore: Ferraguti Service s.a.s. (Responsabile Ivo Ferraguti) Tipografie Riunite Donati - Borgo Santa Chiara 6- 43125 Parma 2 Albertini Gianni, ALLA RICERCA DEI NAUFRAGHI DELL'"ITALIA". mille kilometri sulla banchisa., Libreria d'Italia, Milano, 1929, 8o, brossura e sovracoperta., bs.,seconda ediz., pp. 165. La spedizione Nobile. Con numerose e bellissime foto. € 31,00 3 Albieri Adele, CRISTOFORO COLOMBO alla scoperta dell'America., Paravia G.B. -

Università Di Pisa
UNIVERSITÀ DI PISA SCUOLA DI DOTTORATO IN STORIA, ORIENTALISTICA E STORIA DELLE ARTI CICLO XXIII GLI ITALIANI NELL’ERITREA DEL SECONDO DOPOGUERRA 1941 – 1952 Candidato: Dott. Nicholas Lucchetti Tutor: Chiar.mo Prof. Marco Lenci SSD: M – STO/04 Anno accademico 2010 – 2011 1 INDICE Abbreviazioni, p. 4 Ringraziamenti, p. 6 Introduzione, p. 7 Capitolo 1. L’Amministrazione militare britannica dell’Eritrea, p. 13 1.1 La struttura del governo d’occupazione e i rapporti con gli italiani, p. 13 1.2 “L’Informazione” (1941), p. 17 1.3 L’“Eritrean Daily News” – “Il Quotidiano eritreo”, la politica britannica nei confronti degli eritrei e le contraddizioni del mantenimento in servizio degli italiani, p. 21 1.4 La PAI durante l’Amministrazione britannica, p. 29 1.5 La Guardia di Finanza durante l’Amministrazione britannica, p. 31 1.6 L’Arma dei Carabinieri durante l’Amministrazione britannica, p. 35 Capitolo 2. La politica tra gli italiani d’Eritrea, p. 39 2.1 Il movimento antifascista, il GUI e l’Amministrazione britannica. 1941 – 1943, p. 39 2.2 1944. La fondazione del CLN e del PDCI, il caso Del Giudice, p. 56 2.3 “Resistenti”, guerriglieri e fascisti d’Eritrea 1941 – 1945, p. 66 2.4 1946. La sospensione di “Voci di casa nostra”, il referendum istituzionale, “La Repubblica” ed il “Corriere di Asmara” di Franco Pattarino, p. 85 2.5 1947. La sospensione del “Corriere di Asmara”, la nascita del CRIE, lo sciopero degli operai dell’ARAMCO, la crisi del CRIE, “Ficcanaso”, l’MSI “eritreo”, p. 96 2.6 1948. La manifestazione per l’eccidio di Mogadiscio. -

Fondo Lasagni
FONDO GUERRINO LASAGNI BL B 1 ANT *Viaggio nei Bogos / O. Antinori ; con prefazione del march. prof. Giacomo Antinori. - Roma : Societa' Geografica Italiana, 1887. - 162 p. : ill. ; 22 cm. ((Estr. da: Boll. della società geografica italiana (1887), giugno e segg. N.Inv: LAS 207 BL B 1 APP La *sfinge nera : dal Marocco al Madagascar / Mario Appelius. - Milano : Alpes, 1926. - 414 p. ; 20 cm. N.Inv: LAS 250 1 AFRICA - Descrizioni e viaggi BL B 1 ARC *Quando ero medico in Africa / Gaetano Arcoleo. - Bologna : L. Cappelli, 1936. - 180 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm. ((L. 10. N.Inv: LAS 191 BL B 1 BEL La *cittadella di Allah : viaggio nell'Arabia Saudita / Felice Bellotti. - Milano : Cino del Duca, [1960]. - 235 p., [24] c.di tav. : ill. ; 21 cm . N.Inv: LAS 160 1 Arabia Saudita - Descrizioni e viaggi BL B 1 BIA *Esplorazioni in Africa di Gustavo Bianchi / memorie ordinate e pubblicate dal dottor Dino Pesci. - Milano etc.! : F. Vallardi, 1886?!. - VIII, 323 p., 1! c. di tav., 1! c. di tav. ripieg. : ritr., c. geogr. color. ; 19 cm. ((Data dalla prefaz. N.Inv: LAS 226 BL B 1 BIA *Mungo Park alla ricerca del Niger / Natale Bianchi. - Torino etc.! : Paravia, stampa 1926. - 262 p., 12! c. di tav. : ill. ; 19 cm. (I *grandi viaggi di esplorazione) N.Inv: LAS 242 1 NIGER <FIUME> - Esplorazioni - 1795-1805 2 PARK, MUNGO BL B 1 BOU L'*aventure Abyssine / Emmanuel Bourcier. - Paris : Librarie des Champs-Elysees, c1936. - 250 p. ; 19 cm. N.Inv: LAS 153 BL B 1 BOV *Dal Mar Rosso al Nilo azzurro / Renato Bova-Scoppa. -

Il Fondo Maugini Nel Catalogo Di Ateneo
Fondo Maugini Titolo / Autore Pubblicazione Identificativo Scheda su SBN OneSearch 1: 1846-1858 Roma : Abate, 1971 UFI0100149 link 1: 1857-1885 / testo di Carlo Giglio Roma : Istituto Poligrafico dello stato, 1958 UFI0100132 link 1. congresso agricolo coloniale a Tripoli, 2-6 maggio 1928 / Sindacato Roma : Stab. Poligr. de "Il lavoro nazionale tecnici agricoli fascisti d'Italia", [1928?] UFI0048371 link 10 ans de recherches forestieres tropicales / Centre technique forestier Nogent sur Marne : Centre technique forestier tropical tropical, stampa 1960 UFI0085432 link 2: 1859-1869 Roma : Abate, 1972 UFI0100150 link 2: 1958-1963 / Giuseppe Vedovato Firenze : Le Monnier, 1963 SBL0248626 link I 25 anni di attivita del Gruppo Vittorio Bottego : 1946-1971 / con l'alto Milano : [s.n.], 1971 patronato del Presidente della Repubblica UFI0047852 link 25 deliciosos platos con arroz / Carmen Victoria Lopez Venezuela : [Corporacion venezolana de fomento, 19..] UFI0118010 link 28. riunione (Pisa, 11-15 ottobre 1939-XVII) : atti / Societa italiana per il Roma : SIPS, 1940 progresso delle scienze ; pubblicati a cura del segretario generale prof. Lucio Silla UFI0048332 link 3. Convegno nazionale delle Camere di commercio, industria e Udine : Camera di commercio, industria e agricoltura per l'emigrazione : Udine 4 e 5 maggio 1951- Gorizia 6 agricoltura, 1951 maggio 1951 UFI0047243 link 600 q.li di pere ad ettaro col Metodo Newtimes (Ferraguti) / A. Del Roma : Istituto di frutticultura e di Lungo, E. Zanini elettrogenetica, 1935 UFI0065598 link 8. Congresso internazionale d'agricoltura tropicale e subtropicale : Roma : Arte della stampa, 1939 Tripoli, 13-17 marzo 1939-XVII : rapporti e comunicazioni di sezione : riassunti / FITA UFI0068161 link A propos de la mise en liberte, par activite microbiologique, du Milano : E. -

Political History of Tigray
Political History of Tigray: Rivalry for Power (1910-1935) A Thesis Presented to The School of Graduate Studies Of the Addis Ababa University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in History By Hagos G/Yohannes June 2003 ADDIS ABABA UNIVERSITY SCHOOL OF GRADUATE STUDIES COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES DEPARTENT OF HISTORY Political History of Tigray: Rivalry for Power (1910-1935) By Hagos G/Yohannes Hadera Adviser: Tecle-Haimanot G/Selassie (Ph.D.) Approval by Board of Examiners: Adviser Examiner Examiner DECLARATION I, the undersigned declare that this thesis is my work and that all sources used for the thesis have been duly acknowledged. Name: Hagos G/Yohannes Hadera Signature: Place and date of Submission: Addis Ababa University College of Social Sciences Department of History TABLE OF CONTENTS page Table of Contents i Key to Transliteration iii Acknowledgement v Preface … vii Abstract x Chapter I. Background 1 1.1. An overview of the Political History of Tigray from the Battle of Mätäma to the Battle of Koräm .......................................................1 1.2. The Battle of Koräm.........................................................................9 1.3. An overview of Tigray from the Battle of Koräm to the Battle of Ākhora..........................................................................................14 II. The Battle of Ākhora ...............................................................................20 2.1. Prelude and the causes of the Battle of Ākhora ..............................20 2.2. The conduct of the Battle of Ākhora and its results ........................32 2.3. The Battle of Gidära and its results .................................................36 2.4. The central government's handling of the conflict in Tigray and the subsequent attempts for the extradition of D äjja č Gäbrä-Sellassé......................................................................40 2.5. -

LA GUERRA DE MUSSOLINI Orden Tras La Ocupación De Las Fábricas Y La Oleada De Huelgas De 1920
1 EN MARCHA ara Italia los primeros años de la posguerra fueron años difíciles. La Pdesmovilización fue lenta: a finales de 1919 aún había medio millón de hombres en el Ejército, y el proceso no concluyó hasta 1921. Dentro del país los desórdenes fueron a más cuando los trabajadores italianos secun- daron una huelga general internacional en junio de 1919, y a partir de ahí comenzaron dos violentos años de luchas internas. Y para muchos que habían vestido o seguían vistiendo el uniforme, el acuerdo de paz y la «victoria mutilada» que los políticos trajeron consigo de Versalles venían a confirmar el sentimiento de que toda aquella lucha no había servido para nada. «Ni marcha sobre Viena» se lamentaba un decepcionado capi- tán de arditi en julio de 1919, «ni consolidación de victoria, ni colonias, ni Fiume, ni indemnizaciones, ni nada que valga la pena».1 La necesidad de ahorrar golpeó duramente al Ejército. Se suspendieron todos los ascensos durante cinco años, se envió a la reserva a miles de oficiales, en su mayo- ría subalternos, y se recortaron los sueldos de los oficiales. La promesa de que los oficiales iban a cobrar un salario digno que hizo Mussolini apro- ximadamente seis meses antes de la Marcha sobre Roma que le llevó al poder en octubre de 1922, fue bienvenida. Algunos de los objetivos del fascismo encajaban a la perfección con los de los militares, de modo que el Ejército colaboró encantado con la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional (MVSN, los «camisas negras» fascistas) a la hora de restablecer el 60 LA GUERRA DE MUSSOLINI orden tras la ocupación de las fábricas y la oleada de huelgas de 1920. -

Il Diritto Coloniale Dall'età Liberale Al Fascismo: Tra Missione Civilizzatrice E Razzismo
Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Giurisprudenza Scuola di Dottorato di Ricerca in Diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti del diritto europeo XXV ciclo Il diritto coloniale dall'età liberale al Fascismo: tra missione civilizzatrice e razzismo Direttore della Scuola: Ch.mo Prof. Aldo Mazzacane Supervisore: Ch.mo Prof. Aldo Mazzacane Candidato: Olindo De Napoli 1 Cap. I Razza e impero. La legittimazione del colonialismo nel pensiero giuridico dell'età liberale. Problemi metodologici e definitori. Si può affermare che la dominazione coloniale contenga in sé, comunque sia strutturata, un principio razzista, e che quindi – per stare nel campo giuridico – ogni demarcazione tra cittadini e sudditi sia in sé razzista. Secondo Giorgio Rochat, uno dei pionieri nello studio del colonialismo italiano, esso è “intriso di razzismo e sopraffazione, che sono condizioni preliminari per ogni conquista coloniale, perché già l’idea di voler disporre a proprio piacimento delle sorti di un popolo militarmente più debole è profondamente razzista e sopraffattoria”1. Di fronte a questa affermazione di carattere generale bisogna porsi alcune domande. Innanzitutto è necessario chiedersi se l'esistenza del razzismo sia solo qualcosa che gli studiosi possono individuare a posteriori, in base ad alcuni 1 G. Rochat, Il colonialismo italiano, Loescher, Torino, 1973, pag. 222. 2 canoni di non sempre semplice individuazione2, o se essa fosse in qualche modo avvertita o teorizzata all'epoca in esame. In altre parole, se è vero che ogni colonialismo è in sé razzista, bisogna altresì chiedersi se esso si autorappresenti come tale e se il discorso legittimante sia fondato sulla razza3. -

Il Governo Italiano E I Missionari Cattolici in Etiopia
UNIVERSITÀ DI ROMA TRE DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA (POLITICA, SOCIETÀ, CULTURA, TERRITORIO) XXV CICLO COORDINATORE: CH.MA PROF.SSA FRANCESCA CANTÚ TESI DI DOTTORATO DI RICERCA: I MISSIONARI CATTOLICI ITALIANI NELL’ETIOPIA OCCUPATA (1936-1943) TUTOR: CH.MO PROF. ROBERTO MOROZZO DELLA ROCCA DOTTORANDO: ANTONIO CATALDI 2013 Introduzione La presente ricerca intende analizzare in un primo quadro d’insieme, la vicenda dei missionari cattolici italiani nell’impero d’Etiopia, nel pur effimero periodo dell’occupazione coloniale italiana del 1936-1941, senza tuttavia pretendere di chiarire tutte le problematiche e i punti eventualmente ancora oscuri di questo specifico ambito d’indagine storica. Sul versante dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica in merito allo sviluppo della presenza missionaria italiana in Etiopia -inclusa della regione eritrea-, nell’arco cronologico della colonizzazione italiana sono state scritte alcune opere significative, anche se non ancora esaustive. Tra queste certamente lo studio analitico di Cesare Marongiu Buonaiuti del 19821 sulla politica religiosa italiana nelle colonie -diviso sostanzialmente in due campi d’indagine: quello della prassi governativa nei confronti delle diverse comunità religiose delle colonie e quello dei rapporti tra governo e gerarchie vaticane-, costruito principalmente sui carteggi governativi con la sola eccezione di alcune citazioni dagli archivi dell’istituto dei missionari della Consolata. Si tratta di una prima analisi sistematica delle politiche coloniali italiane in ambito -

Territorial Appropriation, Trade, and Politics in the Somalia-Kenya Borderlands (C.1925-1963): State Formation in Transnational Perspective
A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/150661 Copyright and reuse: This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications Territorial Appropriation, Trade, and Politics in the Somalia-Kenya Borderlands (c.1925-1963): State Formation in Transnational Perspective by Anna Bruzzone A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History University of Warwick, Department of History April 2019 Table of Contents List of Illustrations ................................................................................................................... 1 Acknowledgments .................................................................................................................... 2 Declaration ................................................................................................................................ 4 Abstract ..................................................................................................................................... 5 List of Terms ............................................................................................................................ -

Italiani, Brava Gente?
Sommario Premessa .............................................................................................................................................. 7 1. Fare gli italiani ................................................................................................................................. 9 2. La guerra al “brigantaggio” ............................................................................................................ 28 3. L’inferno di Nocra ......................................................................................................................... 36 4. In Cina contro i boxer ..................................................................................................................... 43 5. Sciara Sciat: stragi e deportazioni ................................................................................................... 50 6. Le colpe di Cadorna ....................................................................................................................... 60 7. Gli schiavi dell’Uebi Scebeli .......................................................................................................... 69 8. Soluch come Auschwitz ................................................................................................................. 78 9. Una pioggia di iprite ....................................................................................................................... 87 10. Debrà Libanòs: una soluzione finale ............................................................................................ -

Nationalism and Secession in the Horn of Africa a Critique of the Ethnie Interpretation
Nationalism and Secession in the Horn of Africa A Critique of the Ethnie Interpretation Dominique Jacquin Thesis submitted for the PhD in International Relations London School of Economies and Politicai Science University of London 2 Abstract This thesis seeks to assess the relevance of existing theories about the origins of nationalism and investigate more specifically the claixn that nationalism is rooted in ethnicity. It does so by examining the cases of Eritrea and Somaliland, which proclaimed their independence in May 1991 after seceding from the states to which they were formerly united. Having explained in the introduction why International Relations needs to take a closer look at the causes of nationalism, the second chapter proceeds to review some of the main theories about the origins of nationalism. It retraces the history of the primordialist-modernist debate, discusses the main contentions of the ethnonationalist approach and presents some of the factors singled-out by recent scholarship as propitious for the emergence of nationalism. Given that most of the theories about the origins of nationalism presented in chapter two centre on Europe, chapter three surveys the literature on the rise of nationalism in Africa in order to determine whether any additional factors need to be considered before analysing Eritrea and Somaliland. Chapter three also includes a discussion of the anthropological literature on ethnicity in Africa and questions the ethnonationalist claim that ethnie groups are pre-modern. Using as a framework the factors identified previously, chapter four offers a historical account of the emergence of nationalism in Eritrea. Chapter five does the same for the case of Somaliland. -

Universita' Degli Studi Di Verona
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA DEPARTMENT OF ECONOMICS GRADUATE SCHOOL OF LAW AND ECONOMICS DOCTORAL PROGRAM IN ECONOMICS WITH THE FINANCIAL CONTRIBUTION OF UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Cycle / year (1° year of attendance) 32°/ 2016-2017 CYRENAIC ECONOMIC EVOLUTION DURING FASCIST PERIOD (1922- 1939) The impact of Italian repression against Indigenous on local economy S.S.D. SECS-P/12 Coordinator: Prof. ROBERTO RICCIUTI Tutor: Prof. EDOARDO DEMO Doctoral Student: Dott. DAVIDE BERNARDI Summary The paper is divided into three chapters. The literature review about the theme is analysed in chapter one, where the events related to the Italian colonialism from the origins to the WWI are reported. In the first chapter the economic aspects of every colony until 1915 are briefly described. Finally, in this section there is a description of the Italian dominion in Libya between 1919 and 1940. Chapter two focuses on a description of Cyrenaic economic data from 1920 to 1940, and sources used to collect them. Data belong to several categories, from demography to prices, until wages and transports. Finally, in chapter three the empirical analysis is developed, with a description of methodology used, and of the econometric results found in the research. Abstract This study wants investigate the impact of Italian dominion on Libyan economy during the period between 1922 and 1940. In particular, we attempt to understand if the repression in Cyrenaica in years between 1930-33, with the creation of concentration camps, caused a deconstruction of local economy. To make this, we reconstructed the events related to Italian colonialism until WWI and then we collected data about Libya between 1920 and 1940.