Storia Dell'architettura E Della Città
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Università Di Pisa
UNIVERSITÀ DI PISA SCUOLA DI DOTTORATO IN STORIA, ORIENTALISTICA E STORIA DELLE ARTI CICLO XXIII GLI ITALIANI NELL’ERITREA DEL SECONDO DOPOGUERRA 1941 – 1952 Candidato: Dott. Nicholas Lucchetti Tutor: Chiar.mo Prof. Marco Lenci SSD: M – STO/04 Anno accademico 2010 – 2011 1 INDICE Abbreviazioni, p. 4 Ringraziamenti, p. 6 Introduzione, p. 7 Capitolo 1. L’Amministrazione militare britannica dell’Eritrea, p. 13 1.1 La struttura del governo d’occupazione e i rapporti con gli italiani, p. 13 1.2 “L’Informazione” (1941), p. 17 1.3 L’“Eritrean Daily News” – “Il Quotidiano eritreo”, la politica britannica nei confronti degli eritrei e le contraddizioni del mantenimento in servizio degli italiani, p. 21 1.4 La PAI durante l’Amministrazione britannica, p. 29 1.5 La Guardia di Finanza durante l’Amministrazione britannica, p. 31 1.6 L’Arma dei Carabinieri durante l’Amministrazione britannica, p. 35 Capitolo 2. La politica tra gli italiani d’Eritrea, p. 39 2.1 Il movimento antifascista, il GUI e l’Amministrazione britannica. 1941 – 1943, p. 39 2.2 1944. La fondazione del CLN e del PDCI, il caso Del Giudice, p. 56 2.3 “Resistenti”, guerriglieri e fascisti d’Eritrea 1941 – 1945, p. 66 2.4 1946. La sospensione di “Voci di casa nostra”, il referendum istituzionale, “La Repubblica” ed il “Corriere di Asmara” di Franco Pattarino, p. 85 2.5 1947. La sospensione del “Corriere di Asmara”, la nascita del CRIE, lo sciopero degli operai dell’ARAMCO, la crisi del CRIE, “Ficcanaso”, l’MSI “eritreo”, p. 96 2.6 1948. La manifestazione per l’eccidio di Mogadiscio. -

Il Fondo Maugini Nel Catalogo Di Ateneo
Fondo Maugini Titolo / Autore Pubblicazione Identificativo Scheda su SBN OneSearch 1: 1846-1858 Roma : Abate, 1971 UFI0100149 link 1: 1857-1885 / testo di Carlo Giglio Roma : Istituto Poligrafico dello stato, 1958 UFI0100132 link 1. congresso agricolo coloniale a Tripoli, 2-6 maggio 1928 / Sindacato Roma : Stab. Poligr. de "Il lavoro nazionale tecnici agricoli fascisti d'Italia", [1928?] UFI0048371 link 10 ans de recherches forestieres tropicales / Centre technique forestier Nogent sur Marne : Centre technique forestier tropical tropical, stampa 1960 UFI0085432 link 2: 1859-1869 Roma : Abate, 1972 UFI0100150 link 2: 1958-1963 / Giuseppe Vedovato Firenze : Le Monnier, 1963 SBL0248626 link I 25 anni di attivita del Gruppo Vittorio Bottego : 1946-1971 / con l'alto Milano : [s.n.], 1971 patronato del Presidente della Repubblica UFI0047852 link 25 deliciosos platos con arroz / Carmen Victoria Lopez Venezuela : [Corporacion venezolana de fomento, 19..] UFI0118010 link 28. riunione (Pisa, 11-15 ottobre 1939-XVII) : atti / Societa italiana per il Roma : SIPS, 1940 progresso delle scienze ; pubblicati a cura del segretario generale prof. Lucio Silla UFI0048332 link 3. Convegno nazionale delle Camere di commercio, industria e Udine : Camera di commercio, industria e agricoltura per l'emigrazione : Udine 4 e 5 maggio 1951- Gorizia 6 agricoltura, 1951 maggio 1951 UFI0047243 link 600 q.li di pere ad ettaro col Metodo Newtimes (Ferraguti) / A. Del Roma : Istituto di frutticultura e di Lungo, E. Zanini elettrogenetica, 1935 UFI0065598 link 8. Congresso internazionale d'agricoltura tropicale e subtropicale : Roma : Arte della stampa, 1939 Tripoli, 13-17 marzo 1939-XVII : rapporti e comunicazioni di sezione : riassunti / FITA UFI0068161 link A propos de la mise en liberte, par activite microbiologique, du Milano : E. -
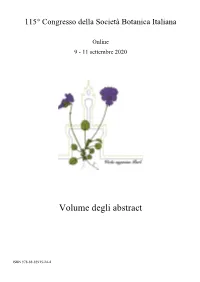
Volume Degli Abstract
115° Congresso della Società Botanica Italiana Online 9 - 11 settembre 2020 Volume degli abstract ISBN 978-88-85915-24-4 Comitato Scientifico Comitato Tecnico e Organizzativo Consolata Siniscalco (Torino) (President) Chiara Barletta Maria Maddalena Altamura (Roma) Gianniantonio Domina Stefania Biondi (Bologna) Lorenzo Lazzaro Alessandro Chiarucci (Bologna) Marcello Salvatore Lenucci Salvatore Cozzolino (Napoli) Stefano Martellos Lorenzo Peruzzi (Pisa) Giovanni Salucci Ferruccio Poli (Bologna) Lisa Vannini Carlo Blasi (Università La Sapienza, Roma) Luca Bragazza (Università di Ferrara) Giuseppe Brundu (Università di Sassari) Stefano Chelli (Università di Camerino) Vincenzo De Feo (Università di Salerno) Giuseppe Fenu (Università di Cagliari) Goffredo Filibeck (Università della Tuscia) Marta Galloni (Università di Bologna) Lorenzo Gianguzzi (Università di Palermo) Stefano Martellos (Università di Trieste) Anna Maria Mercuri (Università di Modena e Reggio Emilia) Lorella Navazio (Università di Padova) Alessio Papini (Università di Firenze) Anna Maria Persiani (Università La Sapienza, Roma) Rossella Pistocchi (Università di Bologna) Marta Puglisi (Università di Catania) Francesco Maria Raimondo (Università di Palermo) Luigi Sanità di Toppi (Università di Pisa) Fabio Taffetani (Università delle Marche) Sponsor 115° Congresso della Società Botanica Italiana onlus Online, 9-11 settembre 2020 Programma Mercoledì 9 settembre 2020 SIMPOSIO GENERALE “I VARI VOLTI DELLA BOTANICA” (Moderatori: A. Canini e A. Chiarucci) 9.00-11.00 Comunicazioni • Luigi Cao Pinna, Irena Axmanová, Milan Chytrý et al. (15 + 5 min) “La biogeografia delle piante aliene nel bacino del Mediterraneo” • Andrea Genre, Veronica Volpe, Teresa Mazzarella et al. (15 + 5 min) “Risposte trascrizionali in radici di Medicago truncatula esposte all'applicazione esogena di oligomeri di chitina a catena corta” • Gianluigi Ottaviani, Luisa Conti, Francisco E. -

“BRAVA GENTE” Alcune Considerazioni Tratte Dai Libri Di
CASA CULTURALE di SAN MINIATO BASSO www. casa culturale san miniato basso – (Sezione LETTURE) SETTIMO LAVORO PER I RAGAZZI NEL 2019 ITALIANI “BRAVA GENTE” Alcune Considerazioni tratte dai libri di : NICOLA LABANCA : OLTREMARE ALESSANDRO ARUFFO: STORIA DEL COLONIALISMO ITALIANO PARTE SECONDA FRA LA PRIMA E LA SECONDA GUERRA MONDIALE Le altre potenze coloniali dell’Europa, e in particolare la Gran Bretagna e la Francia mirarono, nel periodo fra le due guerre mondiali, a sfruttare i propri possedimenti oltremare e invece l’Italia fascista era in preda ad un’ansia di espansione. Il 2 ottobre 1935 Mussolini così aveva sintetizzato il suo programma: - La ruota del destino che muove inarrestabile verso la meta / guidata dallo spirito e dalla potenza del popolo italiano / popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di navigatori / che per quaranta anni ha pazientato con l’Etiopia / paese africano universalmente bollato come un paese senza ombra di civiltà / ma che ora di fronte a chi tenta di consumare la più nera delle ingiustizie : quella di toglierci un po’ di posto al sole / afferma: ORA BASTA ! Questo discorso del ’35 veniva dopo la marcia su Roma del fascismo del 28 ottobre 1922 che portò ad un regime illiberale e reazionario che avrebbe oppresso l’Italia per un ventennio e portato impreparato il Paese in una guerra mondiale. Governo poi spazzato via solo al termine di una sanguinosa guerra di liberazione il 25 aprile 1945. Dopo la Roma dell’antichità, dopo la Roma medievale e moderna della Chiesa, la Roma novecentesca del fascio doveva, secondo Mussolini, inaugurare ora una nuova era. -

Il Governo Italiano E I Missionari Cattolici in Etiopia
UNIVERSITÀ DI ROMA TRE DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA (POLITICA, SOCIETÀ, CULTURA, TERRITORIO) XXV CICLO COORDINATORE: CH.MA PROF.SSA FRANCESCA CANTÚ TESI DI DOTTORATO DI RICERCA: I MISSIONARI CATTOLICI ITALIANI NELL’ETIOPIA OCCUPATA (1936-1943) TUTOR: CH.MO PROF. ROBERTO MOROZZO DELLA ROCCA DOTTORANDO: ANTONIO CATALDI 2013 Introduzione La presente ricerca intende analizzare in un primo quadro d’insieme, la vicenda dei missionari cattolici italiani nell’impero d’Etiopia, nel pur effimero periodo dell’occupazione coloniale italiana del 1936-1941, senza tuttavia pretendere di chiarire tutte le problematiche e i punti eventualmente ancora oscuri di questo specifico ambito d’indagine storica. Sul versante dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica in merito allo sviluppo della presenza missionaria italiana in Etiopia -inclusa della regione eritrea-, nell’arco cronologico della colonizzazione italiana sono state scritte alcune opere significative, anche se non ancora esaustive. Tra queste certamente lo studio analitico di Cesare Marongiu Buonaiuti del 19821 sulla politica religiosa italiana nelle colonie -diviso sostanzialmente in due campi d’indagine: quello della prassi governativa nei confronti delle diverse comunità religiose delle colonie e quello dei rapporti tra governo e gerarchie vaticane-, costruito principalmente sui carteggi governativi con la sola eccezione di alcune citazioni dagli archivi dell’istituto dei missionari della Consolata. Si tratta di una prima analisi sistematica delle politiche coloniali italiane in ambito -

Italiani, Brava Gente?
Sommario Premessa .............................................................................................................................................. 7 1. Fare gli italiani ................................................................................................................................. 9 2. La guerra al “brigantaggio” ............................................................................................................ 28 3. L’inferno di Nocra ......................................................................................................................... 36 4. In Cina contro i boxer ..................................................................................................................... 43 5. Sciara Sciat: stragi e deportazioni ................................................................................................... 50 6. Le colpe di Cadorna ....................................................................................................................... 60 7. Gli schiavi dell’Uebi Scebeli .......................................................................................................... 69 8. Soluch come Auschwitz ................................................................................................................. 78 9. Una pioggia di iprite ....................................................................................................................... 87 10. Debrà Libanòs: una soluzione finale ............................................................................................ -

Per Amor Di Classicismo
Per chi ha fatto della Storia e della Storia dell’Architettura il centro principale della propria vita - come è accaduto nel caso di Francesco Quinterio, nostro Socio fondatore oltre che Studioso, stimatissimo Professore di “Storia dell’Architettura” e Amico caro - non è difficile PER AMOR comprendere quanto possa essere ancora oggi dirompente mettere in agenda l’importanza della Storia in una Società che punta, invece, non solo a monetizzare ogni intervento e ogni azione, ma che in ambito culturale si mostra soprattutto propensa allo “Story telling” e alla DI CLASSICISMO sola divulgazione (una divulgazione che diviene deleteria quando non accompagnata da una ricerca seria e che si mostra, invece, virtuosa quando finalizzata al progresso culturale 2015-2016 Ricerche di Storia dell’Architettura 2015-2016 della Società). Riteniamo importante, insieme a chi ha voluto partecipare a questo volume in memoria di Quinterio, indirizzarsi piuttosto verso una visione della Storia, se non come 24-25 e dell’Arte in memoria di Francesco Quinterio 24-25 magistra vitae (anche se vorremmo), almeno come ‘lettura’ della Società, come consapevolezza degli eventi, come ricerca delle radici e della “lunga durata” dei fenomeni, come difficile approccio di conoscenza e di apertura consapevole verso il futuro. Gli studi miscellanei che si propongono in questa raccolta, dunque, svolti dall’Età medievale a quella contemporanea, costituiscono non solo una messe di informazioni scientifiche di estrema rilevanza per gli àmbiti trattati, ma anche un preciso orientamento sociale, oltre che metodologico; una visione ancora utile che può permettere di ‘fare quadrato’ rispetto al sempre paventato «silenzio della Storia» e alla depauperazione dei contenuti scientifici e disciplinari di essa. -

La Costruzione Dell'impero Fascista
A1i 583 Alessandro Pes LA COSTRUZIONE DELL’IMPERO FASCISTA POLITICHE DI REGIME PER UNA SOCIETÀ COLONIALE Copyright © MMX ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, 133/A–B 00173 Roma (06) 93781065 ISBN 978–88–548–3770–6 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: dicembre 2010 Indice Prefazione di Cecilia Dau Novelli e Charles F. Burdett. Introduzione, p. 5. Capitolo 1 L’Etiopia nei progetti coloniali italiani, 1887-1928, p. 15. 1.1 La penetrazione missionaria in Etiopia nel XIX secolo, p. 15 - 1.2 I primi progetti di espansione in Etiopia, p 27 – 1.3 Adua 1896: la disfatta coloniale di una potenza europea, p. 44 – 1.4 Le società geografiche e la politica coloniale dopo Adua, p. 57 – 1.5 Dalla pace di Addis Abeba al Trattato di amicizia, p. 67. Capitolo 2 La via etiopica alla modernizzazione, p. 71. 2.1 Teodoro II e la conclusione della Zamana Masafent, p. 71 – 2.2 La politica di equilibrio di Giovanni IV, p 79 – 2.3 Menelik II e il processo di modernizzazione del paese, p. 85 – 2.4 Modernità e sistema d’istruzione nei governi di Menelik II e Ras Tafari, p. 94. Capitolo 3 La costruzione dell’Impero fascista, p. 101. 3.1 La necessità fascista dell’Impero, p. 101 – 3.2 I primi problemi di amministrazione dell’Impero, p. -

Votare Con I Piedi.Pdf
eum > storia> istituzioni Votare con i piedi La mobilità degli individui nell’Africa coloniale italiana a cura di Isabella Rosoni e Uoldelul Chelati Dirar eum In copertina Una famiglia si trasferisce, 1900 circa. Archivio Goglia Roma. isbn 978-88-6056-343-9 Prima edizione: ottobre 2012 ©2012 eum edizioni università di macerata Centro Direzionale, via Carducci 63/a – 62100 Macerata [email protected] http://eum.unimc.it Stampa: Global Print S.r.l. Via degli Abeti 17/1 – 20064 Gorgonzola (MI) [email protected] Indice 7 Introduzione Mobilità e controllo in contesto coloniale: chiavi di lettura Catherine Coquery-Vidrovitch 17 A History of African Migrations in Africa Irma Taddia 31 Reflections on Catherine Coquery-Vidrovitch. A History of African Migrations in Africa Mobilità e diritto coloniale Gianluca Bascherini 49 Cultura giuridica e vicenda coloniale Isabella Rosoni 85 Cittadinanze e giustizie differenziali. La condizione giuridica degli eritrei Modelli coloniali a confronto Bernard Durand 105 «Prendre son pied la route»: Enjeux et Défis de la mobilité en Afrique coloniale française Karin Pallaver 131 «L’incresciosa questione dei portatori»: mobilità dei lavoratori e politiche coloniali nell’Africa Orientale Tedesca (1890-1916) Stacey Hynd 151 Arenas of Death: Murder Trials and Colonial Justice in British Africa, c. 1920-1950 6 INDICE Corrado Tornimbeni 175 Lo stato coloniale portoghese in Mozambico, la mobilità della popolazione e la politica del territorio La pratica amministrativa Chiara Giorgi 199 Soggetti e politiche della -

Fascicoli Da 1 a 2413
n3-4_2007indiceFINALE:Layout 1 5/16/2008 2:36 PM Pagina 1 THE HISTORICAL SOURCES AT IAO THE UNPUBLISHED DOCUMENTATION CENTRE JOURNAL OF AGRICULTURE AND ENVIRONMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT Formerly Rivista di Agricoltura Subtropicale e Tropicale Volume 101 Number 3-4 July - December 2007 3 Il Centro di Documentazione Inedita 5 The Unpublished Documentation Centre 7 Il Centro di Documentazione Inedita - Catalogo The Unpublished Documentation Centre - Catalogue 915 Indice Autori Authors Index 975 Indice Paesi Countries Index ISSN 1590-7198 n3-4_2007indiceFINALE:Layout 1 5/16/2008 2:36 PM Pagina 2 n3-4_2007indiceFINALE:Layout 1 5/16/2008 2:36 PM Pagina 3 Il Centro di Documentazione Inedita dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare Il contenuto di ogni fascicolo è conservato in una cartellina di cartone con indicazione manoscritta del titolo, autore e anno. Un’etichetta apposta sulla cartellina indica il n°. di fascicolo e l’area geografica di pertinenza dei documenti. Talvolta i dati furono riportati dall’incaricato dell’organizzazione del Centro di Documentazione, forse il Mariani, erroneamente, o, in assenza di essi, furono desunti dal contenuto: nel primo caso nella nostra descrizione abbiamo proceduto a correzione; nel secondo caso il lettore troverà i dati riportati in corsivo (quando si tratta del titolo del documento, dato sempre riportato in corsivo, si è aggiunta la sottolineatura), anche se spesso modificati, in quanto si è ritenuto di poter assegnare un titolo più idoneo o correggere arbitrarietà. Quando si è attribuito un titolo diverso da quello riportato sulla cartellina, si è indicato il vecchio titolo fra parentesi uncinate (< >). Spesso in ciascuna singola cartellina sono contenuti più documenti: in questo caso l’“incaricato” ha sempre indicato un solo titolo sulla cartellina, titolo che voleva esprimere sinteticamente il contenuto generale della documentazione (per cui lo si è riportato fra parentesi uncinate di seguito al numero del fascicolo indicato in grassetto), oppure che rispondeva ad uno solo dei documenti.