Votare Con I Piedi.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
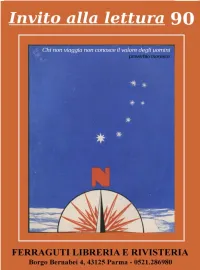
Fn000030.Pdf
1) Viaggi ed esplorazioni- 205 2) Collana Paravia Viaggi- 226 3)Collana Alpes Viaggi- 240 4) Ebraismo- 390 5) Colonialismo Fascista- 513 6) L'Illustrazione Italiana- 522 7) Storia- 546 8) Fascismo- 609 9) Spionaggio- 626 10) Letteratura italiana- 635 11) Letteratura straniera- 648 12) Il Corriere dei Piccoli-658 13) Libri per Ragazzi-693 14) Sport- 701 15) Arte-727 Le immagini di tutti i libri proposti in questo catalogo ( e molti altri) sono disponibili nella sezione RICERCA del sito www.ferraguti.it , continuamente aggiornato, che vi invitiamo a visitare. Preghiamo i gentili clienti di comunicarci l'indirizzo email, al fine di poter inviare, qualora lo gradissero, comunicazioni e cataloghi intermedi rispetto alle "classiche" pubblicazioni trimestrali. Siamo sempre interessati all'acquisto di intere biblioteche e partite o blocchi di libri, riviste e stampe d'epoca, saremo grati a chi ci fornirà opportune segnalazioni. FERRAGUTI SERVICE s.a.s. di Ferraguti Ivo & C. Borgo Bernabei 4 - 43125 Parma Tel. e Fax 0521-286980- [email protected] [email protected] P. IVA 01779470341- C.C.I.A.A. PR Reg. Ditte n. 177878 Iscrizione Tribunale di Parma n. 22291 Conto Corrente Postale n. 11724432 Catalogo numero 90- I semestre 2013- Gennaio,Febbraio, Marzo 2013 Editore: Ferraguti Service s.a.s. (Responsabile Ivo Ferraguti) Tipografie Riunite Donati - Borgo Santa Chiara 6- 43125 Parma 2 Albertini Gianni, ALLA RICERCA DEI NAUFRAGHI DELL'"ITALIA". mille kilometri sulla banchisa., Libreria d'Italia, Milano, 1929, 8o, brossura e sovracoperta., bs.,seconda ediz., pp. 165. La spedizione Nobile. Con numerose e bellissime foto. € 31,00 3 Albieri Adele, CRISTOFORO COLOMBO alla scoperta dell'America., Paravia G.B. -

Sicily and the Surrender of Italy
United States Army in World War II Mediterranean Theater of Operations Sicily and the Surrender of Italy by Albert N. Garland and Howard McGaw Smyth Assisted by Martin Blumenson CENTER OF MILITARY HISTORY UNITED STATES ARMY WASHINGTON, D.C., 1993 Chapter XIV The Climax Sardinia Versus the Mainland The successful invasion of Sicily clarified strategic problems and enabled the Allies to turn from debate to decision. The Combined Chiefs of Staff at the TRIDENT Conference in May had directed General Eisenhower to knock Italy out of the war and contain the maximum number of German forces, but they had not told him how. Preparing to launch operations beyond the Sicilian Campaign, AFHQ had developed several outline plans: BUTTRESS, invasion of the Italian toe by the British 10 Corps; GOBLET, a thrust at the ball of the Italian foot by the British 5 Corps; BRIMSTONE, invasion of Sardinia; and FIREBRAND, invasion of Corsica. But a firm decision on the specific course of action to be taken was still lacking.1 The four plans, Eisenhower had explained to Churchill during the Algiers meetings in June, pointed to two broad alternative courses. If the Axis resisted vigorously in Sicily, thereby forecasting high Italian morale and a bitter and protracted struggle for the Allies, then BRIMSTONE and FIREBRAND, insular operations, were preferable. Otherwise, operations on the Italian mainland were more promising. Despite Churchill's articulate enthusiasm for the latter course, Eisenhower had made no commitment. He awaited the factual evidence to be furnished in Sicily. Meanwhile, the Americans and British continued to argue over strategy. -

Foreign News: Where Is Signor X?
Da “Time”, 24 maggio 1943 Foreign News: Where is Signor X? Almost 21 years of Fascism has taught Benito Mussolini to be shrewd as well as ruthless. Last week he toughened the will of his people to fight, by appeals to their patriotism, and by propaganda which made the most of their fierce resentment of British and U.S. bombings. He also sought to reduce the small number pf Italians who might try to cut his throat by independent deals with the Allies. The military conquest of Italy may be no easy task. After the Duce finished his week's activities, political warfare against Italy looked just as difficult, and it was hard to find an alternative to Mussolini for peace or postwar negotiations. No Dorlans. The Duce began by ticking off King Vittorio Emanuele, presumably as insurance against the unlikely prospect that the sour-faced little monarch decides either to abdicate or convert his House of Savoy into a bargain basement for peace terms. Mussolini pointedly recalled a decree of May 10, 1936, which elevated him to rank jointly with the King as "first marshal of Italy." Thus the King (constitutionally Commander in Chief of all armed forces) can legally make overtures to the Allies only with the consent and participation of the Duce. Italy has six other marshals. Mussolini last week recalled five of them to active service.* Most of these men had been disgraced previously to cover up Italian defeats. Some of them have the backing of financial and industrial groups which might desert Mussolini if they could make a better deal. -

Cahiers De La Méditerranée, 88 | 2014 Italy, British Resolve and the 1935-1936 Italo-Ethiopian War 2
Cahiers de la Méditerranée 88 | 2014 Le rapport au monde de l'Italie de la première guerre mondiale à nos jours Italy, British resolve and the 1935-1936 Italo- Ethiopian War Jason Davidson Electronic version URL: http://journals.openedition.org/cdlm/7428 DOI: 10.4000/cdlm.7428 ISSN: 1773-0201 Publisher Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine Printed version Date of publication: 30 June 2014 Number of pages: 69-84 ISSN: 0395-9317 Electronic reference Jason Davidson, « Italy, British resolve and the 1935-1936 Italo-Ethiopian War », Cahiers de la Méditerranée [Online], 88 | 2014, Online since 03 December 2014, connection on 08 September 2020. URL : http://journals.openedition.org/cdlm/7428 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdlm.7428 This text was automatically generated on 8 September 2020. © Tous droits réservés Italy, British resolve and the 1935-1936 Italo-Ethiopian War 1 Italy, British resolve and the 1935-1936 Italo-Ethiopian War Jason Davidson 1 As Italian elites prepared to attack Ethiopia in 1935 they knew that resolve mattered; they were aware that British willingness to incur costs to defend Ethiopia and the League of Nations would have a decisive impact on the war. If the British were to militarily oppose to Italy or even to close the Suez Canal, the Italian war effort would be prohibitively costly and would probably fail. Moreover, the British sent signals that could have been interpreted as evidence of high resolve (a willingness to incur great costs to defend Ethiopia and the League of Nations). In mid-September Foreign Secretary Samuel Hoare made an impassioned pledge that Britain would be “second to none” in defending its League obligations. -

Università Di Pisa
UNIVERSITÀ DI PISA SCUOLA DI DOTTORATO IN STORIA, ORIENTALISTICA E STORIA DELLE ARTI CICLO XXIII GLI ITALIANI NELL’ERITREA DEL SECONDO DOPOGUERRA 1941 – 1952 Candidato: Dott. Nicholas Lucchetti Tutor: Chiar.mo Prof. Marco Lenci SSD: M – STO/04 Anno accademico 2010 – 2011 1 INDICE Abbreviazioni, p. 4 Ringraziamenti, p. 6 Introduzione, p. 7 Capitolo 1. L’Amministrazione militare britannica dell’Eritrea, p. 13 1.1 La struttura del governo d’occupazione e i rapporti con gli italiani, p. 13 1.2 “L’Informazione” (1941), p. 17 1.3 L’“Eritrean Daily News” – “Il Quotidiano eritreo”, la politica britannica nei confronti degli eritrei e le contraddizioni del mantenimento in servizio degli italiani, p. 21 1.4 La PAI durante l’Amministrazione britannica, p. 29 1.5 La Guardia di Finanza durante l’Amministrazione britannica, p. 31 1.6 L’Arma dei Carabinieri durante l’Amministrazione britannica, p. 35 Capitolo 2. La politica tra gli italiani d’Eritrea, p. 39 2.1 Il movimento antifascista, il GUI e l’Amministrazione britannica. 1941 – 1943, p. 39 2.2 1944. La fondazione del CLN e del PDCI, il caso Del Giudice, p. 56 2.3 “Resistenti”, guerriglieri e fascisti d’Eritrea 1941 – 1945, p. 66 2.4 1946. La sospensione di “Voci di casa nostra”, il referendum istituzionale, “La Repubblica” ed il “Corriere di Asmara” di Franco Pattarino, p. 85 2.5 1947. La sospensione del “Corriere di Asmara”, la nascita del CRIE, lo sciopero degli operai dell’ARAMCO, la crisi del CRIE, “Ficcanaso”, l’MSI “eritreo”, p. 96 2.6 1948. La manifestazione per l’eccidio di Mogadiscio. -

Fondo Lasagni
FONDO GUERRINO LASAGNI BL B 1 ANT *Viaggio nei Bogos / O. Antinori ; con prefazione del march. prof. Giacomo Antinori. - Roma : Societa' Geografica Italiana, 1887. - 162 p. : ill. ; 22 cm. ((Estr. da: Boll. della società geografica italiana (1887), giugno e segg. N.Inv: LAS 207 BL B 1 APP La *sfinge nera : dal Marocco al Madagascar / Mario Appelius. - Milano : Alpes, 1926. - 414 p. ; 20 cm. N.Inv: LAS 250 1 AFRICA - Descrizioni e viaggi BL B 1 ARC *Quando ero medico in Africa / Gaetano Arcoleo. - Bologna : L. Cappelli, 1936. - 180 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm. ((L. 10. N.Inv: LAS 191 BL B 1 BEL La *cittadella di Allah : viaggio nell'Arabia Saudita / Felice Bellotti. - Milano : Cino del Duca, [1960]. - 235 p., [24] c.di tav. : ill. ; 21 cm . N.Inv: LAS 160 1 Arabia Saudita - Descrizioni e viaggi BL B 1 BIA *Esplorazioni in Africa di Gustavo Bianchi / memorie ordinate e pubblicate dal dottor Dino Pesci. - Milano etc.! : F. Vallardi, 1886?!. - VIII, 323 p., 1! c. di tav., 1! c. di tav. ripieg. : ritr., c. geogr. color. ; 19 cm. ((Data dalla prefaz. N.Inv: LAS 226 BL B 1 BIA *Mungo Park alla ricerca del Niger / Natale Bianchi. - Torino etc.! : Paravia, stampa 1926. - 262 p., 12! c. di tav. : ill. ; 19 cm. (I *grandi viaggi di esplorazione) N.Inv: LAS 242 1 NIGER <FIUME> - Esplorazioni - 1795-1805 2 PARK, MUNGO BL B 1 BOU L'*aventure Abyssine / Emmanuel Bourcier. - Paris : Librarie des Champs-Elysees, c1936. - 250 p. ; 19 cm. N.Inv: LAS 153 BL B 1 BOV *Dal Mar Rosso al Nilo azzurro / Renato Bova-Scoppa. -

Il Fondo Maugini Nel Catalogo Di Ateneo
Fondo Maugini Titolo / Autore Pubblicazione Identificativo Scheda su SBN OneSearch 1: 1846-1858 Roma : Abate, 1971 UFI0100149 link 1: 1857-1885 / testo di Carlo Giglio Roma : Istituto Poligrafico dello stato, 1958 UFI0100132 link 1. congresso agricolo coloniale a Tripoli, 2-6 maggio 1928 / Sindacato Roma : Stab. Poligr. de "Il lavoro nazionale tecnici agricoli fascisti d'Italia", [1928?] UFI0048371 link 10 ans de recherches forestieres tropicales / Centre technique forestier Nogent sur Marne : Centre technique forestier tropical tropical, stampa 1960 UFI0085432 link 2: 1859-1869 Roma : Abate, 1972 UFI0100150 link 2: 1958-1963 / Giuseppe Vedovato Firenze : Le Monnier, 1963 SBL0248626 link I 25 anni di attivita del Gruppo Vittorio Bottego : 1946-1971 / con l'alto Milano : [s.n.], 1971 patronato del Presidente della Repubblica UFI0047852 link 25 deliciosos platos con arroz / Carmen Victoria Lopez Venezuela : [Corporacion venezolana de fomento, 19..] UFI0118010 link 28. riunione (Pisa, 11-15 ottobre 1939-XVII) : atti / Societa italiana per il Roma : SIPS, 1940 progresso delle scienze ; pubblicati a cura del segretario generale prof. Lucio Silla UFI0048332 link 3. Convegno nazionale delle Camere di commercio, industria e Udine : Camera di commercio, industria e agricoltura per l'emigrazione : Udine 4 e 5 maggio 1951- Gorizia 6 agricoltura, 1951 maggio 1951 UFI0047243 link 600 q.li di pere ad ettaro col Metodo Newtimes (Ferraguti) / A. Del Roma : Istituto di frutticultura e di Lungo, E. Zanini elettrogenetica, 1935 UFI0065598 link 8. Congresso internazionale d'agricoltura tropicale e subtropicale : Roma : Arte della stampa, 1939 Tripoli, 13-17 marzo 1939-XVII : rapporti e comunicazioni di sezione : riassunti / FITA UFI0068161 link A propos de la mise en liberte, par activite microbiologique, du Milano : E. -

Il Diplomatico Su Carta
S T E F A N O B A L D I IL DIPLOMATICO SU CARTA R e p e r t o r i o d e i 1 2 0 0 l i b r i p u b b l i c a t i d a d i p l o m a t i c i i t a l i a n i Stefano Baldi IL DIPLOMATICO SU CARTA REPERTORIO DEI 1200 LIBRI PUBBLICATI DA DIPLOMATICI ITALIANI (IN SERVIZIO DAL 1946) La versione completa della ricerca è disponibile online all’indirizzo: http://baldi.diplomacy.edu/diplo II edizione © 2018 Stefano Baldi Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere deri- vate 3.0 Italia License L’edizione digitale di questo libro è pubblicata sul sito http://baldi.diplomacy.edu INDICE Introduzione 5 Repertorio dei libri pubblicati da diplomatici italiani 7 Libri fotografici sulle Rappresentanze diplomatiche italiane 97 Autori diplomatici 115 Introduzione Sono ormai oltre 1.200 i libri che i diplomatici italiani in servizio dopo il 1946 hanno scritto e pubblicato. È un numero che sorprende la maggior parte delle persone, ma che in fondo non dovrebbe stupire troppo visto che riguarda au- tori che esercitano o hanno esercitato una professione, come quella del diplo- matico, che ha tra le sue caratteristiche proprio quella dello scrivere. Questo repertorio bibliografico è il frutto di una lunga ricerca da me iniziata ol- tre venti anni fa insieme all’Ambasciatore Pasquale Baldocci che portò, nel 2004, alla pubblicazione del volume “La penna del diplomatico” che raccoglie- va i libri che eravamo riusciti a censire fino ad allora (meno della metà di quel- li attuali). -

“BRAVA GENTE” Alcune Considerazioni Tratte Dai Libri Di
CASA CULTURALE di SAN MINIATO BASSO www. casa culturale san miniato basso – (Sezione LETTURE) SETTIMO LAVORO PER I RAGAZZI NEL 2019 ITALIANI “BRAVA GENTE” Alcune Considerazioni tratte dai libri di : NICOLA LABANCA : OLTREMARE ALESSANDRO ARUFFO: STORIA DEL COLONIALISMO ITALIANO PARTE SECONDA FRA LA PRIMA E LA SECONDA GUERRA MONDIALE Le altre potenze coloniali dell’Europa, e in particolare la Gran Bretagna e la Francia mirarono, nel periodo fra le due guerre mondiali, a sfruttare i propri possedimenti oltremare e invece l’Italia fascista era in preda ad un’ansia di espansione. Il 2 ottobre 1935 Mussolini così aveva sintetizzato il suo programma: - La ruota del destino che muove inarrestabile verso la meta / guidata dallo spirito e dalla potenza del popolo italiano / popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di navigatori / che per quaranta anni ha pazientato con l’Etiopia / paese africano universalmente bollato come un paese senza ombra di civiltà / ma che ora di fronte a chi tenta di consumare la più nera delle ingiustizie : quella di toglierci un po’ di posto al sole / afferma: ORA BASTA ! Questo discorso del ’35 veniva dopo la marcia su Roma del fascismo del 28 ottobre 1922 che portò ad un regime illiberale e reazionario che avrebbe oppresso l’Italia per un ventennio e portato impreparato il Paese in una guerra mondiale. Governo poi spazzato via solo al termine di una sanguinosa guerra di liberazione il 25 aprile 1945. Dopo la Roma dell’antichità, dopo la Roma medievale e moderna della Chiesa, la Roma novecentesca del fascio doveva, secondo Mussolini, inaugurare ora una nuova era. -

Political History of Tigray
Political History of Tigray: Rivalry for Power (1910-1935) A Thesis Presented to The School of Graduate Studies Of the Addis Ababa University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in History By Hagos G/Yohannes June 2003 ADDIS ABABA UNIVERSITY SCHOOL OF GRADUATE STUDIES COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES DEPARTENT OF HISTORY Political History of Tigray: Rivalry for Power (1910-1935) By Hagos G/Yohannes Hadera Adviser: Tecle-Haimanot G/Selassie (Ph.D.) Approval by Board of Examiners: Adviser Examiner Examiner DECLARATION I, the undersigned declare that this thesis is my work and that all sources used for the thesis have been duly acknowledged. Name: Hagos G/Yohannes Hadera Signature: Place and date of Submission: Addis Ababa University College of Social Sciences Department of History TABLE OF CONTENTS page Table of Contents i Key to Transliteration iii Acknowledgement v Preface … vii Abstract x Chapter I. Background 1 1.1. An overview of the Political History of Tigray from the Battle of Mätäma to the Battle of Koräm .......................................................1 1.2. The Battle of Koräm.........................................................................9 1.3. An overview of Tigray from the Battle of Koräm to the Battle of Ākhora..........................................................................................14 II. The Battle of Ākhora ...............................................................................20 2.1. Prelude and the causes of the Battle of Ākhora ..............................20 2.2. The conduct of the Battle of Ākhora and its results ........................32 2.3. The Battle of Gidära and its results .................................................36 2.4. The central government's handling of the conflict in Tigray and the subsequent attempts for the extradition of D äjja č Gäbrä-Sellassé......................................................................40 2.5. -
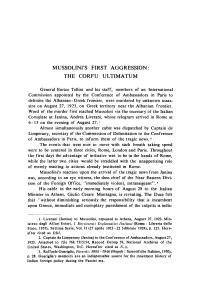
Mussolini's First Aggression: the Corfu Ultimatum
MUSSOLINI’S FIRST AGGRESSION: THE CORFU ULTIMATUM General Enrico Tellini and his staff, members of an International Commission appointed by the Conference of Ambassadors in Paris to délimité the Albanian - Greek frontier, were murdered by unknown assas sins on August 27, 1923, on Greek territory near the Albanian frontier. Word of the murder first reached Mussolini via the secretary of the Italian Consulate at Janina, Andrea Liverani, whose telegram arrived in Rome at 6: 15 on the evening of August 27. 1 Almost simultaneously another cable was dispatched by Captain de Limperany, secretary of the Commission of Delimitation to the Conference of Ambassadors in Paris, to inform them of the tragic news.2 3 * * The events that were now to move with such breath taking speed were to be centered in three cities, Rome, London and Paris. Throughout the first days the advantage of initiative was to be in the hands of Rome, while the latter two cities would be straddled with the unappetizing role of merely reacting to actions already instituted in Rome. Mussolini’s reaction upon the arrival of the tragic news from Janina was, according to an eye witness, the then chief of the Near Eastern Divi sion of the Foreign Office, "immediately violent, intransigeant”.9 His cable in the early morning hours of August 28 to the Italian Minister in Athens, Giulio Cesare Montagna, is revealing. The Duce felt that "without diminishing seriously the responsibility that is incumbent upon Greece, immediate and exemplary punishment of the culprits is indis- 1. Liverani (Janina) to Mussolini, repeated to Athens, August 27, 1923. -

The Japanese and Italian Foreign Ministry in the 1930S1
Segle XX. Revista catalana d’història, 7 (2014), 1-12 ISSN: 1889-1152 Axis Diplomacy in Comparison: The Japanese and Italian Foreign Ministry in the 1930s1 Ken Ishida University of Chiba (Japan) The conventional wisdom about the Tripartite Alliance between Italy, Ger- many and Japan was that the decision-makers of these three countries shared their sense of international isolation. The three Axis powers lacked not only the united ideology but also common interests, and therefore the substance of the alliance was very hollow.2 However, it must also be said that there are relatively few works that examine this conventional wisdom through detailed comparative analyses of Nazi Germany, Fascist Italy and ultranationalist Japan, and as a result, there is a tendency for the historians to accept it uncritically.3 This article is in- tended to tackle this shortcoming of historiography by offering an analysis from comparative perspective. It will concentrate on examining the commonalities and differences between Italy and Japan, specifically on the role of diplomats and foreign ministries in diplomatic policy-making process of respective nations. 1 Rebut: 15.09.2014 – Acceptat: 11.11.2014 2 ken ishida, “the german-japanese-italian axis as seen from fascist italy,” ed. by kudo akira, tajima nobuo and erich pauer, japan and germany: two latecomers to the world stage, 1890-1945. vol. ii: the pluralistic dynamic of the formation of the axis, (folkestone: global oriental ltd, 2009), pp. 262-301. 3 Some of the few works that make a comparative analysis among these three nations are; Paul Brooker, The Faces of Fraternalism: Nazi Germany, Fascist Italy, and Imperial Japan, (Oxford: Cla- rendon Press, 1991); Bernd Martin, Japan and Germany in the Modern World, (Providence: Bergh- ahn Books, 1995); MacGregor Knox, Common Destiny: Dictatorship, Foreign Policy, and War in Fascist Italy and Nazi Germany, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000); Aristotle A.