MASSA CARRARA a Cura Di: P
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Popolazione Delle Frazioni Geografiche E Delle Località Abitate Dei Comuni (20 Faseicoli 1'Egionali E Una Appenrliee Con Le Tavole Riassuntive) Voi
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 11° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 24 OTTOBRE 1971 VOLUME III POPOLAZIONE DELLE, FRAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE LOCALITA ABITATE, DEI COMUNI FASCICOLO 9 TOSCANA ROMA - 1974 06 74 - Contratto del 20-12-1972 - (c. 1.400) - Soc. A.B E.T.E. - Roma INDICE AVVERTENZE . Pago V PROVINCIA DI MASSA-CARRARA TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ......................... » 2 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate . » 3 PROVINCIA DI LUCCA TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ......................... » 12 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate ..... » 13 PROVINCIA DI PISTOIA TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ......................... » 30 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate ... .. » 31 PROVINCIA DI FIRENZE TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ...... ................. » 38 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate .... » 39 ì 1 t IV i lNDICE I ! I I PROVINCIA DI LIVORNO TAVOLA 1 - Superficie territoliale e jdensità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e ~ei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata .1... !. Pago 56 I TAVOLA 2 - Altitudine e pop~~~zio~e iresidente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle locahta ablt,te . -

Piano Strutturale E Al Regolamento Urbanistico Vigenti Del Comune Di Gaiole in Chianti PIANO STRUTTURALE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
+ D.C.C. n. 2 del 04/03/2015 Varianti puntuali al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico vigenti del Comune di Gaiole in Chianti PIANO STRUTTURALE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ....................................................................................... 5 Art. 1 - Natura e funzioni del Piano Strutturale ............................................................ 5 Art. 2 - Efficacia del P.S. ................................................................................................ 5 Art. 3 - Attuazione del P.S. ............................................................................................ 6 Art. 4 - Elaborati del P.S. ............................................................................................... 6 TITOLO II - DISCIPLINA STRUTTURALE DEL TERRITORIO E STATUTO DEI LUOGHI .............. 10 Art. 5 - Sistemi territoriali ........................................................................................... 10 Art. 5/bis - Invarianti strutturali ................................................................................. 11 Art. 5/ter - Obiettivi della parte gestionale del Piano ................................................ 12 CAPO I - SISTEMA DEL FONDOVALLE ............................................................................... 13 Art. 6 - Subsistema del territorio aperto di fondovalle .............................................. 13 Art. 7 - UTOE fondovalle asciutto .............................................................................. -
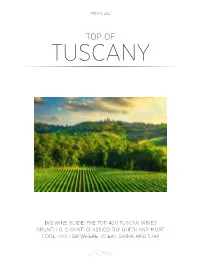
Top of Tuscany
SPECIAL 2021 TOP OF TUSCANY BIG WINE GUIDE: THE TOP 400 TUSCAN WINES BRUNELLO, CHIANTI CLASSICO, BOLGHERI AND MORE COOL TIPS FOR WHERE TO EAT, DRINK AND STAY Contents 05 Trends & facts 2020/2021 08 The three tenors Legends that have made history 14 The magnificent seven Talents of the year 19 Top 5 white wines The best white wines of the year 20 Top 10 red wines Editorial The best red wines of the year 22 Best buys 2020 10 wines offering top value for money ow that our lives are centred primarily on our own gardens and our own wine cellars (where time and finances allow), we have much more leisure 24 Vernaccia San Gimignano to do what we wish. COVID-19 has affected many things, including our N 28 Maremma view of ourselves as wine connoisseurs and quasi-globetrotters. The majority of our tours of Italy and Tuscany planned for spring and summer 32 Morellino die Scansano DOCG 2020 were limited to the works of Fruttero & Lucentini (especially their ’The Pal- io of Dead Riders’, the best Siena book of all) and to exploring the depths of var- 35 Montecucco ious bottles of mature Brunello, Chianti Classico, Vino Nobile or Bolgheri Supe- 38 Brunello di Montalcino riore. However, things will eventually change, and if you should find the time to flick through this edition of Top of Tuscany as you rekindle your wanderlust with 46 Vino Nobile die Montepulciano a glass of Tignanello or Masseto, we would be delighted. The following pages offer a colourful mix of wine stories, and above all a wealth 50 Chianti Classico DOCG of bottles tasted: we have selected more than 400 from all over Tuscany, with 145 granted the ’Top of Tuscany’ accolade. -

Chianti Classico Indice / Index
CHIANTI CLASSICO INDICE / INDEX pagina page 2 PASSAPORTO 14 PASSPORT 3 IL TERRITORIO 15 THE TERRITORY 4 PIRAMIDE DELLA QUALITÀ 16 THE QUALITY PYRAMID 6 L’originALE 18 THE ORIGINAL 8 LA STORIA 20 THE HISTORY 10 IL CONSORZIO 22 THE CONSORTIUM 11 LA LEGGENDA 23 THE LEGEND 12 NON SOLO VINO 24 NOT JUST WINE 25 AZIENDE 25 WINE ESTATES VINITALY | 2018 CHIANTI CLASSICO PASSAPORTO Nome Chianti Classico DOCG Anno di nascita 1716: si delimitano i confini della zona di produzione Luogo di nascita Territorio che comprende, tra le province di Firenze e Siena, i comuni di: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti e Radda in Chianti per intero e, in parte, quelli di Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa Estensione del territorio 70.000 ha Superficie vitata del territorio 10.000 ha Vigneti iscritti all’albo del 7.200 ha Chianti Classico Uvaggio indicato Sangiovese: da un minimo di 80% a un massimo di 100% dal disciplinare Altri vitigni autorizzati a bacca rossa (autoctoni o internazionali): di produzione massimo 20% Produzione media annua in bottiglie 35/38 millioni (ultimi 10 anni) Produzione media annua in ettolitri 270.000 hl (ultimi 10 anni) Soci Consorzio Vino Chianti Classico 523 di cui 315 imbottigliatori ESPORTATO IN 130 PAESI NEL 2017 Italia 23% Stati Uniti 33% Germania 12% Canada 8% Paesi Scandinavi 5% Regno Unito 4% Svizzera 3% Giappone 3% Benelux 2% Cina e Hong Kong 2% ITALIANO Russia 1% Francia 1% Altri Paesi 3% 2 VINITALY | 2018 CHIANTI CLASSICO IL TERRITORIO -

Paolino Pieri, Croniche Di Firenze, Edizione Critica
Università degli Studi di Padova Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna Classe LM-14 Tesi di Laurea Paolino Pieri, Croniche di Firenze, edizione critica. Relatore Laureando Prof. Davide Cappi Andrea Bego n° matr.1103748 / LMFIM Anno Accademico 2015 / 2016 Indice ♦ Introduzione......................................................................................................1 ♦ Descrizione del manoscritto.............................................................................5 ♦ Criteri di trascrizione e di edizione..................................................................7 ♦ Paolino Pieri, Croniche...................................................................................11 ♦ Note storiche...................................................................................................87 ♦ Glossario.......................................................................................................121 ♦ Indice dei nomi di persona...........................................................................125 ♦ Indice dei nomi di luogo e di nazionalità.....................................................133 ♦ Appendice.....................................................................................................141 ♦ Bibliografia...................................................................................................145 Introduzione 1 Le cronaca di Paolino Pieri (o «Paulino di Piero» 1.2-3) ci è pervenuta in copia unica nel ms. Magliabechiano -

Procedura Esecutiva Contro PALLANTI PAOLO Procedura: (71/2015) Registro: Esecuzioni Immobiliari
ISTANZA N. 1 24/10/2017 Descrizione: Relazione valutativa immobiliare Procedura esecutiva contro PALLANTI PAOLO Procedura: (71/2015) Registro: Esecuzioni Immobiliari Giudice Delegato: F. Mennella Ufficio: Tribunale ordinario di Siena Firmato Da:ANDREA PETRENI EmessoDa: INFOCERT FIRMAQUALIFICATA Serial#:2 567418 Volume Unico TRIBUNALE di SIENA SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI REG. GEN. ESECUZIONI 71/2015 P A L L A N T I P A O L O C Esecuzione Immobiliare 71/2015 Firmato Da:ANDREA PETRENI EmessoDa: INFOCERT FIRMAQUALIFICATA 2 Serial#: 567418 relazione valutativa del compendio immobiliare 0 TRIBUNALE CIVILE DI SIENA ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 71/2015 LE CASE CLASSICHE SOC. COOP. EDIFICATRICE a R.L. contro PALLANTI PAOLO RELAZIONE DEL CONSULENTE VALUTATORE GIUDIZIARIO relativa alla valutazione della piena proprietà di più unità immobiliari di cui una attualmente utilizzata ad ufficio e posta al piano terra e primo (oltre soppalco) di un fabbricato in Via Bettino Ricasoli n. 43 in Gaiole in Chianti e le altre di terreni (collinari) in località Montegrossi in Gaiole in Chianti. Delle seguenti proprietà: Pallanti Paolo natonato a Gaiole in Chianti il 23 ottobre 1962 residente in Gaiole in Chianti località Montegrossi n. 29 C.F.: PLL PLA 62R23 D858N Il sottoscritto dottor Andrea Petreni con studio in Siena Via dei Montanini n. 63, consulente estimatore presso il tribunale di Siena e alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura al ruolo dei periti e degli esperti (categoria: attività varie; sub- categoria 010), veniva nominato consulente stimatore del tribunale di Siena in data 25 marzo 2017 mobiliare rubricata al numero 71/2015 in ordine alla valutazione del compendio immobiliare summenzionato. -

Ambito 32 Chianti 4
Ambito n°32 CHIANTI PROVINCE : Firenze, Siena TERRITORI APPARTENENTI AI COMUNI : Barberino Val d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga , Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Poggibonsi, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Impruneta Sezione 4 Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 1 P r o v i n c i a d i S i e n a A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI superficie territori della Toscana tipologia art. 136 D.Lgs. codice D.M. – G.U. denominazione comune (ha) (Atlante dei paesaggi) 42/04 9052073 D.M.23/05/1972 Zona di Volpaia sita nel comune di Radda in 2608,86 Chianti G.U.15/1973dec Radda in Chianti Chianti a b c d La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché comprende un bellissimo comprensorio collinare, ricco di uliveti, cipressi e boschi che incorniciano complessi monumentali ed insediamenti particolarmente qualificati in senso ambientale e paesistico, quali Volpaia, Capaccia, Albola, motivazione Villa Castelvecchi; tale ambiente, costellato anche da tipiche case rurali, si determina come uno dei paesaggi meglio caratterizzati della campagna toscana, notevolmente qualificata in maniera omogenea e godibile da molti punti di vista, in particolare dal belvedere di Radda. tipi di paesaggio B) IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA B1. Elementi rilevati alla data di istituzione del vincolo e valutazione della loro permanenza ad oggi elementi di valore permanenza dei valori – elementi di degrado morfologia idrografia naturale e antropica mosaico agrario Uliveti, cipressi e boschi Sebbene l’olivo e la vite costituiscano ancora gli elementi vegetazionali caratteristici dell’area di vincol o, la elementi riconversione produttiva avvenuta in campo agricolo ha mutato le loro forme di allevamento rispetto alla vegetazionali tradizionale coltura promiscua data dalla consociazione di vite e olivo. -

BP Chianti Classico + Chianti 2013, Layout 1
Die besten Weinproduzenten Chianti Classico DOCG + Chianti DOCG + Chianti IGT Die hier folgenden Bewertungen der Weingüter enthalten die über viele Jahre kumulierten Ergebnisse von Degustationen, die ausnahmslos blind durchgeführt wurden und werden. Die neuesten Ergebnisse stammen meistens aus den alljährlichen Ante- prima-Verkostungen, an denen sich jeweils im Februar Weinjournalisten aus der ganzen Welt über mehrere Tage mit den neu- en Weinen aus dem Chianti-Gebiet, San Gimignano, Montalcino (Brunello) und Montepulciano (Vino Nobile ) beschäftigen. Im Februar 2013 wurden in verschiedenen Veranstaltungen präsentiert: Chianti 2011 und ältere, Chianti Classico Jahrgang 2010, 2009 und 2008 sowie Riserva 2009 und Fassproben des Jahrgangs 2011. Die weine aus San Gimignano, Motepulciano und Montalcino finden Sie in separaten Listen. Ebenso die Supertuscans. Das Chianti Classico Consortium hat in diesem Jahr die Journalisten aufgefordert, die Bezeichnung Chianti Classico stets nur ausgeschrieben zu verwenden und nicht abzukürzen. Man will sich offenbar deutlich von den Weinen, die im Chianti-Consortium zusammengeschlossen sind, abgrenzen. Hier deshalb einige Erklärungen zur besseren Unterscheidung: Im Consorzium Chianti sind 2.650 Betriebe zusammengeschlossen, die in den Zonen Colli Arettini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli und Rufina 10.500 h Weinberge bearbeiten. Die jährliche Produktion beträgt 600.000 Hektoliter. Zum Consorzium Vini Chianti Classico gehören aktuell 560 Produzenten. Sie bewirtschaften 10.000 ha, von denen 7.200 als Chi- anti Classico DOCG registriert sind. Das im vergangenen Jahr abgefüllte Weinvolumen von 270.000 Hektolitern hat einen Wert von über 360 Millionen Euro. Der Umsatz mit Oliven und Olivenöl beläuft sich auf weitere 10 Mio. Euro, andere landwirtschaftli- che Erzeugnisse bringen weitere 90 Mio und der Tourismus 75 Mio. -

Chianti Castles and Chianti Castles Route
Casa Pancole Holiday Home Chianti Castles and Chianti Castles Route CASA PANCOLE, Località Pancole 161, 52022, Cavriglia (AR), Italy Map coordinates: 43°30'59.2"N 11°30'51.0"E Telephone Number: (+39) 3498419058 - Email: [email protected] - www.casapancole.it Casa Pancole Holiday Home Anyone who has visited the Chianti Castles, even a few hours, remembers them with passion. They are wonderful places, impossible to forget. A real "must" for anyone who wants to visit Chianti and discover its true soul. Castles have always occupied a special place in the collective imagination, full of mystery, romance and poetry. They appear majestic, when you come into contact with them you feel small and magically manage to transport you back in time, thinking of the dark period of the Middle Ages, the Renaissance, etc. Visiting one of these ancient buildings means coming into direct contact with the history, culture and legends of Chianti. CASA PANCOLE, Località Pancole 161, 52022, Cavriglia (AR), Italy Map coordinates: 43°30'59.2"N 11°30'51.0"E Telephone Number: (+39) 3498419058 - Email: [email protected] - www.casapancole.it Casa Pancole Holiday Home Brolio Castle – Gaiole in Chianti The Brolio Castle is located in Brolio, near San Regolo, in the municipality of Gaiole in Chianti, in the province of Siena. The toponym "Brolio", deriving from the Celtic (Gallic) term "Brogilo", with its name Oltramontano refers to an era before the thousand when it designated for Broilo or Brolio "a wild estate with a fence reduced to domestic, and in the midst of this is the castle for his lord's house ”. -

Relazione Ed Allegati
INDAGINI GEOLOGICO – APPLICATE 2010 QUADRORelazione CONOSCITIVO finale e allegati tecnici ASSESSORE ALL’URBANISTICA , PIANIFICAZIONE TERRITORIALE MARCO MACCHIETTI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. MASSIMO BETTI DIRETTORE AREA POLITICHE DEL TERRITORIO ING. FABIO GALLI GARANTE DELLA COMUNICAZIONE DOTT. GIOVANNI IOZZI PROGETTISTA ARCH. SILVIA VIVIANI GRUPPO DI PROGETTAZIONE ARCH. TERESAARRIGHETTI ASPETTI PAESAGGISTICI ARCH. EMANUELA MORELLI COLLABORATORI ARCH. CHIARA AGNOLETTI ARCH. LEONARDO RIGNANESE ARCH. ANTONELLA SALETTI DOTT.SSA LETIZIA COLTELLINI DOTT. DEVID ORLOTTI VALUTAZIONE INTEGRATA PROF. VINCENZO BENTIVEGNA ARCH. ANNALISA PIRRELLO ARCH. GABRIELE BARTOLETTI ARCH. LUCIA NINNO GRUPPO DI LAVORO ASPETTI GEOLOGICO APPLICATI Idrogeologia e Geologia Tecnica Pianificatoria PROF. PIERO BARAZZUOLI GEOL. FAUSTO CAPACCI GEOL. JENNY MIGLIORINI GEOL. ROBERTO RIGATI Dipartimento di Scienze della Terra - Università di Siena STUDIO SUI GEOSITI PROF. ARMANDO COSTANTINI Università di Siena GRUPPO DI LAVORO ASPETTI ECONOMICI AREE PRODUTTIVE ED AGRITURISMI DOTT. ORAZIO FIGURA - Direttore area Politiche Economiche Provincia di Siena DOTT. DOMENICO NEVOSO - Eurobic Toscana Sud S.p.A. GRUPPO DI LAVORO INDAGINE CONOSCITIVA PIANI STRUTTURALI, REGOLAMENTI URBANISTICI E PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE Ufficio Assetto del Territorio Provincia di Siena: ARCH. FAUSTO DE ANDREIS ARCH. LETIZIA GIULIANI ARCH. DANIELA GIURA GEOL. BENEDETTA MOCENNI GEOM. SIMONA RAPPUOLI ARCH. ADELE SEMERARO CON I CONTRIBUTI DI: SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA: AREA TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE DIR. ING. FABIO GALLI, ARCH. MASSIMO BETTI PROVINCIA DI SIENA AREA POLITICHE ECONOMICHE DIR. DOTT. ORAZIO FIGURA SVILUPPO RURALE DIR. DOTT. PAOLO BUCELLI AREA POLITICHE DELL’AMBIENTE DIR. DOTT. PAOLO CASPRINI AREA RISORSE NATURALI DIR. GIAMPIERO SAMMURI, DOTT.SSA DOMITILLA NONIS CONSORZIO TERRE CABLATE PIANO TERRITORIALE DI INDAGINICOORDINAMENTO GEOLOGICO-APPLICATE PROVINCIALE Approvato con D.C.P. -

Die 300 Jahre Des Ersten Weinbaugebietes
Die 300 Jahre des ersten Weinbaugebietes. CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE – RISERVA – ANNATA MÜNCHEN, 10. OKTOBER 2016 Chianti Classico INHALTSVERZEICHNIS Seite 2 DAS ANBAUGEBIET 4 STECKBRIEF 6 DIE CHIANTI CLASSICO PYRAMIDE 8 DAS ORIGINAL 10 GRAN SELEZIONE 12 SAALPLAN 14 PECORINO ToSCANO DOP 16 PROSCIUTTO ToSCANO DOP 18 WEINGÜTER Chianti Classico DAS ANBAUGEBIET Italien Mailand Venedig Rom FLORENZ S. Casciano in Val di Pesa Toskana Tavarnelle Val di Pesa Greve in Chianti Barberino Val d’Elsa Radda in Chianti Poggibonsi Castellina Gaiole in Chianti in Chianti Castelnuovo Berardenga SIENA Provinz Florenz Provinz of Siena 2 MÜNCHEN | 2016 Chianti Classico DAS ANBAUGEBIET Als weitläufig bewaldete Gegend, überwiegend mit halb ist es nicht möglich, im Chianti-Gebiet eine Eichen, Kastanienbäumen, Pinien und vereinzelten Unterteilung nach Gemeinden ausschließlich auf- Zypressen, erstreckt sich das Chianti-Gebiet auf grund der verschiedenen Bodentypen vorzuneh- einer Hochebene zwischen 200 und 800 m üdM., men. Dennoch kann man erkennen, dass der Ga- wobei die maximale Höhenlage für den Anbau von lestro-Boden um San Casciano in Val di Pesa Trauben für den Chianti Classico 700 m beträgt. Es verbreitet ist, ein lehm- kalkhaltiger Boden ty- herrscht Kontinentalklima mit diskreten Tempera- pisch für Greve in Chianti und alle weniger hohen turunterschieden zwischen Tag und Nacht. Im Win- Lagen ist, felsige Stücke aus überwiegend Sand- ter sinkt die Temperatur stark ab, auch auf we- gestein auf dem Kamm von Monti in Chianti auf- niger als 4-5 Grad, und in den trockenen, heißen treten, Alberese-Gestein vornehmlich im mittleren Sommern überschreitet sie nicht selten 35 Grad. bis südlichen Teil des Gebietes auftritt und Tuff- Unter geologischem Gesichtspunkt kann die Bo- stein einen guten Teil der Gegend um Castelnuo- denbeschaffenheit als tonhaltiger Schiefer (Ga- vo Berardenga prägt. -

— Conversations with New Master Sommeliers: David Keck MS, Camerata at Paulie's Kim Kyungmoon MS, the Modern Jim Rolls
— Conversations with New Master Sommeliers: David Keck MS, Camerata at Paulie’s pg. 3 Kim Kyungmoon MS, The Modern pg. 7 Jim Rollston MS, Manresa pg. 11 — STAR LISTINGS (1,000+ wines) pg. 16 USA: Top 2013 & 2014 Pinot Noirs (Sonoma pg. 17 Coast, Russian River Valley, Anderson Valley) — Superb 2012 & 2013 Cabernet Sauvignons pg. 25 (Napa Valley, Alexander Valley, Paso Robles) — Germany: 311 Rieslings (mostly 2014), pg. 48 Silvaners, Pinot Blancs/Gris & Pinot Noirs — Italy: Chianti Classico – 200 recommended pg. 72 wines from vintages 2007-2014 — Also: Outstanding wines from Argentina, Australia, Chile, France, New Zealand, Portugal, South Africa & Spain www.restaurantwine.com/subscribe Issues #166, #167 & #168 ★ ★ ★ ★ ★ Italy CHIANTI CLASSICO ★ ★ ★ ★ ★ PICCINI, 2011 CHIANTI CLASSICO, $136 ($17) HHH+ Round and full bodied, this Chianti Classico is crisp on the palate, and tastes of red currant, plum, and black tea. Very good value. 90% Sangiovese, 10% Merlot. Aged 15 months in oak barrels and casks. 13% [2017-2018] Epic Wines, Santa Rosa, CA 800.568.8851 PODERE L’AJA, 2013 CHIANTI CLASSICO, HHHH $192 ($24) Supple and ripely flavored, this is an excellent wine; it is full bodied, well balanced, and long on the finish, tasting of red currant, cherry, rosehips, and light oakiness. Excellent value. Aged 12 months in Slavonian oak casks. Radda in Chianti. 13% [2017-2019] ROCCA DI CASTAGNOLI SOC. AGR., HHHHH 2013 CHIANTI CLASSICO, $176 ($22) Outstanding Chianti Classico: intensely flavored (black cherry, violet, pepper, plum), round, crisp and long on the palate, with a persistent, lightly tannic finish. Superb quality and value. Can be aged a bit.