Rapporto Ambientale Variante PS 300Dpi.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Torniella - Farma
Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana (E. Repetti) http://193.205.4.99/repetti/ Torniella - Farma ID: 4148 N. scheda: 51010 Volume: 5; 6S Pagina: 539 - 540; 91 ______________________________________Riferimenti: 32390 Toponimo IGM: Torniella - Podere la Pieve (a O) - Torrente Farma (a N) Comune: ROCCASTRADA Provincia: GR Quadrante IGM: 120-3 Coordinate (long., lat.) Gauss Boaga: 1675316, 4771369 WGS 1984: 11.15432, 43.07633 ______________________________________ UTM (32N): 675380, 4771543 Denominazione: Torniella - Farma Popolo: S. Giovanni Battista a Torniella Piviere: S. Giovanni Battista a Torniella Comunità: Roccastrada Giurisdizione: Roccastrada Diocesi: Grosseto Compartimento: Grosseto Stato: Granducato di Toscana ______________________________________ TORNIELLA in Val di Merse. - Villaggio che fu Castello, con chiesa plebana (S. Gio. Battista) il cui popolo è compreso nella Comunità Giurisdizione e circa 6 miglia toscane a settentrione di Roccastrada, Diocesi e Compartimento di Grosseto. Risiede sulla schiena de'poggi che propagansi verso grecale da quelli di Rocca Tederighi e di Sassofortino per separare il vallone della Farma , fiumana tributaria della Merse dalle vallecole del Gretano e del Lanzo , due torrenti che scendono a vuotarsi presso Paganico nel fiume Ombrone. La pieve di Torniella con la distrutta cappella di S. Sicudera è nominata tra quelle confermate ai vescovi di Grosseto dal pontefice Clemente III mercé di una bolla concistoriale data in Laterano lì 12 aprile del 1188. Fu il Castello di Torniella dominato un tempo da una consorteria di nobili detti i signori di Torniella e di Sticciano , ai quali apparteneva quel Ranieri che nel 1233, per atto pubblico del 17 maggio rogato nella chiesa di Monticiano, unitamente ad un suo figlio, Alberto, allivellò in perpetuo al Comune e uomini di Torniella tutti i beni di suolo che ivi possedeva a condizioni, le quali furono anche ratificate da donna Diana moglie di detto signore. -

Viva Xpress Logistics (Uk)
VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) Tel : +44 1753 210 700 World Xpress Centre, Galleymead Road Fax : +44 1753 210 709 SL3 0EN Colnbrook, Berkshire E-mail : [email protected] UNITED KINGDOM Web : www.vxlnet.co.uk Selection ZONE FULL REPORT Filter : Sort : Group : Code Zone Description ZIP CODES From To Agent IT ITAOD04 IT- 3 Days (Ex LHR) Cities & Suburbs CIVITELLA CESI 01010 - 01010 CELLERE 01010 - 01010 AZIENDA ARCIONE 01010 - 01010 ARLENA DI CASTRO 01010 - 01010 FARNESE 01010 - 01010 LATERA 01010 - 01010 MONTEROMANO 01010 - 01010 ONANO 01010 - 01010 PESCIA ROMANA 01010 - 01010 PIANSANO 01010 - 01010 TESSENNANO 01010 - 01010 VEIANO 01010 - 01010 VILLA S GIOVANNI IN TUSC 01010 - 01010 MUSIGNANO 01011 - 01011 CELLENO 01020 - 01020 CHIA 01020 - 01020 CASTEL CELLESI 01020 - 01020 CASENUOVE 01020 - 01020 GRAFFIGNANO 01020 - 01020 LUBRIANO 01020 - 01020 MUGNANO 01020 - 01020 PROCENO 01020 - 01020 ROCCALVECCE 01020 - 01020 SAN MICHELE IN TEVERINA 01020 - 01020 SERMUGNANO 01020 - 01020 SIPICCIANO 01020 - 01020 TORRE ALFINA 01020 - 01020 TREVIGNANO 01020 - 01020 TREVINANO 01020 - 01020 VETRIOLO 01020 - 01020 ACQUAPENDENTE 01021 - 01021 CIVITA BAGNOREGIO 01022 - 01022 BAGNOREGIO 01022 - 01022 CASTIGLIONE IN TEVERINA 01024 - 01024 GROTTE SANTO STEFANO 01026 - 01026 MAGUGNANO 01026 - 01026 CASTEL S ELIA 01030 - 01030 CALCATA 01030 - 01030 BASSANO ROMANO 01030 - 01030 FALERIA 01030 - 01030 FABBRICA DI ROMA 01034 - 01034 COLLEMORESCO 02010 - 02010 COLLI SUL VELINO 02010 - 02010 CITTAREALE 02010 - 02010 CASTEL S ANGELO 02010 - 02010 CASTEL SANT'ANGELO 02010 -

COLLINE METALLIFERE E GOLFO DI FOLLONICA Met2204 ITA.Qxp 14/05/2004 12.29 Pagina 2 Met2204 ITA.Qxp 14/05/2004 12.29 Pagina 3
Met2204_ITA.qxp 14/05/2004 12.29 Pagina 1 TOSCANA MAREMMA COLLINE METALLIFERE COLLINE METALLIFERE E GOLFO DI FOLLONICA Met2204_ITA.qxp 14/05/2004 12.29 Pagina 2 Met2204_ITA.qxp 14/05/2004 12.29 Pagina 3 INTRODUZIONE isitare le Colline Metallifere vuol dire avere una nuova idea della natura, dell'arte, dei colori e dei sapori della Maremma. Quello che colpisce è la varietà del territo- rio, mai uguale nel suo estendersi ma ricco di mille sfaccettature. Un litorale fatto Vdi candide spiagge incorniciate da rigogliose pinete e bagnato da un limpido mare, è fra gli ambienti marini più accessibili e belli della costa tirrenica. L'ampio golfo di Follonica e gran parte del territorio di Scarlino si specchiano su queste calde acque navigate fin dall'antichità, da quando dalla vicina isola d'Elba le navi cariche di ferro scaricavano il mate- riale per le fonderie. Salendo verso l'entroterra la realtà siderurgica si fonde con l'altra caratteristica di questo territorio: le risorse minerarie. Già il nome "Colline Metallifere" ricorda gli altri fiori di questa terra. Una terra da sempre regno delle miniere dove si estrae- vano e si lavoravano, nelle varie epoche, il ferro, il rame, il piombo, lo zinco, la pirite, e l'ar- gento. Qui la presenza dell'uomo è stata chiaramente indirizzata non alla meticolosa lavo- razione dei campi, come in gran parte della Maremma, ma allo sfruttamento delle ricchezze minerarie. Ci sono tracce ovunque, come testimoniano i resti degli antichi forni e delle miniere di epoca etrusco-romana, le discariche di materiale di epoca medievale e agli impo- nenti ruderi delle miniere contemporanee. -

Federico Selvi a Critical Checklist of the Vascular Flora of Tuscan Maremma
Federico Selvi A critical checklist of the vascular flora of Tuscan Maremma (Grosseto province, Italy) Abstract Selvi, F.: A critical checklist of the vascular flora of Tuscan Maremma (Grosseto province, Italy). — Fl. Medit. 20: 47-139. 2010. — ISSN 1120-4052. The Tuscan Maremma is a historical region of central western Italy of remarkable ecological and landscape value, with a surface of about 4.420 km2 largely corresponding to the province of Grosseto. A critical inventory of the native and naturalized vascular plant species growing in this territory is here presented, based on over twenty years of author's collections and study of relevant herbarium materials and literature. The checklist includes 2.056 species and subspecies (excluding orchid hybrids), of which, however, 49 should be excluded, 67 need confirmation and 15 have most probably desappeared during the last century. Considering the 1.925 con- firmed taxa only, this area is home of about 25% of the Italian flora though representing only 1.5% of the national surface. The main phytogeographical features in terms of life-form distri- bution, chorological types, endemic species and taxa of particular conservation relevance are presented. Species not previously recorded from Tuscany are: Anthoxanthum ovatum Lag., Cardamine amporitana Sennen & Pau, Hieracium glaucinum Jord., H. maranzae (Murr & Zahn) Prain (H. neoplatyphyllum Gottschl.), H. murorum subsp. tenuiflorum (A.-T.) Schinz & R. Keller, H. vasconicum Martrin-Donos, Onobrychis arenaria (Kit.) DC., Typha domingensis (Pers.) Steud., Vicia loiseleurii (M. Bieb) Litv. and the exotic Oenothera speciosa Nutt. Key words: Flora, Phytogeography, Taxonomy, Tuscan Maremma. Introduction Inhabited by man since millennia and cradle of the Etruscan civilization, Maremma is a historical region of central-western Italy that stretches, in its broadest sense, from south- ern Tuscany to northern Latium in the provinces of Pisa, Livorno, Grosseto and Viterbo. -

Antonio Gamberi Non Ci Ha Lasciato Una Memoria Sulla Sua Vita E Non
ANTONIO GAMBERI, ATEO CONVINTO E FERMO SOCIALISTA APPUNTI PER UNA BIOGRAFIA FRANCO BERTOLUCCI Antonio Gamberi non ci ha lasciato una memoria sulla sua vita e non esistono al momento testimonianze o documenti provenienti dall’ambito familiare; chi volesse tracciare il percorso biografico di questo personag- gio deve far riferimento alla documentazione conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato nel fondo del Casellario Politico Centrale dove esiste un fascicolo nominativo, che raccoglie però alcune carte molto sintetiche e incoerenti, o sfogliare i giornali dell’epoca, sui quali la poliedrica penna del poeta maremmano ha lasciato diversi scritti, molti dei quali però sigla- ti con pseudonimi non sempre facilmente decifrabili. L’unica eredità do- cumentaria sufficientemente ampia è la produzione poetica, raccolta, quella edita, in una manciata di volumi e opuscoli pubblicati tra il 1907 e il 1937, a parte una pubblicazione postuma edita da un gruppo di amici del poeta nel 1948. Ma la poesia può essere una fonte utile ed attendibile per ricostruire la biografia di un personaggio che, come Gamberi, ha vis- suto a cavallo di due secoli con una militanza politica durata quasi mezzo secolo? Con la consapevolezza di alcuni inevitabili limiti e con il supporto di fonti storiche alternative abbiamo qui deciso di utilizzare la poesia di Gamberi come una fonte storica, un diario delle esperienze, dei sentimen- ti, delle emozioni e delle passioni del poeta, una testimonianza degli avve- nimenti dell’epoca sia limitati al territorio regionale della Maremma To- scana, come le condizioni di vita e le malattie che colpiscono i minatori, il lavoro nei campi, l’emigrazione… che nazionali e internazionali, come i primi grandi eventi rivoluzionari del XX secolo – dalla rivoluzione russa a quella spagnola –, l’avvento del fascismo, la morte di personaggi illustri da Andrea Costa a Mario Rapisardi, da Karl Liebknecht a Max Nordau. -

Asd Alberese Usd Albinia
ELENCO SOCIETA’ DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO Stagione Sportiva 2018/2019 ASD ALBERESE Matricola : 1200 Categoria : Prima Codice impianto : 224 Colori Sociali Bianco Nero (Amaranto) Sede Sociale Piazza del Combattente n.17 D – Alberese 58100 - GROSSETO Corrispondenza Piazza del Combattente n.17 D – Alberese 58100 - GROSSETO Campo di giuoco Stadio ― O.Francioli ― - Strada del Cimitero, snc - 58100 Alberese (GR) Numero telefono Società 347 5332652 Presidente Fantoni Alessandro Tel. 348 2482860 mail [email protected] Segretario Pegoraro Alessandro Tel. 347 5332652 Responsabile SGS Dirigente chiamate urgenti Pegoraro Alessandro Tel. 347 5332652 Referente Telegram Pegoraro Alessandro Tel. 347 5332652 USD ALBINIA Matricola : 1310 Categoria : Promozione Codice impianto : 253 Colori Sociali Rosso-- Blu Sede Sociale Via Raffi n.26 - Albinia 58010 Orbetello (GR) Corrispondenza c/o USD ALBINIA Casella Postale 30 – 58010 Albinia (GR) Campo di giuoco Stadio G.Combi – Via P.Aldi 3 - Albinia Numero telefono Società 0564 871745 Presidente Vettori Cristiano Tel. 338 6496150 mail [email protected] Segretario Molinari Andrea Tel. 339 5912725 Responsabile SGS D’arrigo Antonino Tel. 338 7533628 Dirigente chiamate urgenti Sbrilli Andrea Tel. 347 6784050 Referente Telegram Molinari Andrea Tel. 339 5912725 ASD ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO Matricola : 917422 Categoria : Terza Codice impianto : 240 Colori Sociali Bianco-Verde Sede Sociale Via Firenze n.4 - Arcidosso (GR) Corrispondenza Via Firenze n.4 - 58031 Arcidosso (GR) Campo di giuoco Comunale di Arcidosso Numero telefono Società 331 3654913 Presidente Deriu Emanuele Tel. 331 3654913 mail [email protected] Segretario Rapposelli Alberto Tel. 353 3551276 Dirigente chiamate urgenti Deriu Emanuele Tel. 331 3654913 Referente Telegram ASD ALTA MAREMMA Matricola : 750082 Categoria : Seconda Codice impianto : 263 Colori Sociali Giallo-Nero (Rosa-Nero) Sede Sociale c/o Centro Civico - 58029 Sassofortino (GR) Corrispondenza c/o Poli Ilario - Via delle Cortine n.76/C - 58036 Roccatederighi (GR) Campo di giuoco "Cecchi Gori" - loc. -

Buon Giorno Und Herzlich Willkommen
BUON GIORNO UND HERZLICH WILLKOMMEN Mit den nachfolgenden Informationen möchte ich Ihnen einen Einstieg, eine Hilfe für Ihren kommenden Aufenthalt in der Maremma, des südlichen Teils der Toskana geben. Typisch für diese Landschaft ist die Ebene entlang des Meeres, weite Felder mit Weizen, Mais, Sonnenblumen, Olivenbäumen und Wein. Das war früher Sumpfgebiet - man kann noch einige Entwässerungskanäle sehen. Die Einfahrten zu den Gehöften sind manchmal baumbesäumt mit abwechselnd einer Pinie und einer Zypresse. Dazwischen liegt immer wieder “macchia mediterranea”, ein Niederwald mit vielen verschiedenen, zum Großteil immergrünen Bäumen u. Buschgewächsen. Landeinwärts beginnt es hügeliger und waldiger zu werden. Verstreut liegen kleine Dörfer, manchmal geschwätzig, manchmal verschlafen. In den Orten Roccatederighi, Montemassi, Tatti, Buriano usw. sind noch Reste von früheren Burgen und Festungen zu finden, die z.T. in die heutige Dorfstruktur integriert sind. Von den Felsen von Roccatederighi hat man, besonders bei Sonnenuntergang, einen herrlichen Ausblick. Typisch für dieses Gebiet ist die Korkeiche. Wenn Sie auf Bäume treffen, deren Rinde geschält ist und darunter sehen sie den Stamm in einer rötlichen Farbe: das ist sie. An den Hängen sind Olivenhaine, Wiesen und hier und da ein Weinberg. Und dann kommt Wald, Wald, ..... Was Sie unternehmen können Siena, San Gimignano, Volterra und Montalcino stehen wahrscheinlich in Ihrem Führer. Möchten Sie noch ein paar Tipps der “Einheimischen”? Probieren Sie‘s mit einem Ausflug nach Massa Marittima, einem mittelalterlichen Städtchen mit Dom, einer schönen “Piazza” und einem Bergwerksmuseum. Etruskische Ausgrabungen in Vetulonia, Populonia, Tarquinia, am Accesasee + Roselle. Der Naturpark “Parco dell’ Uccellina” liegt ca. 15 km südlich von Grosseto Richtung Rom, Abfahrt Alberese. -
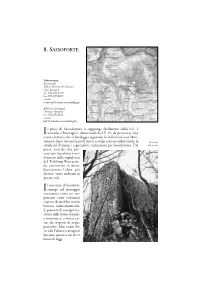
08. Sassoforte*
8. SASSOFORTE Informazioni: Roccastrada Ufficio Turismo del Comune corso Roma, 8 tel.: 0564/561230 fax: 0564/561205 e-mail: [email protected] Biblioteca Comunale “Antonio Gamberi” tel.: 0564/561111 e-mail: [email protected] l paese di Sassofortino si raggiunge facilmente dalla S.S. 1 I uscendo a Braccagni e imboccando la S.P. 19, da percorrere sino a una rotatoria che si bordeggia seguendo le indicazioni per Mon- temassi; dopo un centinaio di metri si volge a destra imboccando la Torre sud strada del Peruzzo e seguendo le indicazioni per Sassofortino. Dal del cassero paese, uno dei due per- corsi per Sassoforte è evi- denziato dalla segnaletica del Trekking Roccastra- da, consistente in strisce biancorosse; l’altro, più diretto, viene indicato in questa sede. l massiccio di Sassoforte I emerge sul paesaggio circostante come un im- ponente cono vulcanico coperto da un folto manto boscoso, caratterizzato dal- la presenza di macigni tra- chitici dalle forme bizzarre e maestose e, a mezza co- sta, da sorgenti di acque purissime. Man mano che si risale l’altura i castagneti lasciano spazio a un ricco bosco di faggi. 110 Guida alla Maremma medievale L’AMBIENTE L’abitato, incastellato almeno dall’XI secolo, dovette la sua fortuna alla ottima posizione strategica sulla via della transumanza e allo svi- luppo di attività manifatturiere locali, quali la coltivazione del croco- zafferano e, all’interno della cinta muraria, la produzione di maioli- che pregiate. Eccezionale, si è detto, appare la posizione strategica del sito, che domina tutta la pianura della Bruna, il versante sud delle Colline Metallifere, le colline di Roccastrada con il Monte Leoni e tutta la vallata del Gretano fino all’Ardenghesca. -

Miniere E Cave Del Comune Di Roccastrada
WALTER SCAPIGLIATI BIBLIOGRAFIA GEOGIACIMENTOLOGICA E STORICO-MINERARIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCASTRADA AGGIORNATO AL GIUGNO 2011 1 MINIERA DI LIGNITE DELL’ACQUANERA (ROCCATEDERIGHI-SASSOFORTINO) AXERIO G., 1868 MINIERE DI LIGNITE PICEA DEL SIGNOR FERRARI-CORBELLI. STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA - INDUSTRIA MINERARIA. RELAZIONI DEGL'INGEGNERI DEL REAL CORPO DELLE MINIERE, pp. 172-183 TIPOGRAFIA TOFANI, Firenze GIACIMENTOLOGIA, GEOLOGIA REGIONALE, ARTE MINERARIA, SISTEMI DI COLTIVAZIONE, STORIA MINERARIA, PRODUZIONE, IMPIEGHI, COMBUSTIBILI FOSSILI, LIGNITE, MINIERE, CASTEANI, RIBOLLA, F.128 IV NO, ACQUANERA, F.120 III SE, COMUNE DI GAVORRANO, COMUNE DI ROCCASTRADA, PROVINCIA DI GROSSETO, TOSCANA BOCCI A., 2000 LE MINIERE DI LIGNITE MAREMMANE DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE. http://utenti.tripod.it/Boccioldmine/ligniti_maremmane.htm, pp. 1-5 BOCCI ADRIO, Gavorrano STORIA MINERARIA, MINIERE, COMBUSTIBILI FOSSILI, LIGNITE, ARTE MINERARIA, SISTEMI DI COLTIVAZIONE, RIBOLLA, CASTEANI, ACQUANERA, MONTEBAMBOLI, BACCINELLO, PRODUZIONE, OCCUPAZIONE, XX SECOLO, 1919-1921, PROVINCIA DI GROSSETO, TOSCANA BOCCI A., 2003 LA MINIERA DI ROCCATEDERIGHI. http://utenti.tripod.it/Boccioldmine/roccatederighi.htm, pp. 1-3 BOCCI ADRIO, Gavorrano GIACIMENTOLOGIA, STORIA MINERARIA, MINIERE, RAME, OFIOLITI, ROCCATEDERIGHI, COMBUSTIBILI FOSSILI, LIGNITE, ACQUANERA, F.120 III SE, COMUNE DI ROCCASTRADA, PROVINCIA DI GROSSETO, TOSCANA BONAZZA R., 1957-1959 PERMESSO DI RICERCA PER LIGNITE “CASA ACQUANERA” (COMUNE DI ROCCASTRADA). RELAZIONE SUL SERVIZIO MINERARIO, ANNO LXVIII, 83, pp. 121-122 CORPO DELLE MINIERE, Roma GIACIMENTOLOGIA, RICERCA MINERARIA, COMBUSTIBILI FOSSILI, MINIERE, LIGNITE, MIOCENE, ACQUANERA, ROCCATEDERIGHI, F.120 III SE, COMUNE DI ROCCASTRADA, PROVINCIA DI GROSSETO, TOSCANA CIPRIANI N., TANELLI G., 1983 RISORSE MINERARIE ED INDUSTRIA ESTRATTIVA IN TOSCANA. NOTE STORICHE ED ECONOMICHE. ATTI E MEMORIE DELL'ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE “LA COLOMBARIA”, 48, pp. -
Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus 49D 49D Grosseto-Roccastrada-Follonica-Piombino Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 49D (Grosseto-Roccastrada-Follonica-Piombino) ha 7 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Follonica Amendola 167: 04:23 - 20:13 (2) Grosseto F.S.: 06:56 - 22:55 (3) Portineria Magona: 04:57 - 20:57 (4) Roccastrada Centro: 06:56 - 22:56 (5) Scarlino Scalo Aurelia: 06:25 - 22:25 (6) Scarlino Scalo Aurelia: 04:05 - 20:05 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 49D più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 49D Direzione: Follonica Amendola 167 Orari della linea bus 49D 59 fermate Orari di partenza verso Follonica Amendola 167: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 04:23 - 20:13 martedì 04:23 - 20:13 Grosseto F.S. mercoledì 04:23 - 20:13 Tarquinia Stadio Via Tarquinia, Grosseto giovedì 04:23 - 20:13 Caravaggio Stadio venerdì 04:23 - 20:13 Viale Caravaggio, Grosseto sabato 04:23 - 20:13 Aldi domenica 04:23 - 20:57 Via Giovanni Fattori, Grosseto Repubblica S.Giovanni Grosseto Pianetto Informazioni sulla linea bus 49D Direzione: Follonica Amendola 167 Pianetto 2 Fermate: 59 Durata del tragitto: 8 min SP Gr 158 La linea in sintesi: Grosseto F.S., Tarquinia Stadio, Caravaggio Stadio, Aldi, Repubblica S.Giovanni, Mago Di Oz Grosseto Pianetto, Pianetto 2, SP Gr 158, Mago Di Oz, Principina Terra, Casotto Venezia, Marina Principina Terra Pingrosso, Marina Quadrivio SS 322, Marina Fiumara, Canova Prima, Campeggio Le Marze, Casotto Venezia Canova Seconda, Le Marze, SP Gr 158, Campeggio Etruria, Castiglione D.P. -

Avviso Al Pubblico Bacino Di Grosseto
AOO GRPM01000E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000150 - 09/01/2021 - C01 - E 120820 AVVISO AL PUBBLICO BACINO DI GROSSETO da lunedì 11 fino a sabato 16 gennaio 2021, oltre alle corse come da programma di esercizio adibite al trasporto studenti presso i plessi scolastici di GROSSETO, saranno provvisoriamente attivate le seguenti corse aggiuntive per il trasporto degli studenti nelle tratte: CORSE ANDATA ore 6.15 da Manciano-Albinia-Grosseto (bis alla corsa 41P711); ore 6.20 da Scansano-Montiano a Grosseto (bis alla corsa 9/G486); ore 6.25 da Sassofortino-Ribolla a Grosseto (bis alla corsa 25R151); ore 6.30 da Falsettaio-Paganico a Grosseto (bis alla corsa 42A420); ore 6.35 da Roccastrada-Montemassi a Grosseto (bis alla corsa 25R551); ore 6.35 da Pari-Paganico a Grosseto (bis alla corsa 26R483); ore 6.35 da Gavorrano-Braccagni a Grosseto (bis alla corsa 3/G709); ore 6.40 da Marsiliana-Albinia a Grosseto (bis alla corsa 41P728); ore 6.45 da Orbetello-Albinia a Grosseto (bis alla corsa 15O211); ore 6.45 da Roccastrada-Paganico a Grosseto (bis alla corsa 25R249); ore 6.45 da Scansano-Montorgiali a Grosseto (bis alla corsa 8/G592); ore 6.47 da Baccinello-Istia a Grosseto (bis alla corsa 6/G795); ore 6.50 da Montepescali-Braccagni a Grosseto (bis alla corsa g21991); ore 6.55 da Riva del Sole-Marina di Grosseto-Grosseto (bis alla corsa 1/G965); ore 6.55 da Alberese-Grosseto (bis alla corsa g15358); ore 6.56 da Ribolla-Castellaccia-Grosseto (bis alla corsa 3/G006); ore 6.56 da Ribolla-Castellaccia-Grosseto (bis alla corsa 43F438); ore -

Civitella Paganico; Campagnatico; Cinigiano Data Indirizzo Minimo Tipologia Mq Usufrutto 13/09/21 Campagnatico Caselle Di Sotto € 6.402 Collabenti
IMMOBILI ALL’ASTA NEI COMUNI DI ROCCASTRADA; CIVITELLA PAGANICO; CAMPAGNATICO; CINIGIANO DATA INDIRIZZO MINIMO TIPOLOGIA MQ USUFRUTTO 13/09/21 CAMPAGNATICO CASELLE DI SOTTO € 6.402 COLLABENTI 21/09/21 CAMPAGNATICO RATTAIONI € 93.260 TERRENO 38HA 21/09/21 LOC. MUCCAIA RIBOLLA € 1.103.375 AZ AGRIC. HA 46 21/09/21 CAMPAGNATICO SAN ANTONIO € 306.956 TERRENI HA 22 22/09/21 RIBOLLA LOC LE VENELLE € 46.815 6,5 VANI 139 22/09/21 RIBOLLA LOC LE VENELLE € 23.657 4 VANI 90 22/09/21 CAMPAG. LOC PIEVE VECCHIA € 526.106 VILLA 440 28/09/21 ROCCASTRADA VIA DELLA FONTE 46 € 33.826 5 VANI 89 28/09/21 ROCCASTRADA CASA MELANI € 82.067 CAPANNONE 28/09/21 ARCILLE VIALE ITALIA € 98.383 NEGOZIO 251 28/09/21 MONTE ANTICO PIEVANELLA € 24.597 TERRENO HA12 28/09/21 MONTE ANTICO PIEVANELLA € 1.210.964 AGRITURIS 28/09/21 ROCCASTRADA PIAZZA GARIBALDI € 31.277 5 VANI 100 7,5 VANI + 226+ 29/09/21 ROCCASTRADA VIA SALVO D’ACQUISTO € 151.470 GARAGE 51 29/09/21 PAGANICO VIA DELLE QUERCE € 141.000 7,5 VANI 174 12/10/21 SASSO D’OMBRONE VIA DEI POGGI 18 € 38.678 4,5 VANI 65 12/10/21 MONTICELLO AMIATA LA CONCIA € 185.343 CAPANNONE 1210 HA 13/10/21 ROCCASTRADA SASSOFORTINO € 19.076 TERRENO 2.54 13/10/21 ROCCASTRADA SASSOFORTINO € 64.050 VOLUMETRIA 854 VILLA 13/10/21 ROCCASTRADA ROCCATEDERIGHI € 309.150 UNIFAMILIARE 229 19/10/21 CINIGIANO VIA TRIESTE 5 € 31.447 6 VANI 98 19/10/21 CAMPAGNATICO LOC SABATINA € 78.854 RURALE 19/10/21 RIBOLLA VIA LIGURIA 16 € 40.467 5 VANI + GARAGE 114 19/10/21 CIVITELLA PAG.