Montorsaio E Le Sue Famiglie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Elenco Guide Turistiche Abilitate Nell'ambito Territoriale Di Grosseto E Provincia
ELENCO GUIDE TURISTICHE ABILITATE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI GROSSETO E PROVINCIA CITTA' AMBITO COGNOME NOME INDIRIZZO (di Residenza) TELEFONO (Territoriale) Loc. Palazzo Casteani, 18 Agazzi Emilia Casteani Gavorrano 335 6375615 Gr e prov. Agresti Raffaella Via Madd. Ciacci 66 Pitigliano Gr e prov. Aldi Marina P.zza XVIII Novembre,13 Isola del Giglio 328 0244996 Gr e prov. Antonelli Stefania Via Canada,6 Grosseto Gr e prov. Bacci Maria Grazia Via Zuccarelli,132 Pitigliano Gr e prov. Bacchione Clara Cecilia Loc. Sabatina, 31 Campagnatico Gr e prov. Via delle Cortine, 3 Baldanzi Riccarco Roccatederighi Roccastrada 0564 569660 - 340 4920588 Gr e prov. Bardelli Anna Via Gorizia,17 Grosseto 0564 416253 - 349 6116276 Gr-Si e prov. Bartoli Francesca Via F.Fellini,4 Principina Mare Gr e prov. Bartolomei Daniela Via del Tonale, 32 Santa Marinella (RM) 347 9246841 Bassetta Laura Via Giacosa, 6/c Grosseto Gr e prov. Battaglia Federica Via Delle Piagge, 7 Manciano Bernardini Laura Pod.Col di Lana, 39 Alberese Gr e prov. Bertinaria Sabina Via Aurelia, 388/b Santa Marinella (RM) 339 8983086 Biondi Cristina Via Gramsci, 5 Pitigliano Gr e prov. Birardi Francesca Via della Grotta, 17 Monte Argentario Bisazza Natala Domenica Via Volpegnino, 9 Roma 340 5245041 Biserni Fernanda Via F.Turati Castel del Piano Gr e prov. Blanchi Paola Via Catalani, 19 Grosseto 0564 25654 - 339 7252194 Gr-Li-Si e prov. Bocci Adriano Viale Italia, 6 Tolfa (RM) 320 8432256 Bonacorsi M.Cristina Via Canada,124 Grosseto Gr e prov. Via S.Magno,14 Botarelli Maria Luisa Farnese Sorano Gr e prov. -

“Rete Di Telecomunicazioni a Larga Banda Delle Pubbliche Amministrazioni”
SEDE LEGALE GROSSETO –VIA AMBRA, 28/B SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA GROSSETO –VIA LATINA, 5 CENTRALINO E FAX : 0564.484134 - [email protected] PARTITA IVA E CODICE FISCALE 01206200535 CAPITALE SOCIALE VERSATO EURO 110.400,00 - REGISTRO IMPRESE DI GROSSETO N. 104104 Realizzazione del progetto “Rete di telecomunicazioni a Larga Banda delle Pubbliche Amministrazioni”. N° 02213 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Allegato n° ELENCO SEDI DA COLLEGARE ALLA RETE IP 06 IL RESPONSABILE DEL PROGETTO I Progettisti L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC.NETSPRING S.R.L. Hats & Tel di Farina P.I. Renzo DOTT.CLAUDIO BELLUCCI TEA Information Technology Ing. M. Barsacchi Ing. S. Pistolesi GROSSETO,AGOSTO 2008 06 NETSPRING S.r.l. 1° e 2° STRALCIO - ELENCO SEDI PUBBLICHE DA COLLEGARE ALLA RETE A LARGA BANDA NEL COMUNE DI GROSSETO numero in N° ENTE di Competenza Nome della sede Indirizzo GBE FE NOTE cartografia 1 23 Provincia Istituto Professionale Turistico Via Meda 1 Anello 1 2 24 Provincia Liceo Ginnasio Carducci-Ricasoli Via Giolitti 1 3 25 Provincia Ufficio Provincia Via Micca 1 Anello 2 4 27 Provincia Istituto Professionale Piazza De Maria 1 5 31 Provincia Camera Commercio Via Cairoli 1 Anello 3 6 47 Provincia Istituto linguistico Porciatti 1 7 35 Provincia Ufficio Provincia Via Signorini 1 Anello 5 8 40 Provincia Liceo Artistico Statale P.Aldi Pian d'Alma 1 9 49 Provincia APT Ufficio informazioni turistiche (baracchino) Via Ximenes/via Gramsci 1 Anello 6 10 56 Provincia APT Direzione Via Monterosa 1 11 50 Provincia Ufficio Provincia Via Trieste 1 Anello 7 12 64 Provincia Vecchia Sede Questura diventa Ufficio Provincia Piazza Rosselli 1 13 53 Provincia Istituto Tecnico Commerciale Via Sicilia 1 Anello 8 14 55 Provincia Ufficio Provincia Via Scrivia 1 15 62 Provincia Nuova sede Questura via Marocco 1 s 16 41 Provincia Autoparco Via Castiglionese 1 s 17 45 Provincia Polizia Provinciale Via Ambra 1 s 1 22 Comune Scuola Media Alighieri Via Meda 1 Anello 9 2 38 Comune Centro Anziani e sportello anagrafe Via Canova 1 3 26 Comune Scuola elementare IV Cir. -

Prefettura Di Grosseto-Ufficio Elettorale Provinciale ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 Ubicazione Dei Seggi Elettorali Ubicazione Dettagliata E Distanza
Prefettura di Grosseto-Ufficio Elettorale Provinciale ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 Ubicazione dei seggi elettorali ubicazione dettagliata e distanza n Tipo di edificio (scuola, numero di telefono Presidente i d numero (via, dalla casa r Comune ospedale, luogo di detenzione, seggio per contatto del o comunale . sezione locali comunali, ecc…) numero civico, località o n immediato Seggio frazione) in Km. 1 ARCIDOSSO 1 edificio scolastico via Risorgimento m. 100 …omissis… ...omississ… 2 ARCIDOSSO 2 edificio scolastico via Risorgimento m. 100 …omissis… ...omississ… 3 ARCIDOSSO 3 edificio scolastico via Risorgimento m. 100 …omissis… ...omississ… 4 ARCIDOSSO 4 locali comunali via Nuova - Montelaterone Km. 4,5 …omissis… ...omississ… 5 ARCIDOSSO 5 locali comunali via Provinciale - Stribugliano Km. 21 …omissis… ...omississ… 6 CAMPAGNATICO 1 ex scuola media via Roma, 6 - …omissis… ...omississ… 7 CAMPAGNATICO 2 sede A.S.B.U.C. via IV Novembre, 7 - Montorsaio Km. 12 …omissis… ...omississ… 8 CAMPAGNATICO 3 sala comunale Loc.Campino - Marrucheti Km. 11 …omissis… ...omississ… 9 CAMPAGNATICO 4 sala comunale piazza Italia, 5-6 - Arcille Km. 12 …omissis… ...omississ… 10 CAPALBIO 1 scuola via Giovanni Pascoli, 2 m. 200 …omissis… ...omississ… 11 CAPALBIO 2 edifici demaniali via Lecce , 2 - Borgo Carige Km. 6 …omissis… ...omississ… 12 CAPALBIO 3 edifici demaniali via Lecce , 2 - Borgo Carige Km. 6 …omissis… ...omississ… 13 CAPALBIO 4 scuola via Piemonte, 9 Capalbio Scalo Km. 15 …omissis… ...omississ… 14 CASTEL DEL PIANO 1 edificio scolastico piazza Rosa - Guarnieri m. 250 …omissis… ...omississ… 15 CASTEL DEL PIANO 2 edificio scolastico piazza Rosa - Guarnieri m. 250 …omissis… ...omississ… 16 CASTEL DEL PIANO 3 edificio scolastico - seggio speciale piazza Rosa - Guarnieri m. -

Torniella - Farma
Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana (E. Repetti) http://193.205.4.99/repetti/ Torniella - Farma ID: 4148 N. scheda: 51010 Volume: 5; 6S Pagina: 539 - 540; 91 ______________________________________Riferimenti: 32390 Toponimo IGM: Torniella - Podere la Pieve (a O) - Torrente Farma (a N) Comune: ROCCASTRADA Provincia: GR Quadrante IGM: 120-3 Coordinate (long., lat.) Gauss Boaga: 1675316, 4771369 WGS 1984: 11.15432, 43.07633 ______________________________________ UTM (32N): 675380, 4771543 Denominazione: Torniella - Farma Popolo: S. Giovanni Battista a Torniella Piviere: S. Giovanni Battista a Torniella Comunità: Roccastrada Giurisdizione: Roccastrada Diocesi: Grosseto Compartimento: Grosseto Stato: Granducato di Toscana ______________________________________ TORNIELLA in Val di Merse. - Villaggio che fu Castello, con chiesa plebana (S. Gio. Battista) il cui popolo è compreso nella Comunità Giurisdizione e circa 6 miglia toscane a settentrione di Roccastrada, Diocesi e Compartimento di Grosseto. Risiede sulla schiena de'poggi che propagansi verso grecale da quelli di Rocca Tederighi e di Sassofortino per separare il vallone della Farma , fiumana tributaria della Merse dalle vallecole del Gretano e del Lanzo , due torrenti che scendono a vuotarsi presso Paganico nel fiume Ombrone. La pieve di Torniella con la distrutta cappella di S. Sicudera è nominata tra quelle confermate ai vescovi di Grosseto dal pontefice Clemente III mercé di una bolla concistoriale data in Laterano lì 12 aprile del 1188. Fu il Castello di Torniella dominato un tempo da una consorteria di nobili detti i signori di Torniella e di Sticciano , ai quali apparteneva quel Ranieri che nel 1233, per atto pubblico del 17 maggio rogato nella chiesa di Monticiano, unitamente ad un suo figlio, Alberto, allivellò in perpetuo al Comune e uomini di Torniella tutti i beni di suolo che ivi possedeva a condizioni, le quali furono anche ratificate da donna Diana moglie di detto signore. -

Guarda Il PDF: Orari, Fermate E Percorso Linea
Orari e mappe della linea bus 20A 20A Arcidosso-Santa Fiora-Castell'Azzara Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 20A (Arcidosso-Santa Fiora-Castell'Azzara) ha 12 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Amiata Stazione: 13:25 (2) Arcidosso Autostazione: 06:10 - 15:30 (3) Arcidosso Autostazione: 05:20 - 19:15 (4) Castel Del Piano Centrale: 07:10 - 18:00 (5) Castell'Azzara Centro: 08:05 - 19:29 (6) Largo Verdi: 05:46 - 06:40 (7) Piancastagnaio Centro: 06:10 (8) Santa Fiora Centrale: 14:30 - 15:50 (9) Seggiano C.Le: 05:50 - 15:05 (10) Seggiano Comune: 19:00 (11) Selvena Centro: 14:30 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 20A più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 20A Direzione: Amiata Stazione Orari della linea bus 20A 34 fermate Orari di partenza verso Amiata Stazione: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 13:25 martedì 13:25 Arcidosso Autostazione mercoledì 13:25 Arcidosso Centrale giovedì 13:25 Arcidosso Cimitero venerdì 13:25 Arcidosso Ponti sabato 13:25 Montoto domenica Non in servizio Arcidosso S.Lorenzo Castel Del Piano Campeggio Informazioni sulla linea bus 20A Castel Del Piano Hotel Impero Direzione: Amiata Stazione Fermate: 34 Durata del tragitto: 47 min Castel Del Piano Vittorio Veneto La linea in sintesi: Arcidosso Autostazione, Via Dalmazia, Castel del Piano Arcidosso Centrale, Arcidosso Cimitero, Arcidosso Ponti, Montoto, Arcidosso S.Lorenzo, Castel Del Castel Del Piano Centrale Piano Campeggio, Castel Del Piano Hotel Impero, Castel Del Piano Vittorio Veneto, Castel Del Piano Castel Del Piano Ospedale Centrale, Castel Del Piano Ospedale, Castel Del Piano Santucci, Castel Del Piano Santucci, Castel Del Piano Castel Del Piano Santucci Cimitero, Castel Del Piano Bivio Casella, Leccio, Pescina Bivio Sud, Pian Di Ballo, Tepolini, Podere La Castel Del Piano Santucci Lama, Bv. -

Schede Dei Paesaggi E Individuazione Degli Obiettivi Di Qualità
ALLEGATO A - elaborato 4 p i t Piano di indirizzo territoriale della Toscana Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità Sommario AMBITO 1: LUNIGIANA ........................................................................................................................3 AMBITO 2: MASSA CARRARA ...........................................................................................................15 AMBITO 3: GARFAGNANA .................................................................................................................28 AMBITO 4: MEDIA VALLE DEL SERCHIO ........................................................................................40 AMBITO 5: MONTAGNA PISTOIESE..................................................................................................51 AMBITO 6: PISTOIA .............................................................................................................................61 AMBITO 7: PRATO E VAL DI BISENZIO............................................................................................70 AMBITO 8: ROMAGNA TOSCANA .....................................................................................................81 AMBITO 9: MUGELLO .........................................................................................................................91 AMBITO10: CASENTINO ...................................................................................................................107 AMBITO 11: VALTIBERINA TOSCANA ...........................................................................................119 -

Piano Strutturale Comune Di Scansano
( ( ( ( ( ( ( ( O ( N F 2 ( ( A ( O ( I ( 5 ( 184.8 ( S L ( ( ( 252.1 ( 563.5 S 0 ( G ( 442.3 ( O 259.1 296.1 ( U 6 ( 0 ( ( ( S ( Serbatoio 199.1 . IB 0 ( D 278.9 C ( R i 142.8 171.5 . ( ( ( E ( T ( ( d 161.4 L 246.7 ( 540.5 261.7 ( S 229.0 ( CASINONO ( P. 516.( 3 590.4 ( ( 482.3 C ( ( A ( ( 424.8 ( ( N O ( 184.7 303.6 ( A ( D ( P 207.8 P 456.5 I ( . M ( P. POGGIO ( A 415.8 ( .V A . 573.9 ( 162.9 I ( S ( C ( P B ( A . CASETTA ( 381.3 D S ( ABECHI C D ( ( 253.2 ( E ( ( C 169.2 I E 218.7 256.4 336.6 ( ( VEDUTA o LA ( N L L P. BANDITA ( E t 5( 63.6 5 L ( LOCCA L ( L DELLA ( t 5 A ( L A ( ( ( 476.0 0 ( O o C ( I 209.8 ( 204.0 ( ( A ( ( DEI BOVI d D ( 233.6 S ( 441.6 610.7 T e ( ( ( ( A ( 3 G ( u ( ( ( N ( ( 201.8 5 L q O ( tav. 4a.2 E ( 236.3 L ( c 0 O ( ( D 270.3 215.8 240.2 ( 446.1 A ( ( ( ( 169.9 234.9 E 276.0 ( ( F Piano Strutturale ( Variante contestuale al Piano Operativo T R ELLI ( POGGIAR ( 464.2 452.5 191.2 ( O ( C N ( ( N ( 163.8 B A C C I N E L L O A 207.6 E ( Z 234.0 V R P. MOLINO ( I 228.0 ( N 202.5 374.3 ( S.C. -

La Maremma Nei Libri Della BIT
La Maremma nei libri della BIT 2013 Le bibliografie della Biblioteca dell’identità toscana – La Maremma 1 Indice La Maremma Arti, Architettura e urbanistica p. 3 Storia e archeologia 6 Tradizioni 12 Geografia e guide 15 Economia, Lavoro e Scienze Sociali 18 Cucina 24 Religione 25 Letteratura 25 Scienze e Tecnica 27 Bibliografie, giornali e musei 29 Maremma Arti, Architettura e urbanistica Acque di Maremma: pittura e scultura / artisti: Piero Ardenghi ... [et al.] ; contributo critico: Mauro Papa. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2011. - 35 p. : ill. ; 21 cm Architettura e bonifiche : la Maremma settentrionale : territorio, città, architettura : 1738-1860 / Maria Luisa Ugolotti ; saggio introduttivo di Sandro Benedetti. - Roma : Dedalo, c1999. - 205 p. : ill. ; 24 cm Arte antica in Maremma : dal 13. al 16. secolo / a cura di Olivia Bruschettini. - Firenze : Effigi, 2009- . - v. : ill. ; 32 cm Il balestro a Massa di Maremma : cronaca e storia della rinascita di un antico gioco d'armi e dei suoi fasti / Società dei terzieri massetani, Centro studi storici Agapito Gabrielli. - Massa Marittima : Publidea, 1994. - 200 p. : ill. ; 24 cm Castelli e potere nella Maremma grossetana nell'alto Medioevo / Gaetano Prisco ; prefazione di Riccardo Francovich. - Grosseto : Innocenti, stampa 1998. - 320 p. ; 24 cm Chiese medievali della Maremma grossetana : architettura religiosa tra la Val di Farma e i Monti dell'Uccellina / Giulia Marrucchi. - Empoli : Editori dell'Acero, c1998. - 207 p. : ill. ; 30 cm Claudio Amerighi : oro e veleno / Mario Filabozzi. - Grosseto : Innocenti, stampa 2006. - 121 p. : ill. ; 29 cm Collezione Gianfranco Luzzetti : primo nucleo del lascito di opere destinate al Museo archeologico e d'arte della Maremma, Grosseto : catalogo / a cura di Sandro Bellesi ; contributi di Sandro Bellesi .. -

Roberto Bucci, Architetto, Nato a Grosseto (Gr) Il 16/04/1963 Residente in Grosseto 58100 Via Pergolesi 11- Tel 0564-418411- 348 5817153 Mail [email protected]
Roberto Bucci, Architetto, nato a Grosseto (Gr) il 16/04/1963 Residente in Grosseto 58100 via Pergolesi 11- tel 0564-418411- 348 5817153 mail [email protected] Curriculum-Vitae TITOLI DI STUDIO a) Laurea in Architettura conseguita nell’anno accademico 1991/92 presso l’Università degli studi di Roma con votazione di 105/110 b) Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1994, iscrizione all’Ordine degli Architetti di Grosseto al n° 267; c) Corso di 120 ore in attuazione della direttiva 92/57/CEE ai sensi dell’Art. 10 comma 2 del D.L. 494/96 frequentato nel 1998. Titoli di servizio: d) 1992-95; insegnamento di materie tecniche presso l’Istituto Tecnico per Geometri Andrea da Grosseto in Grosseto e) 1993-95; insegnamento di materie tecniche presso l’Istituto Tecnico per Geometri A. Manzoni in Siena; i) Servizio di leva assolto nell’anno 1990/91 come servizio civile svolto presso la Caritas di Grosseto l) 1994-97 Esercizio della libera professione con studio di progettazione in Campagnatico p.za IV Novembre i) Contratto di consulenza con EDS Electronic Data System Italia dal marzo 2005 al giugno 2007. m) Dipendente del Comune di Scansano part-time in qualità di Istruttore Tecnico, cat. D 1 presso l’ufficio Servizi Tecnologici – da agosto 1996 a giugno 1998 n) Dipendente del Comune di Scansano in qualità di Istruttore Direttivo, cat. D 3 Responsabile dell'Ufficio Sevizio 5 –Servizi Tecnologici - dal giugno 1998 ad oggi o) Contratto di Collaborazione con il Comune di Montieri dal novembre 2001 al maggio 2005 in qualità di istruttore direttivo e Responsabile del Procedimento per l’esecuzione di OO.PP. -

Aldobrandeschi.Pdf
Gli Aldobrandeschi. La grande famiglia feudale della Maremma toscana a cura di Mario Ascheri Lucio Niccolai Redazione: Consultacultura Viale Marconi 93, Santa Fiora e-mail: [email protected] Trascrizione e battitura testi: Maria Angela Iannelli Edizioni: C&P Adver effigi Via Roma, 14 - Arcidosso Stampa: Tipografia Ceccarelli, Gennaio 2002 Atti del convegno “Gli Aldobrandeschi. La grande famiglia feudale della Maremma toscana”, promosso da The international of Lions Club Distretto 108 “La Toscana” e realizzato a Santa Fiora il 26 maggio 2001, Organizzato dai Clubs Lions di: Alta Maremma, Amiata, Chianti, Chiusi, Grosseto Aldobrandeschi, Grosseto Host Orbello-I Presidi, Siena. In collaborazione e con il patrocinio di: Amministrazione provinciale di Grosseto, Comunità Montana Zona I1, Area grossetana, Azienda di promozione turistica (APT) Amiata, Comuni di Santa Fiora e di Arcidosso, Associazione Pro Loco di Santa Fiora, Associazione “Consultacultura” di Santa Fiora. Pubblicato dai Clubs Lions di: - Alta Maremma - Amiata - Chianti - Chiusi - Grosseto Aldobrandeschi - Grosseto Host - Orbetello I Presidi - Siena Collaborazione e patrocinio: Amministrazione Provinciale Grosseto Comunità Montana Amiata Ovest Azienda Promozione Turistica Amiata Comune di Santa Fiora Comune di Arcidosso Associazione Pro Loco di Santa Fiora Associazione Consultacultura di Santa Fiora In collaborazione con la Cassa di Risparmio di Firenze Realizzato grazie al contributo dell’azienda Tosti di Castel del Piano Immagini tratte da: G. CIACCI, Gli Aldobrandeschi nella storia e nella Divina Commedia, Roma 1934 e I. CORRIDORI, Gli Aldobrandeschi nella storia maremmana, Grosseto 1977. Genius Loci Storia e cultura locale Indice Rodolfo Fazzi, Presentazione p. 7 Saluti e interventi autorità p. 9 Lorenzo Maccari, L’importanza di questo convegno p. -

Viva Xpress Logistics (Uk)
VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) Tel : +44 1753 210 700 World Xpress Centre, Galleymead Road Fax : +44 1753 210 709 SL3 0EN Colnbrook, Berkshire E-mail : [email protected] UNITED KINGDOM Web : www.vxlnet.co.uk Selection ZONE FULL REPORT Filter : Sort : Group : Code Zone Description ZIP CODES From To Agent IT ITAOD04 IT- 3 Days (Ex LHR) Cities & Suburbs CIVITELLA CESI 01010 - 01010 CELLERE 01010 - 01010 AZIENDA ARCIONE 01010 - 01010 ARLENA DI CASTRO 01010 - 01010 FARNESE 01010 - 01010 LATERA 01010 - 01010 MONTEROMANO 01010 - 01010 ONANO 01010 - 01010 PESCIA ROMANA 01010 - 01010 PIANSANO 01010 - 01010 TESSENNANO 01010 - 01010 VEIANO 01010 - 01010 VILLA S GIOVANNI IN TUSC 01010 - 01010 MUSIGNANO 01011 - 01011 CELLENO 01020 - 01020 CHIA 01020 - 01020 CASTEL CELLESI 01020 - 01020 CASENUOVE 01020 - 01020 GRAFFIGNANO 01020 - 01020 LUBRIANO 01020 - 01020 MUGNANO 01020 - 01020 PROCENO 01020 - 01020 ROCCALVECCE 01020 - 01020 SAN MICHELE IN TEVERINA 01020 - 01020 SERMUGNANO 01020 - 01020 SIPICCIANO 01020 - 01020 TORRE ALFINA 01020 - 01020 TREVIGNANO 01020 - 01020 TREVINANO 01020 - 01020 VETRIOLO 01020 - 01020 ACQUAPENDENTE 01021 - 01021 CIVITA BAGNOREGIO 01022 - 01022 BAGNOREGIO 01022 - 01022 CASTIGLIONE IN TEVERINA 01024 - 01024 GROTTE SANTO STEFANO 01026 - 01026 MAGUGNANO 01026 - 01026 CASTEL S ELIA 01030 - 01030 CALCATA 01030 - 01030 BASSANO ROMANO 01030 - 01030 FALERIA 01030 - 01030 FABBRICA DI ROMA 01034 - 01034 COLLEMORESCO 02010 - 02010 COLLI SUL VELINO 02010 - 02010 CITTAREALE 02010 - 02010 CASTEL S ANGELO 02010 - 02010 CASTEL SANT'ANGELO 02010 -
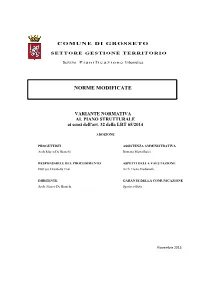
Norme Modificate
COMUNE DI GROSSETO SETTORE GESTIONE TERRITORIO Servizio Pianificazione Urbanistica NORME MODIFICATE VARIANTE NORMATIVA AL PIANO STRUTTURALE ai sensi dell'art. 32 della LRT 65/2014 ADOZIONE PROGETTISTI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA Arch.Marco De Bianchi Dott.ssa Marta Baici RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ASPETTI DELLA VALUTAZIONE Dott.ssa Elisabetta Frati Arch. Elena Fredianelli DIRIGENTE GARANTE DELLA COMUNICAZIONE Arch. Marco De Bianchi Spartaco Betti Novembre 2015 Indice TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ......................................................................................................... 5 ART. 1 - FINALITÀ, CONTENUTI E AMBITO DI APPLICAZIONE ................................................................................ 5 ART. 2 - QUADRO CONOSCITIVO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE ............... 6 ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE ........................................................................... 7 ART. 4 - EFFICACIA DEL PIANO STRUTTURALE E NORME DI SALVAGUARDIA ..................................................... 11 ART. 5 - ELABORATI DEL PIANO STRUTTURALE ................................................................................................. 18 TITOLO II – CONDIZIONI E LIMITAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE UTILIZZAZIONI DERIVANTI DALLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA ED IDRAULICA E DALLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE ....................................................... 30 ART. 6 - DISCIPLINA DEGLI ASSETTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI