Felice Senatore
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dottorato in Scienze Storiche, Archeologiche E Storico-Artistiche
DOTTORATO IN SCIENZE STORICHE, ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE Coordinatore prof. Francesco Caglioti XXX ciclo Dottorando: Luigi Oscurato Tutor: prof. Alessandro Naso Tesi di dottorato: Il repertorio formale del bucchero etrusco nella Campania settentrionale (VII – V secolo a.C.) 2018 Il repertorio formale del bucchero etrusco nella Campania settentrionale (VII – V secolo a.C.) Sommario Introduzione ........................................................................................................................................... 6 Storia degli studi sul bucchero rinvenuto in Campania ...................................................................... 8 1. I siti e i contesti ............................................................................................................................ 16 1.1 Capua .................................................................................................................................... 18 1.2 Calatia ................................................................................................................................... 28 1.3 Cales ...................................................................................................................................... 31 1.4 Cuma ..................................................................................................................................... 38 1.5 Il kolpos kymaios ................................................................................................................... 49 2. Catalogo -

Volume 16 Winter 2014
Volume 16 Winter 2014 Tomb 6423 At right, the Below is the A Digger’s View: lastra sealing chamber as The Tomb of the Hanging the chamber found at the The perspective of a field Aryballos, Tarquinia shown in situ. moment of archaeologist by Alessandro Mandolesi Above it is the opening, by Maria Rosa Lucidi another lastra on the back The University of Turin and the possibly reut- wall a little The discovery of the tomb of the Superintendency for the Archaeological ilzed spolia aryballos still “hanging aryballos" has aroused great Heritage of Southern Etruria have been interest among the public in both Italy taken from hangs on its investigating the Tumulus of the Queen and internationally. The integrity of the original nail. and the necropolis surrounding it, the the tumulus unviolated tomb is definitely one of the Doganaccia, since 2008. The excava- of the queen, (photographs reasons for the attention it has received. tions have brought forth many important which stands by Massimo The uniqueness is even more pro- and unexpected results, thanks to subse- nearby. Legni). nounced when one considers that since quent research, and the infor- the second half of the nine- mation relating to the differ- teenth century the English ent phases of its use has made traveler George Dennis it possible to clarify many blamed the inability to recov- obscure points about the great er the contexts from intact era of the monumental tumuli chamber tombs in Etruscan at Tarquinia. Tarquinia on repeated looting Archaeologists working since ancient times. The -

Dionysiac Imagery in Archaic Etruria Dimitris Paleothodoros University of Thessaly
Etruscan Studies Journal of the Etruscan Foundation Volume 10 Article 15 2007 Dionysiac Imagery in Archaic Etruria Dimitris Paleothodoros University of Thessaly Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies Recommended Citation Paleothodoros, Dimitris (2007) "Dionysiac Imagery in Archaic Etruria," Etruscan Studies: Vol. 10 , Article 15. Available at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies/vol10/iss1/15 This Article is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Etruscan Studies by an authorized editor of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. Dionysiac Imagery in Archaic Etruria by Dimitris Paleothodoros he emergence of Etruscan Dionysiac iconography was made possibLe by the adop - tion and imitation of prototypes found on imported Attic vases 1. The first TDionysiac images produced by Etruscan craftsmen date to 550 BC and are found on bLacK-figured vases by the Paris Painter, and the painters of the Ivy-Leaf and the La ToLfa Groups. Between the mid 6th and mid 5th centuries BC, Etruscan artists decorate aLmost 170 bLacK-figured and added-red vases with Dionysiac images, 13% of the totaL pro - duction of figured vases. 2 This group of images, suppLemented by other pieces of evidence, such as mirror engravings and bronze statuettes, forms the basis of the present study, which is the preLiminary report of a thorough investigation of Dionysus in archaic Etruria. In the recent past, schoLars have deveLoped the concept of “Dionysism without Dionysus,” to account for the paradox of the scarcity of Dionysus’ images in archaic Etruria, in contrast to the great popuLarity of images of his foLLowers, i.e. -
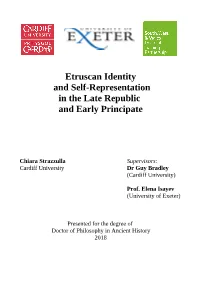
Etruscan Identity and Self-Representation in the Late Republic and Early Principate
Etruscan Identity and Self-Representation in the Late Republic and Early Principate Chiara Strazzulla Supervisors: Cardiff University Dr Guy Bradley (Cardiff University) Prof. Elena Isayev (University of Exeter) Presented for the degree of Doctor of Philosophy in Ancient History 2018 Acknowledgements Research might often be portrayed as a solo enterprise, but no work of research is ever truly done alone. This work would most certainly not have been possible without the help and support of many others beside me, who gave their own precious insights, directed my investigation to unexpected corners of the subject topic, and generously gave assistance when assistance was needed. My heartfelt thanks go therefore to: My supervisors, Dr Guy Bradley and Prof. Elena Isayev, who have been present at every stage, providing fundamental clarifications, encouraging me to push my limits and find my strengths, helping me shape what was a disconnected bunch of ideas about Romans and Etruscans into something concrete. Their dedication to this work cannot be understated and without it none of it would have been possible. All at AHRC and the South, West and Wales Doctoral Training Partnership, for generously funding my PhD and providing invaluable occasions for personal and professional development, debate, and sharing. The discussions had at cohort days organised by the DTP have helped guide the direction my research was taking, provided me with additional tools and given me interdisciplinary insights. My thanks in particular to Chantelle Payne and Rose Jones, for their tireless organisational work; and to all the fellow DTP students with whom I exchanged opinions and ideas, most importantly Beatrice Hitchman, Sophie Payne, Maria Tomlinson, Anna Field, James Thomas Lloyd, and Jo Bryant. -

The Tabula Cortonensis and Land Transactions
THE TABULA CORTONENSIS AND LAND TRANSACTIONS Recently R. A. Wallace has dedicated a chapter of his book ‘Zikh Rasna. A Manual of Etruscan Language and Inscriptions' (2008) to the inscription of the bronze Tabula Cortonensis\ The Tablet of Cortona, hereafter TCo, was handed in by a carpenter to the Carabinieri at Camucia (Cortona) in 1992. The editio princeps was published by L. Agostiniani and F. Nicosia in 2000. The text is extremely important since it is, after the Liber linteus Zagrabiensis and the Tabula Capuana, the third longest extant Etruscan text (206 words; 32 lines on side A and 8 lines on side B). It is, however, difficult to interpret and translate for lexical, morphological, grammatical, and syntactical reasons. Wallace’s tentative translation of the text is based on interpretations and translations advanced by Agostiniani and Nicosia (2000), H. Rix (2000, 2002), G. Μ. Facchetti (2000, 2002b), A. Maggiani (2001, 2002b), V. Scarano Ussani and Μ. Torelli (2003), K. Wylin (2002a, 2006b) and I.-J. Adiego (2005). The publications of C. De Simone (1998-2007), P. Amann (2005), Wylin (2005) and Torelli (2005) were not used by Wallace. It appears that there is no consensus on the meaning(s) of about half of the sixty different non- onomastic lexical units, many of which are or look like hapax legomena. This article aims to detect their semantic values from the textual context and with the use of the combinatory method, that is, by comparing words in the TCo text with those in the corpus of ca 11,000 Etruscan inscriptions. Some words and syntagmata will also be studied from a chrono-typological, interlinguistic, etymological, and contemporary, bicultural perspective (e.g. -

Ciencia Y El Arte De Los Etruscos Y La Roma Antigua
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 53 (31/12/2013): 363–412. LOS ARTRÓPODOS EN LA MITOLOGÍA, LAS CREENCIAS, LA CIENCIA Y EL ARTE DE LOS ETRUSCOS Y LA ROMA ANTIGUA Víctor J. Monserrat Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad Complutense, 28040 Madrid (España). – [email protected] Resumen: Con una breve introducción sobre los primeros asentamientos humanos en la Península Itálica durante el Neolítico, y tras las influencias de los fenicios y los griegos, nos adentramos en la enigmática civilización etrusca, que acabará por generar la fascinante civilización romana. Mucho menos documentada que la de sus conquistadores romanos, los etruscos desarrollaron una civilización hedonista y refinada, y trataremos de ahondar en los artrópodos y sus derivados que formaron parte de sus creencias y costumbres, desde los escarabeos que usaban como sellos y amuletos, al uso de la miel en multitud de sus prácticas, rituales y hábitos. Tras ello damos paso al Imperio Romano, que desde sus rurales inicios llegó a ser el primer imperio de la historia con categoría de estado. Transitaremos por su dilatada historia y su estructura militar, política, social, económica y religiosa, y nos iremos acercando a su zoológico. Comentarenos primero, de forma general, algunos datos sobre sus animales, y posteriormente sus artrópodos en particular, siendo los artrópodos unos animales que formaron parte de las creencias de esta civilización, con una enorme intencionalidad práctica y con mucho menos importancia simbólica, mágica y ritual que en otras civilizaciones mediterráneas previas, como la egipcia, la cretense o la griega. Aun así hablaremos de los artrópodos que hallamos en su mitología y sus deidades, así como los que hallamos entre sus creencias, costumbres, rituales, u ofrendas, en las que los artrópodos participaron y que dejaron constancia en multitud de ejemplos de su magnífica arquitectura, musivaria, escultura, arte mobiliario, pintura, orfebrería o numismática. -

More on Dioscorides' Etruscan Herbs the Capitoline Museum and The
VOLUME: 6SUMMER, 2006 Moreon The Capitoline Museumand Dioscorides’ the Castellani Collection Etruscan by AntonellaMagagnini CuratoreArcheologo,Musei Capitolini Herbs OnDecember 23, 2005, theCapitoline Museums,after along effort coordinated by by JohnScarborough AnnaMuraSommella, Director of theMusei University of Wisconsin Capitolini,andagreat financialcommitment, wereenriched by anew wing,focused on a Inhis “AnEtruscanHerbal?” ( Etruscan largelight-filled, glassed-in hall in the spaces News,5[Winter, 2006]),KyleP. Johnson previously occupied by theRomanGardenof makes someinteresting points regarding the thePalazzodeiConservatori. Theoriginal manuscript traditions that include alternative bronzeequestrian statueof Marcus Aurelius names for theplants andherbs in Dioscorides’ has finally foundits worthy homein this piaz- Materiamedica. 1 It was beyond the scopeof za-like space, along with thelargebronzes Johnson’s briefintroductory note, however, donated by Sixtus IVto theRomanpeoplein andhence it is thegoalof this article, to sug- Pimpernel,from the ViennaDioscurides 1472. From this hall onecanmarvelat the gest how and why these synonyms,not (WikimediaCommons) enormous,imposing remains of thefounda- included by Dioscorides in his original work, 2 5 tions of theTempleof Jupiter Capitoline enter themanuscript history,andmoreimpor- inal work. revealed by recent archaeologicalexcava- tantly, why thesenames might indicateapar- Inestablishing his Greek text of the tions. ticularly Etruscanherbalism. Materiamedica,Max Wellmann pulled most In thegalleries -

Culture a Contatto in Campania. Processi Di Trasformazione Tra V E IV Secolo A.C.», in Roma 2008 – International Congress of Classical Archeology
Culture a Contatto in Campania proCessi di trasformazione tra V e iV seColo a.C. a cura di maria Bonghi Jovino ACME - Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano LXIV - II - Maggio-Agosto 2011 http://www.ledonline.it/acme r iproduzione cartacea della sezione a cura di maria Bonghi Jovino «Culture a contatto in Campania. processi di trasformazione tra V e iV secolo a.C.», in Roma 2008 – International Congress of Classical Archeology. Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean, ministero per i Beni e le attività Culturali, «Bollet tino di archeologia on line» 1 (2010), volume speciale, http:// www.archeologia. beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html. ACME - Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano LXIV - II - Maggio-Agosto 2011 http://www.ledonline.it/acme i ntroduzione Com’è largamente noto, le dinamiche di trasformazione sono di ventate oggetto di vari studi recenti che hanno evitato la tentazione di parallelizzare avvenimenti citati nelle fonti letterarie con i dati della te stimonianza archeologica e di interpretare gli aspetti culturali in chiave etnica. È il caso istruttivo della cosiddetta “seconda colonizzazione etru sca” della Campania, che non fu un fenomeno di stampo invasionistico bensì un processo sociale, economico e politico molto più complesso con la partecipazione, a lato degli etruschi, di diversi gruppi etnici. in parti colare all’interno del processo Capua, sulla base dei rinvenimenti recenti, appare una città etrusca murata sin dal Vi secolo a.C. in un’ottica che punta sulla convergenza dei dati e dei fenomeni, ormai sufficientemente acquisita o prevalente, sul piano dell’approccio metodologico, ci siamo posti l’obiettivo di indagare quali evidenze ar cheologiche possano fornire oggi nuove testimonianze in merito alle di namiche di trasformazione rispetto a quanto ci è noto. -

Gli Etruschi Un Popolo Ancora Avvolto Nel Mistero
Gli Etruschi un popolo ancora avvolto nel mistero CRONOLOGIA 1200 AC - Prime tracce della civiltà etrusca. 700 AC - Gli etruschi derivano il loro alfabeto dai Greci (primi in Italia). 616-579 AC - Roma sotto il primo leggendario re etrusco, Lucius Tarquinius Priscus 550 AC - Picco del potere etrusco. Alleati dei Cartaginesi, gli etruschi commerciano nel Mediterraneo. 535 AC - Ad Alalia in Corsica la flotta di Cartaginesi ed Etruschi sconfigge la flotta greca. 510 AC – L’ultimo re Etrusco, Lucius Tarquinius Superbus, viene cacciato da Roma. 474 AC – A Cuma la flotta greca sconfigge gli Etruschi. 396 AC – I Romani distruggono la città Etrusca di Veio. Segue un lungo periodo durante il quale Roma annette le città Etrusche. All’inizio del primo secolo AC tutta l’Etruria cade sotto il potere di Roma. IPOTESI DELLE ORIGINI ● Secondo Erodoto (484-430 a.C.) : Provenienza dalla Lidia guidati dal re Tirreno e costretti dalla carestia ● Secondo Dionigi d’Alicarnasso (60-7 a.C.) : Origine autoctnona di un popolo che si dava il nome di Rasenna ● Secondo la moderna Storiografia : Incontro tra popolazioni autoctone (Civiltà Villanoviana) con genti provenienti da altre aree Civiltà Villanoviana (IX – VIII sec a.C.) Continuità tra civiltà villanoviana (sviluppatasi nei pressi di Bologna) e etrusca. Abitudine a conservare i corpi dei defunti in urne cinerarie a forma di capanne (forse simili a quelle delle loro abitazioni) LA SCRITTURA E LA LINGUA ● L'indecifrabilità della lingua ha contribuito a creare un alone di fascino e mistero intorno alla civiltà -

16 Gerión 24-2006 Filmar
16. Gerión 24-1 21/6/06 10:17 Página 287 Communitary and Individualistic Gods in German and Roman Religion Adolfo ZAVARONI Reggio Emilia, Italy RESUMEN Según dos episodios contados por Saxo Grammaticus, Othinus fué reemplazado temporalmente por Mythothyn y, en una circunstancia diferente, por Ollerus. El análisis textual enseña que Mythothyn aspiró a la posesión y a la gloria personal, prohibiendo las ofertas dedicadas en común a los dioses. Ollerus-Ullr “Gloria, Esplendor” evidencia una semejante inclinación en el nombre mismo. Puesto que Iovis hijo de Fortuna fué venerado por los patricios romanos, mientras la tríada Ceres-Liber-Libe- ra, el antiguo Mercurio y Saturno fueron adorados por los plebeyos como divinidades comunitarias, podemos deducir que los dioses de la luz diurna fueron creídos partidarios de poder individual desde muchos siglos. Palabras clave: epulum Iovis, Fortuna, Gullveig, Iovis, Latinus, Mercurius, Mithothyn, Ollerus-Ullr, Odin-Othinus-ÓDinn, Summanus, Vulcanus. ABSTRACT According to two episodes told by Saxo Grammaticus, Othinus was temporarily replaced by Mythothyn and, in a different circumstance, by Ollerus. Analysis shows that the former aspired to per- sonal ownership and glorification, prohibiting votes dedicated to all gods, while the latter shows such an inclination in the name itself (Ullr “Glory”). Analogously Iovis son of Fortuna was the god worshipped by the Roman patricians, while the Ceres- Liber-Libera triad, the early Mercury and Saturn were worshipped by the plebeians as communitary divinities. We may infer that the gods of daily light had been considered promoters of individual power since many centuries. Key Words: epulum Iovis, Fortuna, Gullveig, Iovis, Latinus, Mercurius, Mithothyn, Ollerus-Ullr, Odin-Othinus-ÓDinn, Summanus, Vulcanus. -

Divining the Etruscan World Jean Macintosh Turfa Frontmatter More Information
Cambridge University Press 978-1-107-00907-3 — Divining the Etruscan World Jean MacIntosh Turfa Frontmatter More Information Divining the Etruscan World Th e Etruscan Brontoscopic Calendar is a rare document of omens foretold by thunder. It long lay hidden, embedded in a Greek translation within a Byzantine treatise from the age of Justinian. Th e fi rst complete English translation of the Brontoscopic Calendar , this book provides an understanding of Etruscan Iron Age society as revealed through the ancient text, especially the Etruscans’ concerns regarding the environment, food, health, and disease. Jean MacIntosh Turfa also analyzes the ancient Near Eastern sources of the calendar and the subjects of its predictions, thereby creating a picture of the complexity of Etruscan society reaching back to before the advent of writing and the recording of the calendar. Jean MacIntosh Turfa is Rodney Young Fellow in the Mediterranean Section of the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology and Adjunct Professor of Classics and Ancient Studies at St. Joseph’s University, Philadelphia. She has published catalogs of collections of Etruscan antiquities and articles on Etruscan art, seafaring, votive off erings, and divination and medicine. © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-1-107-00907-3 — Divining the Etruscan World Jean MacIntosh Turfa Frontmatter More Information apasi atialc alcsentresc, cen zic zichu turce © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org -

Margaret Mary Th6r£Se Watmough University College London Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for The
STUDIES IN THE ETRUSCAN LOANWORDS IN LATIN Margaret Mary Th6r£se Watmough University College London Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 1 ( LONI/INo) ProQuest Number: 10609130 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 10609130 Published by ProQuest LLC(2017). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States C ode Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106- 1346 ABSTRACT In the political and cultural relations between archaic Rome and Etruria the Etruscans were not the speakers of a 'dominant language'. Since Rome was not under Etruscan domination nor was there any prestige associated with the Etruscan language, the conditions under which large scale lexical borrowing takes place were absent. A recent survey of the whole field is reviewed and its results are found to be uncertain or ill-supported; in it the constraints of space preclude the detailed treatment of individual words which is necessary if the nature of the influence of Etruscan on the Latin lexicon is to be fully understood. This thesis deals with some specific problems in Etrusco- Latin interaction and in the Etruscan loanwords in Latin; a small number of words is treated in detail.