Rivista Di Epigrafia Etrusca
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dottorato in Scienze Storiche, Archeologiche E Storico-Artistiche
DOTTORATO IN SCIENZE STORICHE, ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE Coordinatore prof. Francesco Caglioti XXX ciclo Dottorando: Luigi Oscurato Tutor: prof. Alessandro Naso Tesi di dottorato: Il repertorio formale del bucchero etrusco nella Campania settentrionale (VII – V secolo a.C.) 2018 Il repertorio formale del bucchero etrusco nella Campania settentrionale (VII – V secolo a.C.) Sommario Introduzione ........................................................................................................................................... 6 Storia degli studi sul bucchero rinvenuto in Campania ...................................................................... 8 1. I siti e i contesti ............................................................................................................................ 16 1.1 Capua .................................................................................................................................... 18 1.2 Calatia ................................................................................................................................... 28 1.3 Cales ...................................................................................................................................... 31 1.4 Cuma ..................................................................................................................................... 38 1.5 Il kolpos kymaios ................................................................................................................... 49 2. Catalogo -

Etruscan Jewelry and Identity
Chapter 19 Etruscan Jewelry and Identity Alexis Q. Castor 1. Introduction When Etruscan jewelry is found, it is already displaced from its intended purpose. In a tomb, the typical archaeological context that yields gold, silver, ivory, or amber, the ornaments are arranged in a deliberate deposit intended for eternity. They represent neither daily nor special occasion costume, but rather are pieces selected and placed in ways that those who prepared the body, likely women, believed was significant for personal or ritual reasons. Indeed, there is no guarantee that the jewelry found on a body ever belonged to the dead. For an element of dress that the living regularly adapted to convey different looks, such permanence is entirely artificial. Today, museums house jewelry in special cases within galleries, further sep- arating the material from its original display on the body. Simply moving beyond these simu- lations requires no little effort of imagination on the part of researchers who seek to understand how Etruscans used these most personal artifacts. The approach adopted in this chapter draws on anthropological methods, especially those studies that highlight the changing self‐identity and public presentation necessary at different stages of life. As demonstrated by contemporary examples, young adults can pierce various body parts, couples exchange rings at weddings, politicians adorn their lapels with flags, and military veterans pin on medals for a parade. The wearer can add or remove all of these acces- sories depending on how he or she moves through different political, personal, economic, social, or religious settings. Cultural anthropologists who apply this theoretical framework have access to many details of life‐stage and object‐use that are lost to us. -

Volume 16 Winter 2014
Volume 16 Winter 2014 Tomb 6423 At right, the Below is the A Digger’s View: lastra sealing chamber as The Tomb of the Hanging the chamber found at the The perspective of a field Aryballos, Tarquinia shown in situ. moment of archaeologist by Alessandro Mandolesi Above it is the opening, by Maria Rosa Lucidi another lastra on the back The University of Turin and the possibly reut- wall a little The discovery of the tomb of the Superintendency for the Archaeological ilzed spolia aryballos still “hanging aryballos" has aroused great Heritage of Southern Etruria have been interest among the public in both Italy taken from hangs on its investigating the Tumulus of the Queen and internationally. The integrity of the original nail. and the necropolis surrounding it, the the tumulus unviolated tomb is definitely one of the Doganaccia, since 2008. The excava- of the queen, (photographs reasons for the attention it has received. tions have brought forth many important which stands by Massimo The uniqueness is even more pro- and unexpected results, thanks to subse- nearby. Legni). nounced when one considers that since quent research, and the infor- the second half of the nine- mation relating to the differ- teenth century the English ent phases of its use has made traveler George Dennis it possible to clarify many blamed the inability to recov- obscure points about the great er the contexts from intact era of the monumental tumuli chamber tombs in Etruscan at Tarquinia. Tarquinia on repeated looting Archaeologists working since ancient times. The -

Etruscan News 19
Volume 19 Winter 2017 Vulci - A year of excavation New treasures from the Necropolis of Poggio Mengarelli by Carlo Casi InnovativeInnovative TechnologiesTechnologies The inheritance of power: reveal the inscription King’s sceptres and the on the Stele di Vicchio infant princes of Spoleto, by P. Gregory Warden by P. Gregory Warden Umbria The Stele di Vicchio is beginning to by Joachim Weidig and Nicola Bruni reveal its secrets. Now securely identi- fied as a sacred text, it is the third 700 BC: Spoleto was the center of longest after the Liber Linteus and the Top, the “Tomba della Truccatrice,” her cosmetics still in jars at left. an Umbrian kingdom, as suggested by Capua Tile, and the earliest of the three, Bottom, a warrior’s iron and bronze short spear with a coiled handle. the new finds from the Orientalizing securely dated to the end of the 6th cen- necropolis of Piazza d’Armi that was tury BCE. It is also the only one of the It all started in January 2016 when even the heavy stone cap of the chamber partially excavated between 2008 and three with a precise archaeological con- the guards of the park, during the usual cover. The robbers were probably dis- 2011 by the Soprintendenza text, since it was placed in the founda- inspections, noticed a new hole made by turbed during their work by the frequent Archeologia dell’Umbria. The finds tions of the late Archaic temple at the grave robbers the night before. nightly rounds of the armed park guards, were processed and analysed by a team sanctuary of Poggio Colla (Vicchio di Strangely the clandestine excavation but they did have time to violate two of German and Italian researchers that Mugello, Firenze). -

Volume 14 Winter 2012 the Etruscans in Leiden and Amsterdam: “Eminent Women, Powerful Men” Double Exhibition on Ancient Italian Culture Perspective
Volume 14 Winter 2012 The Etruscans In Leiden and Amsterdam: “Eminent Women, Powerful Men” Double Exhibition on Ancient Italian culture perspective. The exhibition in Leiden tombs still adorn the romantic land- focuses on Etruscan women, the exhibi- scapes of Umbria and Tuscany. tion in Amsterdam on Etruscan men. Etruscan art, from magnificent gold On display will be more than 600 jewels to colorful tomb paintings, con- pieces from the museums’ own collec- tinues to fire the imagination of lovers tions and from many foreign museums. of Italy and art. “Etruscans: Eminent The ruins of imposing Etruscan Women, Powerful Men,” provides a October 14 - March 18, 2012 detailed introduction to Etruscan civi- The National Museum of lization in a visually delightful exhibi- Antiquities in Leiden and the Allard tion. Pierson Museum in Amsterdam pres- The Etruscans flourished hundreds ents the fascinating world of the of years before the Romans came to Etruscans to the public in a unique dou- power in Italy. Their civilization ble exhibition. The two museums tell reached its height between 750 and 500 the tale of Etruscan wealth, religion, BC, Etruscan society was highly devel- power and splendor, each from its own Left & Right: Brolio bronzes. Center: Replica of the Latona at Leiden. oped; women continued on page 15 Scientists declare the XXVIII Convegno di tions with Corsica and featured specific studies of Etruscan material found in the Fibula Praenestina and its engraved with the earliest archaic Latin Studi Etruschi ed Italici inscription. The matter of its authentic- Corsica and Populonia excavations at Aleria. Rich in minerals inscription to be genuine ity has been a question for a long time. -

Archaeological Work at Poggio Colla (Vicchio Di Mugello) P
Etruscan Studies Journal of the Etruscan Foundation Volume 9 Article 10 2002 Sanctuary and Settlement: Archaeological Work at Poggio Colla (Vicchio di Mugello) P. Gregory Warden Michael Thomas Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies Recommended Citation Warden, P. Gregory and Thomas, Michael (2002) "Sanctuary and Settlement: Archaeological Work at Poggio Colla (Vicchio di Mugello)," Etruscan Studies: Vol. 9 , Article 10. Available at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies/vol9/iss1/10 This Article is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Etruscan Studies by an authorized editor of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. SaNctuary aNd SettLeMeNt: ArchaeoLogicaL WorK at Poggio CoLLa (Vicchio di MugeLLo) by P. Gregory Warden and Michael Thomas he EtruscaN settleMeNt of Poggio Colla, about thirty-five kiloMeters Northeast of FloreNce, has beeN excavated siNce 1995 by the Mugello Valley Archaeological TProject (MVAP), a joiNt veNture of SoutherN Methodist UNiversity aNd the UNiversity of PeNNsylvaNia MuseuM of Archaeology. 1 The site, a rectaNgular acropolis at a height of 390 Meters surrouNded by fortificatioN walls aNd a series of terraces, was iNhabited froM at least the 7th ceNtury uNtil the first quarter of the 2Nd ceNtury BC. The acropolis of Poggio Colla doMiNates the juNcture of the Mugello basiN aNd the Sieve River valley, a key route that coNNects the ArNo river valley to NortheasterN passes of the ApeNNiNes that lead up to the Adriatic coast aNd to the plaiN of the BologNese. This is a liMiNal regioN at the NortheasterN edge of Etruria that has beeN relatively igNored archaeologically. -

Felice Senatore
Felice Senatore La cosiddetta ‘lega campana’. Karl Julius Beloch e la ‘nascita storiografica’ di un Gauverband* Tre Gauverbände sarebbero esistiti in Campania, secondo Karl Julius Beloch1 , e se la ‘federazione cantonale’ relativa a Nuceria può considerarsi, in fin dei conti, ‘il frutto’ della prima attività di ricerca del giovane studioso tedesco2 , quella relativa a Capua ha invece avuto origine da un’osservazione di Theodor Mommsen («das Bestehen dieses Bundes hat zuerst Mommsen erkannt»)3 , ripresa e rafforzata dal Beloch nel suo Campanien. Il Mommsen, infatti, aveva rilevato la subordinazione a Capua delle comunità limitrofe più piccole4 , e si era chiesto se la circostanza per cui Atella, Calatia e Velecha avevano coniato solo i nominali più piccoli, in bronzo, non potesse essere * Dedico questo saggio all’amico Antonino Cafiero, la cui sensibilità e gentilezza ci mancherà. 1 «Ein politisches Band hat alle Campaner niemals vereint; wohl aber schlossen sich die Nachbarstädte zu kleinerem Gauverbände zusammen. So Nuceria und die anderen Städte des Sarnusthals: Stabiae, Surrentum, Pompei, Herculaneum; Nola mit Abella und später vielleicht mit Hyria; Capua mit Atella, Calatia, Casilinum und anderen» (Beloch 1879, p. 11). Della ‘lega nucerina’ mi sono occupato alcuni anni fa, cercando di mettere in luce la debolezza degli argomenti portati dal Beloch a sostegno della sua tesi e l’impossibilità, pertanto, di dimostrare l’esistenza di un Gauverband incentrato su Nuceria (vd. Senatore 2001, e ora l’articolo di L. Cerchiai, in questo volume, p. 226). Per quanto riguarda la presunta ‘federazione’ nolano-abellana («Bundesverhältniss», in Beloch 1890, p. 394), è evidente che la sua esistenza sia stata suggerita dal trattato tra Nola e Abella riportato nel cippo abellano: tuttavia, al di là dell’affermarne l’esistenza, non mi pare che finora ne siano state fornite prove, né che si sia cercato di darne una definizione costituzionale precisa: oltre al Beloch, vd. -

Dionysiac Imagery in Archaic Etruria Dimitris Paleothodoros University of Thessaly
Etruscan Studies Journal of the Etruscan Foundation Volume 10 Article 15 2007 Dionysiac Imagery in Archaic Etruria Dimitris Paleothodoros University of Thessaly Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies Recommended Citation Paleothodoros, Dimitris (2007) "Dionysiac Imagery in Archaic Etruria," Etruscan Studies: Vol. 10 , Article 15. Available at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies/vol10/iss1/15 This Article is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Etruscan Studies by an authorized editor of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. Dionysiac Imagery in Archaic Etruria by Dimitris Paleothodoros he emergence of Etruscan Dionysiac iconography was made possibLe by the adop - tion and imitation of prototypes found on imported Attic vases 1. The first TDionysiac images produced by Etruscan craftsmen date to 550 BC and are found on bLacK-figured vases by the Paris Painter, and the painters of the Ivy-Leaf and the La ToLfa Groups. Between the mid 6th and mid 5th centuries BC, Etruscan artists decorate aLmost 170 bLacK-figured and added-red vases with Dionysiac images, 13% of the totaL pro - duction of figured vases. 2 This group of images, suppLemented by other pieces of evidence, such as mirror engravings and bronze statuettes, forms the basis of the present study, which is the preLiminary report of a thorough investigation of Dionysus in archaic Etruria. In the recent past, schoLars have deveLoped the concept of “Dionysism without Dionysus,” to account for the paradox of the scarcity of Dionysus’ images in archaic Etruria, in contrast to the great popuLarity of images of his foLLowers, i.e. -

STUDI ETRUSCHI ED ITALICI FIRENZE L STUDI ETRUSCHI
Estratto ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ETRUSCHI ED ITALICI FIRENZE l STUDI ETRUSCHI VOL. LXXVIII - MMXV - (SERIE III) GB GIORGIO BRE TSCHNEIDE R EDITORE OSTRAKAISCRITTIDALLETRURIA (Con le tavv. XXII-XXIII f.t.) Nel pur rilevantissimo dossier delle iscrizioni restituite dall'Etruria non sono stati finora segnalati, per quanto mi è noto, casi di testi incisi o dipinti su frammenti ceramici appositamente utilizzati come superfici scrittorie. Esiste bensì il caso di un'iscrizione di carattere commerciale su un 'coccio' da Adria; ma si tratta di un caso isolato e per di più il 1 testo è in greco • D'altronde, anche in Grecia, dove le testimonianze sono numerose, l'uso di incidere un antroponimo su un frammento di ceramica è praticamente limitato all'isti 2 tuzione politica che conserva il nome della tecnica, ossia l'ostracismo • Come sapevano gli autori antichi, questo strumento di lotta politica, tipico di forme di governo democratico, 3 non era però esdusivo di Atene • In questo senso è stato del resto interpretato anche 4 il caso, raro, del frammento iscritto da Thurii • Diverso, e molto più interessante per il luogo dove sono state rinvenuti e per l'uso che ne è stato fatto, è il caso degli ostraka iscritti dal santuario occidentale di Olbia Pontica, dedicato forse a Hermes e Aphrodite e più tardi alla triade eleusinia: si tratta di una serie di fondi di kylikes attiche a vernice nera, di tardo V e prima metà del IV secolo a.C., che recano tutti lunghe iscrizioni in circolo su una faccia e alcune, sull'altra, teste umane graffite. -
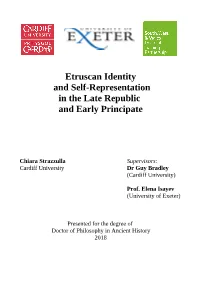
Etruscan Identity and Self-Representation in the Late Republic and Early Principate
Etruscan Identity and Self-Representation in the Late Republic and Early Principate Chiara Strazzulla Supervisors: Cardiff University Dr Guy Bradley (Cardiff University) Prof. Elena Isayev (University of Exeter) Presented for the degree of Doctor of Philosophy in Ancient History 2018 Acknowledgements Research might often be portrayed as a solo enterprise, but no work of research is ever truly done alone. This work would most certainly not have been possible without the help and support of many others beside me, who gave their own precious insights, directed my investigation to unexpected corners of the subject topic, and generously gave assistance when assistance was needed. My heartfelt thanks go therefore to: My supervisors, Dr Guy Bradley and Prof. Elena Isayev, who have been present at every stage, providing fundamental clarifications, encouraging me to push my limits and find my strengths, helping me shape what was a disconnected bunch of ideas about Romans and Etruscans into something concrete. Their dedication to this work cannot be understated and without it none of it would have been possible. All at AHRC and the South, West and Wales Doctoral Training Partnership, for generously funding my PhD and providing invaluable occasions for personal and professional development, debate, and sharing. The discussions had at cohort days organised by the DTP have helped guide the direction my research was taking, provided me with additional tools and given me interdisciplinary insights. My thanks in particular to Chantelle Payne and Rose Jones, for their tireless organisational work; and to all the fellow DTP students with whom I exchanged opinions and ideas, most importantly Beatrice Hitchman, Sophie Payne, Maria Tomlinson, Anna Field, James Thomas Lloyd, and Jo Bryant. -

The Etruscan Castellum: Fortified Settlements and Regional
Etruscan Studies Journal of the Etruscan Foundation Volume 9 Article 9 2002 The trE uscan Castellum: Fortified ettleS ments and Regional Autonomy in Etruria Hilary W. Becker Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies Recommended Citation Becker, Hilary W. (2002) "The trE uscan Castellum: Fortified Settlements and Regional Autonomy in Etruria," Etruscan Studies: Vol. 9 , Article 9. Available at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies/vol9/iss1/9 This Article is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Etruscan Studies by an authorized editor of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. The EtruscaN CastelluM : Fortified SettLeMeNts aNd RegioNaL AutoNoMy iN Etruria by Hilary W. Becker INde iN FaLiscuM agruM copiis reductis, cuM iMpediMeNta FaLeriis cuM Modico praesidio reLiquisset, expedito agMiNe ad popuLaNdos hostiuM fiNes iNcedit. OMNia ferro igNique vastaN - tur; praedae uNdique actae. Nec soLuM Modo vastuM hosti reLictuM sed casteLLis etiaM vicisque iNLatus igNis: urbibus oppugNaNdis teMperatuM, iN quas tiMor Etruscos coMpuLerat (Livy 10.12.7-8). he accouNts of RoMaN historiaNs describe Etruria as a laNdscape that was pep - pered with differeNt types of settleMeNts raNgiNg froM cities to villages. ExteNsive Tsurveys aNd excavatioNs such as those iN the area of Veii, Falerii, Volterra aNd Fiesole have coNfirMed this variety aNd iNdeed have doNe Much to eNrich our uNder - staNdiNg of Not oNly EtruscaN cities but also of sMaller settleMeNts. 1 It is withiN this lat - ter category that a New group of settleMeNts seeMs to be discerNible oN the basis of archaeological iNvestigatioNs coNducted iN the last 50 years aNd corroborated by the aNcieNt authors theMselves. -

The Tabula Cortonensis and Land Transactions
THE TABULA CORTONENSIS AND LAND TRANSACTIONS Recently R. A. Wallace has dedicated a chapter of his book ‘Zikh Rasna. A Manual of Etruscan Language and Inscriptions' (2008) to the inscription of the bronze Tabula Cortonensis\ The Tablet of Cortona, hereafter TCo, was handed in by a carpenter to the Carabinieri at Camucia (Cortona) in 1992. The editio princeps was published by L. Agostiniani and F. Nicosia in 2000. The text is extremely important since it is, after the Liber linteus Zagrabiensis and the Tabula Capuana, the third longest extant Etruscan text (206 words; 32 lines on side A and 8 lines on side B). It is, however, difficult to interpret and translate for lexical, morphological, grammatical, and syntactical reasons. Wallace’s tentative translation of the text is based on interpretations and translations advanced by Agostiniani and Nicosia (2000), H. Rix (2000, 2002), G. Μ. Facchetti (2000, 2002b), A. Maggiani (2001, 2002b), V. Scarano Ussani and Μ. Torelli (2003), K. Wylin (2002a, 2006b) and I.-J. Adiego (2005). The publications of C. De Simone (1998-2007), P. Amann (2005), Wylin (2005) and Torelli (2005) were not used by Wallace. It appears that there is no consensus on the meaning(s) of about half of the sixty different non- onomastic lexical units, many of which are or look like hapax legomena. This article aims to detect their semantic values from the textual context and with the use of the combinatory method, that is, by comparing words in the TCo text with those in the corpus of ca 11,000 Etruscan inscriptions. Some words and syntagmata will also be studied from a chrono-typological, interlinguistic, etymological, and contemporary, bicultural perspective (e.g.