Linguaggio E Frammenti Di Un'antica Cultura
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

U S La D M E N M a Q M
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% B C M Y SLUR 5%B B C M Y 80% 40% BAL B C M Y SLUR 5%C B C M Y 80% 40% C+M B C M 5% B C M Y 80% 40% M+Y B C M Y SLUR 5%Y B C M Y 80% 40% C+Y B C M Y SLUR 5%B B C M Y 80% 40% BAL B C M Y SLUR 5%C B C M Y 80% 40% C+M B C M 5% B C M Y 80% 40% M+Y B C M YSLUR 5%Y B C M Y 80% 40% C+Y DALLA REDAZIONE Maiella, la Montagna Madre d’Abruzzo Quattro caratteristiche che rendono unico questo parco nazionale nel cuore dell’Appennino Narra la leggenda che Maja, la più bella delle pleiadi, fuggì dalla Frigia per salvare il suo unico figlio: Ermes, colpito mortalmente in battaglia. Maja venne informata di una pianta che poteva salvare l’amato gigante guerriero e che cresceva su un monte di una penisola del Maditerraneo. Così la dea si mise in viaggio sbarcando sulle coste dell’Adriatico, ma il monte indicato era ancora coperto di neve, la pianta non era ancora germogliata ed Ermes morì. Maja fu colta da grande disperazione e iniziò a vagare per i boschi, fino a quando affranta dal dolore e spenta dalle troppe lacrime versate, morì, sul monte che l’aveva accolta e che oggi porta il suo nome: la Maiella. -

PSL Gran Sasso Velino Approvato Con DGR. N. 629
PIANO DI SVILUPPO LOCALE Rimodulazione agosto 2012 GRAN SASSO – VELINO: UN’IDENTITA’ MASSICCIA REGIONE ABRUZZO PSR 2007-2013 La proposta di Piano di Sviluppo Locale consiste in un documento con pagine rilegate, numerate e sottoscritte in ogni facciata dal legale rappresentante del GAL, redatto in base al modello di seguito descritto. Il presente documento è aggiornato alla data odierna ed in tal senso contiene in nota i cambiamenti più significativi intercorsi dalla prima edizione INDICE PREMESSA ........................................................................................................................................................... 3 1 GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ......................................................................................................... 4 1.1 GAL e partenariato ....................................................................................................................................... 4 1.2 Consultazione partenariato ........................................................................................................................... 8 2 TITOLO DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) .............................................................................. 19 3 AREA GEOGRAFICA INTERESSATA DAL PSL ..................................................................................... 20 3.1 Descrizione dell‟area geografica interessata dal PSL ................................................................................. 20 3.2 Tabella riepilogativa dei dati ..................................................................................................................... -

Consiglio Regionale Ufficio Di Presidenza
REGIONE ABRUZZO CONSIGLIO REGIONALE UFFICIO DI PRESIDENZA Deliberazione N. 60 dell’8.05.2018 Oggetto: Concessione Patrocini. L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di maggio alle ore 10.40 presso la sede del Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito: Pres. Ass. Presidente Giuseppe DI PANGRAZIO SI ___ Vice Presidenti: Lucrezio PAOLINI SI ___ Paolo GATTI SI ___ Consiglieri Segretari: Alessio MONACO SI ___ Giorgio D’IGNAZIO DIMESSO Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario L'UFFICIO DI PRESIDENZA Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 200 del 29.11.2012 concernente”Criteri e direttive per la concessione del patrocinio non oneroso da parte del Consiglio regionale e all’adesione ai Comitati d’Onore sostitutiva della deliberazione n. 113 del 15.07.2010; Viste le schede tecniche predisposte dal Servizio di Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione relative alle richieste di patrocinio presentate dagli Enti sotto elencati per la realizzazione delle manifestazioni a fianco di ciascuno indicate: 1. ANED – Associazione Nazionale Emodializzati Abruzzo = “Giochi nazionali trapiantati e XXV edizione giochi dializzati”, i giochi nazionali si svolgeranno in una cittadina marittima, Pineto, e avranno lo scopo di rendere a pieno il senso di incontro tra esperienze, storie, gioie e dolori, volontà, in una parola vita. Pineto (TE), 1-3 giugno 2018; 2. Associazione Presenza Culturale Romolo Liberale = “Premio Poesia ‘Romolo Liberale’ ”, la Cerimonia di premiazione del concorso - articolato in tre sezioni e aperto a tutti- ha lo scopo di rendere omaggio alla memoria di un poeta e scrittore di profonda sensibilità e di grande impegno, nelle cui opere le difficoltà e le ingiustizie, che caratterizzano la condizione esistenziale e sociale dell'uomo del nostro tempo, assumono particolari accenti lirici, solcati sempre dalla speranza e dalla prospettiva del riscatto. -
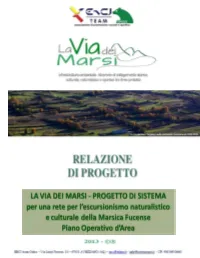
Via Dei Marsi
1 2 Progetto La Via dei Marsi: Allegato tecnico Il Progetto “La Via dei Marsi” è centrato sulla integrazione tematica e territoriale dell’area della Marsica Fucense vista come Rete Marsicana della Mobilità di fruizione strutturata intorno a La Via dei Marsi ed alle Aree Protette (Nazionali e Regionali) quali ambiti di eccellenza per la qualità dell’ambiente, l’attrattività per un turismo sostenibile e la fornitura di servizi, sviluppando anche le connessioni con le Regioni ed Aree Protette confinanti. L’obiettivo è irrobustire e diffondere un processo, già in parte avviato in alcune realtà, in grado di coniugare la conservazione – e ove occorre anche la riqualificazione - dell’ambiente con la promozione socio-economica delle comunità più svantaggiate dell’interno, tenendo conto che la sofferente, realtà turistica di montagna, può trarre benefici dalla estensione dell’offerta nel territorio e nell’arco dell’anno. E’ stato quindi costruito un quadro generale sulla progettualità della proposta “La Via dei Marsi” nel Sistema della Rete Marsicana della Mobilità e le Aree Protette della Marsica 3 Fucense interessate [Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Regionale Sirente Velino, la Riserva del Monte Salviano e le altre Riserve Regionali presenti nel territorio, da Carsoli a Canistro (Valle del Liri), ad Ortona e Bisegna (Valle del Giovenco), fino a Pescasseroli (dall’Alta Vallelonga e Cicerana) e cosi via], la cui realizzazione prevede interventi finanziabili attraverso diversi canali, europei, statali e regionali. La base di partenza è stata costituita da: il Progetto La Via dei Marsi, articolato nelle sue diverse componenti e i progetti settoriali, veri e propri Poli Strategici, Presidi territoriali; i Piani dei Parchi e delle Riserve ed i Piani Pluriennali Socioeconomici; i diversi atti di programmazione degli Enti di gestione delle Aree Protette e della Regione stessa, tra cui le annuali deliberazioni della Giunta regionale di riparto delle risorse per le aree protette, con individuazione dei progetti prioritari. -

Piano Di Classifica E Di Riparto
Piano di Classifica e di Riparto Approvato con Delibera n 30 del 24/03/1998 e delibera n 149 del 15/11/2000 1 1. PREMESSE L’art. 860 del c.c. afferma che i proprietari dei beni, situati entro il perimetro del comprensorio di un Consorzio di Bonifica, sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Quantificare un tale beneficio non è compito semplice, infatti, bisogna operare una sintesi di un’attività altamente diversificata, che si estrinseca non solo sul piano organizzativo ma anche sulla verifica oggettiva dell'azione del Consorzio per la salvaguardia del territorio, delle risorse idriche ed ambientali, nonché riguardo all'efficacia ed efficienza delle sue strutture idrauliche, irrigue e dei corsi d'acqua. Il primo passo da compiere, consiste nel focalizzare l'attenzione sugli indirizzi da perseguire e nel predisporre uno studio approfondito in grado di valutare, oggettivamente, i benefici che gli immobili ricevono dall’attività di bonifica. Si predispone così una classificazione dei singoli immobili per grado di beneficio, in modo da rendere possibile una ripartizione per quota di contributo spettante a ciascuno di essi. Si elabora, così, il "Piano di Classifica", importante atto amministrativo, che attraverso un metodo di valutazione aggiornato, consente di ottenere una più equa ripartizione degli oneri da porre a carico dei consorziati; rappresenta inoltre un valido strumento di conoscenza del territorio e di misura dell’efficacia delle opere di bonifica effettuate. Gli oneri che devono essere ripartiti tra gli immobili presenti nel comprensorio sono le spese che il Consorzio sostiene e che per legge sono a carico dei proprietari degli immobili stessi. -

Viaggio Attraverso L'abruzzo Pittoresco
Viaggiatori stranieri in terra d’Abruzzo Oggetto: Edward Lear Cronologia: 1846 Opera: Viaggio Attraverso l’Abruzzo pittoresco Autore: Edwar Lear nacque ad Halloway, nei pressi di Londra, nel 1812, fu scrittore e pittore. Spesso illustrava le sue stesse opere. Ebbe un’ adolescenza difficile, venti fratelli e un padre in prigione per debiti, e la vita turbata sin dalla giovinezza dalla malattia: soffriva infatti di epilessia e di asma. Abile disegnatore a diciotto anni insegnava privatamente e realizzava incisioni e stampe. Per mantenersi eseguì una serie di disegni o schizzi a carattere zoologico per la Reale Società Zoologica e pubblico nel 1832 il suo primo album “Illustrations of the Family of Psittacidae”. In seguito fu ospite e dipendente del Conte di Derby, come pittore naturalista, dove scrisse i suoi limerick per divertire i figli del conte e nel 1846 pubblica “Book of Nonsense”. Edward Lear passò gran parte della sua vita a viaggiare (grazie al lavoro, che gli permette di visitare luoghi più salubri), legandosi in particolar modo all'Italia: nel 1837 fu a Roma, da lì viaggiò molto nel meridione. Durante tutti i suoi viaggi produsse numerosi resoconti illustrati e nel 1841 pubblicò “Illustrated Excursions in Italy”, “Journal of a Landscape Painter in Southern Calabria”. Quattro anni di lavoro gli permettono di raccogliere i suoi limerick (brevi componimenti poetici) corredati di illustrazioni nel celeberrimo libro “A Book of Nonsense” che pubblica nel 1846 dietro lo pseudonimo di Derry Down Derry. Lear si dilettò a scrivere di botanica o alfabeti nonsense, che riunì nel libro “Nonsense Songs”, “Stories” e in “Botany and Alphabets”inverno. -

Consiglio Regionale Dell'abruzzo
REGIONE ABRUZZO CONSIGLIO REGIONALE UFFICIO DI PRESIDENZA Deliberazione N. 37 del 9/04/2019 OGGETTO: Concessione Patrocini. L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di aprile alle ore 10.45 presso la sede del Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito: Pres. Ass. Presidente Lorenzo SOSPIRI SI ___ Vice Presidenti: Roberto SANTANGELO ___ SI Domenico PETTINARI SI ___ Consiglieri Segretari: Sabrina BOCCHINO SI ___ Dino PEPE SI ___ Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario L'UFFICIO DI PRESIDENZA Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 200 del 29.11.2012 concernente”Criteri e direttive per la concessione del patrocinio non oneroso da parte del Consiglio regionale e all’adesione ai Comitati d’Onore sostitutiva della deliberazione n. 113 del 15.07.2010; Viste le schede tecniche predisposte dal Servizio di Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione relative alle richieste di patrocinio presentate dagli Enti sotto elencati per la realizzazione delle manifestazioni a fianco di ciascuno indicate: 1. Associazione Culturale Compagnia di Teatro Dialettale “Fiore”: Premio Nazionale di poesia “Patrizio Graziani” 2019, concorso nazionale di poesia, Gioia dei Marsi (AQ), dal 20 aprile 2019 al 26 ottobre 2019. undicesima edizione della manifestazione incentrata sulla figura di Patrizio Graziani, editore, poeta e critico d’arte, per la quale sono previste tre sezioni: Lingua, Dialetto, Ragazzi (riservata agli alunni della scuola dell’obbligo), si svolgerà presso il Centro Culturale Gioia dei Marsi; 2. Pro Loco Avezzano: Quarta edizione della Settimana Marsicana, manifestazione storica a valenza culturale, artistica, musicale, enogastronomica e sportiva, Avezzano (AQ) dal 29 luglio al 4 agosto; 3. -

Progetto CARG Per Il Dipartimento Difesa Del Suolo - Servizio Geologico D’Italia: F
1 PROGETTONOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA alla scala 1:50.000 foglio 368 AVEZZANO a cura di: E. Centamore(1) Geologia del substrato U. Crescenti(2) Biostratigrafia F. Dramis(3) Geologia del Quaternario CARG con i contributi di: Geologia del substrato: P. Boncio(2), G. Lavecchia(2), F. Fumanti(7), G. Rusciadelli(2) Geologia del Quaternario: A.M. Blumetti(7), M. Coltorti(4), A.M. Michetti(6) Biostratigrafia: M. Chiocchini(5), P. Didaskalou(5), A. Mancinelli(5), R. Matteucci(1), A. Micarelli(5), M. Potetti(5), J.S. Pignatti(1), I. Raffi(2), G. Sirna(1) Aspetti applicativi: M. Coltorti(4), G. Conte(7), M. Petitta(1) (1) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; (2) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi “G.D’Annunzio” di Chieti; (3) Dipartimento di Scienze Geologiche, Università Roma Tre; (4) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Siena; (5) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Camerino; (6) Università Insubrica, Como; (7) APAT, Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio Geologico d’Italia 2 Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo - Servizio Geologico d’Italia: L. Serva Responsabile del Progetto CARG per il Dipartimento Difesa del Suolo - Servizio Geologico d’Italia: F. Galluzzo Responsabile del Progetto CARG per la Regione Abruzzo: L. Del Sordo, G. Ferrandino ComitatoPROGETTO Geologico Nazionale (D.P.C.M. 23-3-1999 e 9-12-1999): N. Accardi (presidente), G. Arnone, A. Boscherini, S. Cocco, V. Coccolo, U. Crescenti, L. Del Sordo, M. Grasso, P. Manetti, G. Mariotti, G. Pasquarè, R. -

EPOCA PREITALICA: IX-VI Secolo A.C
................................................................................ ____________________________ EPOCA PREITALICA: IX-VI secolo a.C. __________________ IX-VII sec a.C. Durante la prima età del ferro in Italia, nella zona dell'Italia centrale appenninica che da verso l'Adriatico, troviamo insediate popolazioni indeoeuropee giunte in Italia già da diverso tempo, definite Osco-umbre. Una parte degli Osco-Umbri si è da tempo insediata nella zona del lago del Fucino e abita anche la zona di Trasacco. In questo momento la zona fucense, così come l'area di Trasacco, vede lo spostamento degli abitati da zone perilacustri o di pianura a zone d'altura dove iniziano ad essere costruiti insediamenti fortificati. IX-VII sec a.C. I principali centri fortificati nell'area trasaccana riguardano "Balzone" di S. Rufino (Ortucchio)"Colle della Croce" di Valle Canale (Collelongo) e la "Chiusa grande" di Monte Alto di Trasacco. In queste zone sono venute alla luce tombe di necropoli a tumulo risalenti a questo periodo. Precisamente sono state rinvenute nella piana di Vallelonga in localita "Capo La Croce", in località "Passarano" e nell'interno dell'abitato di Trasacco. Da quanto trovato nelle tombe, principalmente armi o difese di metallo emerge una società appartenente alla "cultura fucense". Tale cultura risulta molto importante nella prima età del ferro nella definizione della cultura safina. In base a quanto rinvenuto oltre che dalle tombe anche da ciò rimane di quegli antichi abitati, ci descrive tre centri abitatitivi dotati di recinzione muraria formata da grossi blocchi calcarei e racchiudenti abitati di capanne foderate in argilla. Nelle tombe sono stati rinvenute armi in ferro, dischi-corazza in lamina di bronzo, carri da battaglia in legno rivestiti in ferro, vasellame ed ornamenti in bronzo. -

Carlo D'angiò E Corradino Di Svevia
1 2 Note sulla battaglia dei Piani Palentini tra Carlo D’Angiò e Corradino di Svevia del 23-Agosto-1268 di Fausto Vincenzo Colucci Miniatura sulla battaglia. Carlo D’Angiò erompe dalla selva. 3 4 Indice Premessa……………………………………………..pag. 7 I personaggi……………………………………..…… “ 9 Gli eserciti…………………………...……….…….. “ 13 L’avvicinamento……………………………...….… “ 20 Il territorio………………………………………...... “ 39 Lo scontro………………………………..…………. “ 47 I tempi successivi…………………………………… “ 73 Documenti…………………….. ………….……….. “ 89 5 6 Premessa Lo scopo di questa pubblicazione è di fornire al lettore elementi sufficienti per farsi un’idea personale dell’avvenimento storico indicato come la battaglia di Tagliacozzo, vista la disparità di opinioni formulate da numerosi storici, professionisti e non, che riferiscono sull’argomento in maniera spesso contraddittoria. In fondo, l’unica fonte ‘storica’ della battaglia è la lettera che Carlo I d’Angiò scrive al Papa Clemente IV la sera stessa dello scontro, il 23 agosto 1268, “data in Campo Palestino [Palentino]”. Esiste anche una seconda lettera, che lo stesso D’Angiò scrive ai padovani (potestati Consilio et Communi Paduano) il giorno seguente, 24 agosto, “data in Campo Pallentino prope Albam” stranamente trascurata e pubblicata nel 1869 da Giuseppe Del Giudice. 1 Questa seconda lettera poco aggiunge alla prima, avendone molte parti pressoché uguali, tuttavia anche poche informazioni aggiuntive possono essere preziose nella scarsità o assenza di altre fonti dirette. Alcune contraddizioni che a volte appaiono nelle fonti non riguardano tanto l’aspetto militare dell’evento, descritto dallo 1 G DEL GIUDICE, Codice diplomatico del regno di Carlo I e II D’Angiò., Stamperia regia Università, Napoli 1869, vol II, parte I, 191 e segg, L’autore riporta il documento dal Cronicon Patavinum di Ludovico Antonio Muratori (1672- 1750) in Antiquitates Italicae Medii Aevi, Societatis Palatinae, Milano 1741, Tomo IV, 1145. -

Edilizia Storica Della Marsica Occidentale-Testo Completo-150Dpi
INDICE Presentazione del Sindaco di Sante Marie III Introduzione 1 CAPITOLO I ASPETTI GEOGRAFICI E AMBIENTALI DEL TERRITORIO 5 1) Orografia e idrografia. Le strade naturali. 5 2) Geologia e materiali da costruzione 6 3) La vegetazione 11 4) Il tessuto insediativo 12 CAPITOLO II L’ANTICHITÀ 16 1) La preistoria 16 2) Ocres e necropoli preromane 19 3) Le trasformazioni del territorio dopo la conquista romana 26 4) Vici e santuari italico-romani 33 5) Tecniche edilizie romane 37 CAPITOLO III IL MEDIOEVO. LINEAMENTI STORICI E TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO 41 1) Gastaldi longobardi, curtes e monasteri. 41 2) Conti dei Marsi, De Pontibus e Orsini tra IX e XV secolo 43 3) Il fenomeno dell’incastellamento 44 CAPITOLO IV TECNICHE EDILIZIE MEDIEVALI 45 1) Aspetti generali 45 2) Murature in conci 47 3) Murature in blocchi 49 4) Murature a blocchetti 50 5) Murature irregolari 50 6) Laterizi nelle murature e sui tetti 52 CAPITOLO V I CASTELLI 54 1) Evoluzione dell’architettura fortificata tra XI e XVI secolo 54 2) Il recinto fortificato. I castelli di Tremonti, Castelvecchio, Tagliacozzo, Scurcola, Monte San Nicola e San Donato 58 3) Il castello residenza. I castelli di Carsoli, Oricola, Pereto, Torano, Albe. Le sopravvivenze nei centri minori 74 CAPITOLO VI I BORGHI MURATI 79 1) Le origini dei paesi odierni. 79 2) L’evoluzione del borgo: dal recinto alle case-mura. Alcuni esempi abruzzesi. 82 3) Circuiti di case-mura nei paesi della Marsica occidentale 85 4) Differenze morfologiche e dimensionali tra castelli e borghi. I c.d. castelli di Sante Marie, Scanzano e Luppa 90 5) Aspetti dei paesi medievali. -

POR ABRUZZO Azione C.1.3
ANPI MARSICA CAI – CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Avezzano Sezione ‘ Valle Roveto ’ 6^ Edizione, Anno 2019, PRESENTAZIONE a cura del Dr. Sergio NATALIA ARTICOLAZIONE della PRESENTAZIONE 1. I PROMOTORI 2. LE FINALITA’ E GLI OBIETTIVI 3. L’ITINERARIO 4. LE TEMATICHE DEL CAMMINO E IL COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI 5. LA LOGISTICA 2 1. I Promotori 3 1. I Promotori L’Associazione «Cammino dell’Accoglienza» in collaborazione con: ANPI Marsica Associazione Culturale “Il Liri” CAI “Avezzano” CAI “Valle Roveto” a cura di Sergio NATALIA 4 1. I comuni coinvolti 1. Avezzano 5. Civita D’Antino 2. Balsorano 6. Civitella Roveto 3. Canistro 7. Luco dei Marsi 4. Capistrello 8. Morino 9. S. Vincenzo V.R. 5 1. Le Scuole coinvolte Scuole Medie Scuole Superiori della Marsica della Marsica Rete «Scuole in Cammino» 6 1. Le Associazioni coinvolte Tutte le Associazioni operanti nei comuni traversati dal “Cammino dell’Accoglienza”. 7 1. Le altre adesioni L’iniziativa ha avuto, in passato, il patrocinio morale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e l’adesione del Prefetto dell’Aquila. 8 2. Le Finalità e gli Obiettivi 9 2. Le finalità del “Cammino” 10 2. Gli obiettivi del “Cammino” • contribuire alla conoscenza della nostra storia recente; • contribuire a configurare la Marsica come terra ospitale; • costituire uno strumento per una riflessione corale sull’attuale significato del termine “accoglienza”, alla luce dei nuovi scenari storico-culturali; •favorire la conoscenza del nostro territorio sotto l’aspetto naturalistico e culturale; •valorizzare sotto il profilo turistico la Marsica. 11 2. Il «Cammino dell’accoglienza»: le relazioni funzionali Cicloturismo, Trekking, Arrampicata Climbing, Sci da fondo, Torrentismo Equitazione; Parapendio Birdwatching, ecc SPORT TURISMO CULTURA CAMMINO AMBIENTE STORIA GASTRON.