Foglio 389 ANAGNI
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Geologists and Speleology Between XIX and XX Century
DOI 10.7343/as-2017-281 profili storici Latium underground: geologists and speleology between XIX and XX century. Il Lazio sotterraneo: geologi e speleologia tra il XIX e XX secolo Maria Piro - CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano”- Dip. VI “Pianificazione territoriale generale”, Viale Giorgio Ribotta 41-43, Roma. email: [email protected] Keywords: karst, Latium, sinkhole, speleology Parole chiave: carsismo, Lazio, sinkhole, speleologia Le grotte e il carsismo dell'area laziale hanno suscitato da e anche le grotte costiere del Circeo, descrivendole in alcune sempre l’interesse degli studiosi di scienze geologiche. La pri- pubblicazioni (Brocchi 1817; 1824). ma discesa volontaria di un pozzo di cui si ha documentazione Giuseppe Ponzi, che fra le sue numerose cariche ebbe an- è quella realizzata nel 1800 dal naturalista e geologo marchi- che la prima cattedra di Geologia all’Università di Roma “La giano Paolo Spadoni, contemporaneo di Ambrogio Soldani, Sapienza” dal 1864 e fondò nel 1873 il Museo di Geologia, si nel Pozzo Santullo presso Collepardo (Frosinone), una voragi- interessò allo studio delle grotte; si ricorda in particolare lo ne di oltre 150 metri di diametro e 50 di profondità. L'impre- studio tramite saggi di scavo delle brecce ossifere del riempi- sa fu raccontata con dovizia diparticolari in un volume pub- mento della grotta di Collepardo (Ponzi 1853). blicato a Macerata (Spadoni 1802). Nel 1796 lo Spadoni era Fra i geologi che si interessarono e scrissero di carsismo nel stato incaricato dal cardinale Carandini di ispezionare alcune Lazio alla fine del XIX secolo e agli inizi del XX si devono cave di limonite presso Guarcino (Frosinone). -

Comune Di Fiuggi
Perito Agrario Alessandro Alebardi Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma Tel. e Fax +39 06.6633418 COMUNE DI FIUGGI PROVINCIA DI FROSINONE VERIFICA DEMANIALE RIGUARDANTE LA RICOGNIZIONE E LA DELIMITAZIONE DELLE TERRE SOGGETTE AL REGIME GIURIDICO DEGLI USI CIVICI GESTITE DAL COMUNE DI FIUGGI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE RELAZIONE GENERALE Roma, 30 settembre 2017 IL PERITO DEMANIALE P.A. ALESSANDRO ALEBARDI 1 Perito Agrario Alessandro Alebardi Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma Tel. e Fax +39 06.6633418 Verifica Demaniale Riguardante l’accertamento e sistemazione delle terre soggette al particolare regime giuridico degli usi civici gestite dal Comune di Fiuggi all’interno dell’intero territorio comunale. 1. Panoramica del territorio di Fiuggi (FR), con vista sul centro abitato di Fiuggi. 2 Perito Agrario Alessandro Alebardi Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma Tel. e Fax +39 06.6633418 SOMMARIO: 1. Premessa, pag. 4 2. Identificazione dei terreni, pag. 7 3. Cenni storici, pag. 8 4. Dati generali e territorio, pag. 28 5. Regime giuridico degli usi civici, pag. 30 6. Linee guida della ricerca, pag. 50 7. Descrizione degli atti demaniali compiuti per il territorio comunale di Fiuggi, pag. 55 8. Individuazione delle terre ancora soggette agli “usi civici”, pag. 129 9. Operazioni demaniali da svolgere, pag. 151 2. Palazzo comunale di Fiuggi (FR). 3 Perito Agrario Alessandro Alebardi Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma Tel. e Fax +39 06.6633418 1 - PREMESSA La Regione Lazio con il Decreto del Presidente della Regione Lazio Renata Polverini n. T00229 del 18 giugno 2012 (Allegato “1”), nominava lo scrivente Perito Agrario Alessandro ALEBARDI, con studio a Roma in Via Francesco Azzurri n. -

La Natura Selvaggia Dei Monti Ernici, Tra Faggeti E Sentieri Incontaminati Nell’Oasi Naturale Di Prato Di Campoli
_t ÇtàâÜt I LAGHI ED I FIUMI IL LAGO DI CANTERNO Il lago di Canterno è situato ai piedi dei Monti Ernici, tra i comuni di Ferentino, Fiuggi, Fumone, Torre Cajetani e Trivigliano. Il territorio circostante vede la presenza di numerose formazioni boschive con querceti, boschi misti di latifoglie, conifere, oltre a salici e pioppi nel fondovalle. Il parco comprensivo del lago ha una superficie complessiva di circa 1.824 ettari, Il lago, di formazione carsica, è ricco di esemplari ittici, ma sono presenti anche trampolieri, aironi e gallinelle d’acqua. La vegetazione circostante rappresenta inoltre un habitat ideale per uccelli e piccoli mammiferi. IL LAGO DI CARDITO Il Lago Selva, nella frazione Cardito Vallerotonda, è un bacino artificiale a servizio delle centrali idroelettriche dell’Enel di Grotta Campanaro e di Cassino ed ha una capacità di 2 milioni di metri cubi di acqua. Il lago ed il paesaggio circostante risultano particolarmente congeniali alla pratica di attività sportive, come la pesca, la canoa, il volo con parapendio, lo sport della mountain bike. Da alcuni anni è in atto u n progetto di valorizzazione ambientale con la realizzazione di strutture di accoglienza per incentivare nella zona l’afflusso dei visitatori. LAGO DI S. GIOVANNI INCARICO La Riserva Naturale, in cui è situato il Lago di S. Giovanni Incarico, Arce, Ceprano e Falvaterra, nella Valle del Liri. Ha una superficie di 725 ettari ed è stata istituita nel 1999. Il territorio comprende anche le aree archeologiche di Fregellae e Fabrateria, e ciò conferisce a questo luogo anche un richiamo di spessore culturale oltre che squisitamente naturalistico. -
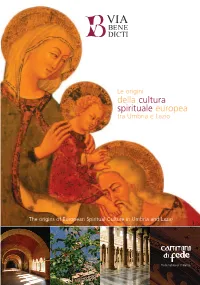
1337 Layout Brochure
Le origini della cultura spirituale europea tra Umbria e Lazio The origins of European Spiritual Culture in Umbria and Lazio Tra la natura e l’immenso. La Via Benedicti, insieme all’itinerario The Benedictine Way is part of the Da Norcia a Cassino, passando per la Sabina francescano con cui a tratti s’incrocia, Routes of Faith project, along with the e Roma, 10 tappe che fa parte del progetto Cammini di Fede Franciscan itinerary that crosses its path mostrano altrettante espressioni dell’universo che, dopo il notevole successo del from time to time. Following the notable benedettino. Cammino di Francesco tracciato success of the St. Francis Walk, a tourist inizialmente dall’APT Rieti sul proprio trail designed for the Rieti region by the local From Norcia to Cassino, territorio, oggi coinvolge sinergicamente tourist board, the project now actively involves through the Sabine region and on to Rome; le regioni Lazio e Umbria in un’unica the regions of Umbria and Lazio in providing 10 places to introduce visitors to the Benedictine proposta spirituale, turistica e culturale, a unique spiritual and cultural experience for way of life. partendo da due figure fondamentali visiting tourists, based around the lives of two per lo sviluppo del cristianesimo. men who were fundamental to the development of Christianity. San Benedetto, con il suo messaggio The message of St. Benedict was spread through veicolato dalle tante comunità the many Benedictine communities established benedettine diffuse ovunque a partire far and wide from the VI Century onwards. dal VI secolo, ha guidato il “vecchio He had helped the “old world” through one continente” lungo uno dei periodi più of the most difficult periods in its history, difficili della sua storia, tanto da earning himself in the process the title of meritarsi il titolo di Santo Patrono Patron Saint of Europe (Pacis Nuntius - d’Europa (Pacis Nuntius - Paolo VI, Paul VI, 24th October 1964). -

La Geodiversità Descrive La Varietà Dei Fenomeni
2. GEOdivErsità introduzione a geodiversità descrive la varietà dei fenomeni del patrimonio naturale geologico gli ottimi risulta- geologici e dei relativi processi presenti in una ti ed il pressoché unanime consenso internazionale Ldata area. Essa è correlata sia agli ambienti (es. raggiunto dalla biodiversità per la conservazione del vulcanico, glaciale, ecc.), sia alle tematiche (es. strati- patrimonio naturale biologico. grafia, geomorfologia, ecc.). Essa è inoltre strettamen- Si forniscono di seguito alcune tra le prime definizioni te connessa alla biodiversità, soprattutto tramite due coniate per la geodiversità: matrici ambientali che svolgono la funzione di anello − l’insieme (quindi, per l’appunto, la diversità) degli di congiunzione tra mondo vivente e non vivente: aspetti, associazioni, sistemi e processi geologici, − la pedosfera, cioè il suolo, formato da una compo- geomorfologici ed edafici (SHARPLES, 1995). nente organica e da una inorganica; − le testimonianze della storia della terra (testimo- − l’idrosfera, cioè l’acqua, che pur essendo un ele- nianze della vita passata, degli ecosistemi e degli mento inorganico, costituisce il fondamento inso- ambienti) e l’insieme dei processi (biologici, idro- stituibile di qualsiasi sistema biologico. logici ed atmosferici) agenti sulle rocce, sulla geo- Come accade per la biodiversità, che può essere morfologia e sul suolo (EBERHARD, 1997). analizzata a vari livelli gerarchici di approfondimento Alcune definizioni più recenti ampliano la prospettiva, (solitamente si indicano i livelli ecosistemico, inter- definendo la Geodiversità come: specifico e intraspecifico) anche per la geodiversità − il legame tra popoli, paesaggi e culture; la varietà occorre stabilire il livello d’analisi ed il campo d’inda- degli ambienti geologici, dei fenomeni e dei pro- gine. -

I Problemi Ignorati Del “Turismo in Ciociaria” Di Colombo Incocciati
I problemi ignorati del “Turismo in Ciociaria” di Colombo Incocciati Una significativa lacuna dobbiamo rilevare, nello studio patrocinato dall’ Unione Industriale di Frosinone, sulla base di una ricerca effettuata da Paride Quadrozzi, ai fini della diagnosi e della cura “Per un possibile turismo in Ciociaria”. Ed è quella, da parte dell’Autore, di aver completamente ignorato la copiosa bibliografia (*) di tutto ciò che sull’argomento (da almeno venti anni) è stato scritto sul “Fiuggi” (unico giornale turistico della provincia, dal 1905) ma anche da alcuni suoi collaboratori, sui quotidiani e i periodici, come Il Messaggero-Momento Sera-La Gazzetta Ciociara-Terra Nostra-Ciociaria ieri e oggi dell’Ept, fino agli anni ’90 e, di recente, anche su Ciociaria Oggi. l’Autore, qualora avesse soltanto sfogliato la raccolta di quelle testate, come ha consultato centinaia di altri testi, avrebbe certamente individuato, nella gestione politica del potere la causa e le responsabilità,che sono alla base dell’attuale crisi del turismo, soprattutto fiuggino. Il quale, costituendo (per stessa ammissione dell’autore) i due terzi del turismo provinciale, trascina con sé sia gli effetti positivi che quelli negativi, sul prodotto che ne deriva. Il Quadrozzi però, non dà il dovuto rilievo a questo importante aspetto del problema. Ecco il motivo per cui , con la sua ricerca, non ha potuto trovare molti elementi da offrire, come contributo al superamento della crisi, che anche lui auspica: ben sapendo che il turismo fiuggino, è il solo che possa fare da volano, al turismo provinciale. Tanto è vero che, a conclusione della sua analisi, si vede costretto a registrare una realtà, che è sempre ferma all’anno zero. -
ALLEGATO 2 Registro Delle Aree Protette Del Distretto
ALLEGATO 2 Registro delle aree protette del distretto – Abruzzo ..\_piani_di_tutela\RABRUZZO\REPORT ART5\Report_Abruzzo_art_5.pdf Registro delle aree protette del distretto – Umbria tratto da: 2_PARTE II_SEZIONE II_mod_2008.pdf tratto da: 4_PARTE II_SEZIONE III_mod_2008.pdf tratto da: 4_PARTE II_SEZIONE III_mod_2008.pdf tratto da: 9_PARTE III_SEZIONE III_mod_2008.pdf Registro delle aree protette del distretto - LAZIO Fonte PTA (prima fornitura) Le indicazioni utili alla formazione del Registro delle aree protette, per il Lazio sono reperibili in schede per sottobacino (appendice vol I schede di bacino.doc) di cui si riporta a titolo di esempio la sezione di interesse: Caratteristiche descrittive previste dal D.L.vo 152/99 ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile NO þ SI Acque idonee alla vita dei pesci NO þ SI Acque destinate alla vita dei molluschi þ NO SI Acque destinate alla balneazione NO þ SI AREE SENSIBILI: (% sul bacino) % AREE PROTETTE (Parchi, zone Ramsar, siti Natura 2000) TIPOLOGIA CODICE DENOMINAZIONE Riserva Regionale EUAP1036 Tuscania Parco Regionale EUAP0189 Marturanum ZPS IT6010055 Lago di Bolsena e Isole Bisentina e Martana ZPS IT6010008 Monti vulsini ZPS IT6010021 Monte Romano SIC IT6010008 Monti Vulsini SIC IT6010007 Lago di Bolsena SIC IT6010041 Isole Bisentina e Martana SIC IT6010020 Fiume Marta (alto corso) SIC IT6010021 Monte Romano SIC IT6010039 Acropoli di Tarquinia SIC IT6010028 Necropoli di Tarquinia SIC IT6010029 Gole del Torrente Biedano ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA: (% sul bacino) % AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (indicare solo se le aree sono state delimitate e non coincidono con i limiti minimi di legge) Zona di Rispetto Zona di Protezione S. -
Frutti Dimenticati E Biodiversità Recuperata
ISPRA_Cop dorso 13 mm:Layout 1 6-12-2017 14:54 Pagina 1 Unione europea Fondo europa agricoli per lo sviluppo reale L’Europa investe nelle zone rurali Informazioni legali L’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le persone che agiscono per conto dell’Istituto non sono responsabili per 'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo quaderno. ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma www.isprambiente.it ISPRA, Quaderni Natura e Biodiversità n. 8/2017 ISBN :978-88-448-0833-4 Riproduzione autorizzata citando la fonte Elaborazione grafica ISPRA Grafica di copertina: Sonia Poponessi Coordinamento tipografico: Daria Mazzella ISPRA – Settore Editoria Amministrazione: Olimpia Girolamo ISPRA – Settore Editoria Distribuzione: Michelina Porcarelli ISPRA – Settore Editoria Impaginazione : Gabriele Piazzoli ARPAE (FC) Stampa: Digitalia Lab - Roma Finito di stampare nel mese di Dicembre 2017 Stampa a cura di ARSIAL Finanziata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020 Misura 10, Sottomisura 10.2, Operazione 10.2.1 - FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - Unione europea Fondo europa agricoli per lo sviluppo reale L’Europa investe nelle zone rurali 2 A cura di: Sergio GUIDI (ARPAE Emilia Romagna), Pietro Massimiliano Bianco (Ispra), Vanna FORCONI (ex ISPRA), con la collaborazione di Miriam D’ANDREA (Ispra). Autori: Immacolata BARBAGIOVANNI M. (ARSIAL), Pietro Massimiliano BIANCO (Ispra), Rita BIASI (Dipartimento -

Analisi Dello Status E Della Distribuzione Dei Rapaci Diurni Nidificanti Nel Lazio
ANALISI DELLO STATUS E DELLA DISTRIBUZIONE DEI RAPACI DIURNI NIDIFICANTI NEL LAZIO foto di Vincenzofoto di Penteriani Quaderni - Natura e Biodiversità 2/2012 1 Informazioni legali L’istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le persone che agiscono per conto dell’Istituto non sono responsabili per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo Quaderno. La Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, ha isti- tuito l’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L’ISPRA svolge le funzioni che erano proprie dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (ex APAT), dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ex INFS) e del- l’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ex ICRAM). Informazioni legali ISPRA – Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma www.isprambiente.it ISPRA, Quaderni – Natura e Biodiversità n. 2/2012 ISBN 978–88–448–0529–6 Riproduzione autorizzata citando la fonte Elaborazione grafica: ISPRA Editing e grafica: Paolo Di Orazio Grafica di copertina: Franco Iozzoli Foto di copertina: Albanella minore (Roberto Ragno) – Astore, Grifone (Vincenzo Pen- teriani) – Grillaio (Stefano Laurenti), Falco pecchiaiolo, Aquila reale (Michele Cento) Coordinamento tipografico: Daria Mazzella ISPRA – Settore Editoria Citazione del volume: Aradis A., Sarrocco S. & Brunelli M. 2012. Analisi dello status e della distribuzione dei rapaci diurni nidificanti nel Lazio. Quaderni Natura e Biodiversità 2/2012 ISPRA, ARP Lazio. -
Rapporto Ambientale Regionale
Rapporto Ambientale del PdS 2010 Regione Lazio Pag. 1 INDICE 1 INTRODUZIONE ...................................................................................................................................................... 2 1.1 STRUTTURA DEL RAPPORTO REGIONALE................................................................................................................. 2 1.2 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE ATTIVATE PER LA VAS ...................................................................................... 2 1.3 FONTI DATI DISPONIBILI ........................................................................................................................................... 2 2 CONTESTO AMBIENTALE.................................................................................................................................... 4 2.1 CARATTERIZZAZIONE GEOGRAFICA ........................................................................................................................ 4 2.2 BIODIVERSITÀ ED AREE PROTETTE .......................................................................................................................... 6 2.2.1 PARCHI .................................................................................................................................................................... 6 2.2.2 AREE RAMSAR ........................................................................................................................................................ 9 2.2.3 RETE NATURA 2000 ............................................................................................................................................. -

Le Attività Dell'arpa Lazio
LE ATTIVITÀ DELL’ARPA LAZIO 2018 Attività Arpa 2018 NEW.qxp 03/04/20 16:24 Pagina 1 LE ATTIVITÀ DELL’ARPA LAZIO 2018 2019 Attività Arpa 2018 NEW.qxp 03/04/20 16:24 Pagina 2 Le attività dell’ARPA Lazio 2018 ARPA Lazio – 2019 Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia http://www.arpalazio.gov.it Coordinamento editoriale a cura dell’Area sistemi operativi e g estione della conoscenza Attività Arpa 2018 NEW.qxp 03/04/20 16:24 Pagina 3 INDICE INTRODUZIONE 05 LE ATTIVITÀ 2018 09 ARIA 13 ACQUA 25 Acque superficiali 25 Acque di transizione 53 Acque di balneazione 54 SUOLO 59 RIFIUTI 65 AGENTI FISICI 73 Elettromagnetismo 73 Rumore 75 Radioattività 81 STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR) 83 AZIENDE CON AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) 87 AZIENDE CON AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) 93 Attività Arpa 2018 NEW.qxp 03/04/20 16:24 Pagina 4 Attività Arpa 2018 NEW.qxp 03/04/20 16:24 Pagina 5 INTRODUZIONE La regione Lazio, ambito territoriale di intervento dell’Agenzia, è suddivisa in quattro province (o aree vaste) a loro volta ripartite in 378 Comuni, e in una città metropolitana e non presenta un’unità geografica definita, potendo piuttosto essere considerata un insieme di sub regioni appartenenti sia all’Appennino centrale sia all'Antiappennino tirrenico che alla fascia pianeggiante costiera. Questo aspetto condiziona la realtà economica e sociale e i connessi interessi rispetto alla tematica ambientale. Tra le cinque province del Lazio è compresa la città di Roma Capitale, elemento che da sempre ha accentuato la centralità della regione sul versante politico/amministrativo ed ha, inoltre, esercitato una forte funzione attrattiva per i flussi commerciali, demografici e dei capitali, ponendosi, nel contempo, al centro dell’attenzione come destinatario di una grande parte delle dotazioni e dei servizi nazionali. -

Assessorato All'ambiente E Sviluppo Sostenibile
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE PRESIDENTE Renata Polverini ASSESSORATO ALL’AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE Marco Mattei DIRETTORE REGIONALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO Luca Fegatelli COORDINAMENTO EDITORIALE Isabella Egidi, Simona Giangi, Ivana Pizzol, Roberta Grilli, Stefano Sarrocco TESTI Giulio Ielardi FOTOGRAFIE Giulio Ielardi. Archivio ARP – Andrea Bonito, Filippo Belisario, Roberta Grilli, Cristiano Fattori, Antonio Muscedere, Fabrizio Petrassi. CARTOGRAFIA Cristiano Fattori GRAFICA E IMPAGINAZIONE Chiara Trinchera STAMPA Art Color Printing © Copyright 2011, ARP Tutti i diritti riservati Questa pubblicazione è stata stampata su carta ecologica. Parco Naturale Regionale Monti Simbruini PARCO NATURALE REGIONALE MONTI SIMBRUINI estensione: 30.174 ettari province: Frosinone, Roma sede: via dei Prati, 5 00020 Jenne (RM) telefono: 0774827219 internet: www.parchilazio.it, www.parks.it il più grande del Lazio. Montagne vere, quelle alle spalle di Cervara, Subiaco e Filetti- no, e ricche di paesaggi integri, di fauna e flora, di arte e storia. A ottanta chilometri È da Roma, qui vivono l’aquila reale, il lupo, il picchio dorso bianco, il gatto selvatico, l’orso bruno marsicano. Ai confini con l’Abruzzo, il parco comprende diverse vette intorno ai duemila metri come il Viglio (2156 m), il Cotento (2014 m), il Tarino (1961 m). Ai piedi delle loro creste rocciose si estendono pianori spettacolari, come quello di Camposecco sopra Camerata Nuova, circondati da boschi soprattutto di faggio. A quote minori caratterizzano invece il paesaggio le forre e i boschi misti pedemontani. Questo è il parco dell’Appennino laziale, ma anche il parco dell’acqua. Il nome stesso del massiccio deriva dal latino sub imbribus, cioè "sotto le piogge".