Geologists and Speleology Between XIX and XX Century
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Relazione Di Patto Verso Il Contratto Di Fiume
Regione Lazio ARPINO BROCCOSTELLA CAMPOLI APPENNINO C ASTELLIRI FONTECHIARI ISOLA DEL LIRI POSTA FIBRENO PESCOSOLIDO SORA VICALVI FONTANA LIRI SANTOPADRE MONTE S. GIOVANNI CAMPAMO PROVINCIA di FROSINONE RELAZIONE DI PATTO "VERSO IL CONTRATTO Dl FlUME" PROCESSO Dl PIANIFICAZIONE PARTECIPATA PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BACINO FLUVIALE LIRI – LACERNO - FIBRENO. Nelle linee di indirizzo al Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.), è contenuto l’invito, a tutti i Comuni ricadenti nei vari sistemi urbanistici del territorio provinciale, ad individuare delle opere, di valenza intercomunale, da includere nei vari piani urbanistici comunali, ovvero a sviluppare un “progetto obiettivo” per lo sviluppo dell’ambito territoriale omogeneo. Nella conferenza dei sindaci del “Medio Bacino del Liri” è emersa l’opportunità, nel tracciare le linee del “progetto Obiettivo”, di promuovere un “Contratto di Fiume” su scala di Bacino Idrografico del Liri e suoi affluenti che coinvolga, attraverso una programmazione integrata, tutti i comuni localizzati sul tracciato fluviale fino alla diga Cerasoli di Fontana Liri. Una programmazione che deve mirare a rilanciare il sistema produttivo con scelte strategiche atte a superare i disegni che continuano ad isolare i territori dei comuni interessati dagli importanti circuiti virtuosi dell’economia. Se rivolgiamo lo sguardo nello scenario dello sviluppo storico della PROVINCIA, rileviamo purtroppo che determinate scelte politiche hanno allontanato quest’area interna dell’Appennino centrale dalle grandi direttrici di sviluppo e che le leggi che governano il territorio hanno imposto tanti vincoli riducendo sempre di più l’estensione territoriale da pianificare. Una analisi che deve essere alla base della programmazione urbanistica di un territorio in grave recessione socio economica. -

Comune Di Fiuggi
Perito Agrario Alessandro Alebardi Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma Tel. e Fax +39 06.6633418 COMUNE DI FIUGGI PROVINCIA DI FROSINONE VERIFICA DEMANIALE RIGUARDANTE LA RICOGNIZIONE E LA DELIMITAZIONE DELLE TERRE SOGGETTE AL REGIME GIURIDICO DEGLI USI CIVICI GESTITE DAL COMUNE DI FIUGGI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE RELAZIONE GENERALE Roma, 30 settembre 2017 IL PERITO DEMANIALE P.A. ALESSANDRO ALEBARDI 1 Perito Agrario Alessandro Alebardi Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma Tel. e Fax +39 06.6633418 Verifica Demaniale Riguardante l’accertamento e sistemazione delle terre soggette al particolare regime giuridico degli usi civici gestite dal Comune di Fiuggi all’interno dell’intero territorio comunale. 1. Panoramica del territorio di Fiuggi (FR), con vista sul centro abitato di Fiuggi. 2 Perito Agrario Alessandro Alebardi Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma Tel. e Fax +39 06.6633418 SOMMARIO: 1. Premessa, pag. 4 2. Identificazione dei terreni, pag. 7 3. Cenni storici, pag. 8 4. Dati generali e territorio, pag. 28 5. Regime giuridico degli usi civici, pag. 30 6. Linee guida della ricerca, pag. 50 7. Descrizione degli atti demaniali compiuti per il territorio comunale di Fiuggi, pag. 55 8. Individuazione delle terre ancora soggette agli “usi civici”, pag. 129 9. Operazioni demaniali da svolgere, pag. 151 2. Palazzo comunale di Fiuggi (FR). 3 Perito Agrario Alessandro Alebardi Via Francesco Azzurri, 16 – 00166 Roma Tel. e Fax +39 06.6633418 1 - PREMESSA La Regione Lazio con il Decreto del Presidente della Regione Lazio Renata Polverini n. T00229 del 18 giugno 2012 (Allegato “1”), nominava lo scrivente Perito Agrario Alessandro ALEBARDI, con studio a Roma in Via Francesco Azzurri n. -

Gran Fondo Madonna Del Campo (Vico Nel Lazio) 24 Agosto 2008
Gran Fondo Madonna del Campo (Vico nel Lazio) 24 Agosto 2008 Iniziamo con dei brevi cenni storici/geografici. Vico nel Lazio (FR) è situato su un colle calcareo a 721m s.l.m. sulla terra anticamente abitata dagli Ernici. Le loro origini sono avvolte nel mistero come quelle degli Etruschi. Il poeta Virgilio racconta che gli Ernici erano talmente bravi a lanciare frecce, che andavano in guerra con il piede sinistro nudo e il destro coperto da un calzare chiamato "pero". Al momento di lanciare le frecce miravano e colpivano con precisione i bersagli, portando avanti il piede destro e mantenendo il sinistro dietro. Vico nel Lazio Certosa di Trisulti Il percorso che si snoda tra i comuni di Vico Nel Lazio e Collepardo con un affascinante passaggio nella splendida Certosa di Trisulti, permette di godere in ogni momento dello splendido panorama di questo angolo di Ciociaria. Ma veniamo alle note tecniche. Subito dopo la partenza che avverrà dal Campo Sportivo di Vico nel Lazio alle ore 9,30 si transiterà all’interno del centro storico di Vico Nel Lazio imboccando Porta Maggiore e percorrendo le vie interne dello stesso fino a Porta Guarcino Porta Maggiore Porta Guarcino Da qui si esce dal centro storico per imboccare un sentiero sterrato in discesa (fate attenzione al fondo leggermente smosso). Dopo una veloce discesa, inizia una prima salita mediamente impegnativa di un km, che vi riscalderà al meglio per affrontare le due successive salite che sono anche le più impegnative del percorso per un totale di altri due km. Al termine dell’ultimo tratto di salita, troverete il PRIMO RISTORO posto in prossimità di un fontanile con acqua sorgente di montagna. -

La Natura Selvaggia Dei Monti Ernici, Tra Faggeti E Sentieri Incontaminati Nell’Oasi Naturale Di Prato Di Campoli
_t ÇtàâÜt I LAGHI ED I FIUMI IL LAGO DI CANTERNO Il lago di Canterno è situato ai piedi dei Monti Ernici, tra i comuni di Ferentino, Fiuggi, Fumone, Torre Cajetani e Trivigliano. Il territorio circostante vede la presenza di numerose formazioni boschive con querceti, boschi misti di latifoglie, conifere, oltre a salici e pioppi nel fondovalle. Il parco comprensivo del lago ha una superficie complessiva di circa 1.824 ettari, Il lago, di formazione carsica, è ricco di esemplari ittici, ma sono presenti anche trampolieri, aironi e gallinelle d’acqua. La vegetazione circostante rappresenta inoltre un habitat ideale per uccelli e piccoli mammiferi. IL LAGO DI CARDITO Il Lago Selva, nella frazione Cardito Vallerotonda, è un bacino artificiale a servizio delle centrali idroelettriche dell’Enel di Grotta Campanaro e di Cassino ed ha una capacità di 2 milioni di metri cubi di acqua. Il lago ed il paesaggio circostante risultano particolarmente congeniali alla pratica di attività sportive, come la pesca, la canoa, il volo con parapendio, lo sport della mountain bike. Da alcuni anni è in atto u n progetto di valorizzazione ambientale con la realizzazione di strutture di accoglienza per incentivare nella zona l’afflusso dei visitatori. LAGO DI S. GIOVANNI INCARICO La Riserva Naturale, in cui è situato il Lago di S. Giovanni Incarico, Arce, Ceprano e Falvaterra, nella Valle del Liri. Ha una superficie di 725 ettari ed è stata istituita nel 1999. Il territorio comprende anche le aree archeologiche di Fregellae e Fabrateria, e ciò conferisce a questo luogo anche un richiamo di spessore culturale oltre che squisitamente naturalistico. -
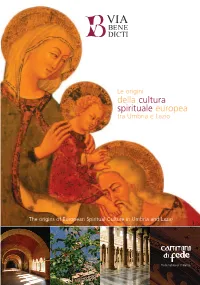
1337 Layout Brochure
Le origini della cultura spirituale europea tra Umbria e Lazio The origins of European Spiritual Culture in Umbria and Lazio Tra la natura e l’immenso. La Via Benedicti, insieme all’itinerario The Benedictine Way is part of the Da Norcia a Cassino, passando per la Sabina francescano con cui a tratti s’incrocia, Routes of Faith project, along with the e Roma, 10 tappe che fa parte del progetto Cammini di Fede Franciscan itinerary that crosses its path mostrano altrettante espressioni dell’universo che, dopo il notevole successo del from time to time. Following the notable benedettino. Cammino di Francesco tracciato success of the St. Francis Walk, a tourist inizialmente dall’APT Rieti sul proprio trail designed for the Rieti region by the local From Norcia to Cassino, territorio, oggi coinvolge sinergicamente tourist board, the project now actively involves through the Sabine region and on to Rome; le regioni Lazio e Umbria in un’unica the regions of Umbria and Lazio in providing 10 places to introduce visitors to the Benedictine proposta spirituale, turistica e culturale, a unique spiritual and cultural experience for way of life. partendo da due figure fondamentali visiting tourists, based around the lives of two per lo sviluppo del cristianesimo. men who were fundamental to the development of Christianity. San Benedetto, con il suo messaggio The message of St. Benedict was spread through veicolato dalle tante comunità the many Benedictine communities established benedettine diffuse ovunque a partire far and wide from the VI Century onwards. dal VI secolo, ha guidato il “vecchio He had helped the “old world” through one continente” lungo uno dei periodi più of the most difficult periods in its history, difficili della sua storia, tanto da earning himself in the process the title of meritarsi il titolo di Santo Patrono Patron Saint of Europe (Pacis Nuntius - d’Europa (Pacis Nuntius - Paolo VI, Paul VI, 24th October 1964). -

Richiesta Servizio Di Assistenza Domiciliare
DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE “ A” (PROVINCIA DI FROSINONE) L. 328/2000 Comuni di: Acuto, Alatri , Anagni, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone,Sgurgola, Torre Cajetani,Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio. Azienda Sanitaria Locale, Terzo Settore, Provincia di Frosinone Piazza Caduti di Nassiriya snc - 03011 ALATRI (FR) Ufficio di Piano: Tel. 0775.4478210/11 - Fax: 0775.4478209 Comune Capofila Servizio Sociale Distrettuale: Tel. 0775.4478213 Alatri Coordinamento Distrettuale Terzo Settore: Tel 0775.889054 e-mail: [email protected] sito internet: www.distrettosocioassistenziale.it Distretto Socio Assistenziale A Alla c.a. del Signor Sindaco Comune di …………………………… Richiesta Servizio di Assistenza Domiciliare IL SOTTOSCRITT.. …………………………………………………………….NATO A …………………………….. IL……………….. RESIDENTE……………………………….IN VIA………………………………………………N……….TEL…………………… CHIEDE DI usufruire del servizio di assistenza domiciliare, per le seguenti prestazioni: ……………………………………………………………………………………………………………………………… OVVERO CHIEDE CHE IL/LA SIG………. ……………………………………………….NATO A ………………….RESIDENTE A……………….. IN VIA…………………………………N……….TEL…………………… tel_____________possa usufruire del servizio di assistenza domiciliare, per le seguenti prestazioni: ……………………………………………………………………………………………………………………………… A CORREDO DELLA PRESENTE SI ALLEGANO: 1. AUTOCERTIFICAZIONE (MODELLO A) 2. EVENTUALE VERBALE DI INVALIDITA’ CIVILE 3 .DICHIARAZIONE ISEE 4 .DICHIARAZIONE DI CONSENSO ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Data _______________ Firma per esteso e leggibile -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2017
Ufficio del territorio di FROSINONE Data: 14/11/2017 Ora: 10.30.11 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.6 del 22/02/2017 n.42 del 25/05/2017 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA N. 1 REGIONE AGRARIA N. 2 Comuni di: ACUTO, ALATRI, FIUGGI, COLLEPARDO, FILETTINO, Comuni di: ALVITO, CAMPOLI APPENNINO, GALLINARO, FUMONE, GUARCINO, PIGLIO, SERRONE, TORRE CAJETANI, TREVI PESCOSOLIDO, S DONATO VAL DI COMINO, SETTEFRATI, SORA NEL LAZIO, TRIVIGLIANO, VEROLI, VICO NEL LAZIO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 2700,00 2800,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 4300,00 4000,00 BOSCO MISTO 2200,00 4500,00 CANNETO 14100,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 8000,00 FRUTTETO 15300,00 INCOLTO PROMISCUO 1800,00 ORTO 19400,00 ORTO IRRIGUO 27100,00 PASCOLO 2200,00 2200,00 PASCOLO ARBORATO 2300,00 2300,00 PASCOLO CESPUGLIATO 1700,00 2200,00 PRATO 7600,00 10500,00 PRATO ARBORATO 8800,00 Pagina: 1 di 10 Ufficio del territorio di FROSINONE Data: 14/11/2017 Ora: 10.30.11 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.6 del 22/02/2017 n.42 del 25/05/2017 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA N. 1 REGIONE AGRARIA N. 2 Comuni di: ACUTO, ALATRI, FIUGGI, COLLEPARDO, FILETTINO, Comuni di: ALVITO, CAMPOLI APPENNINO, GALLINARO, FUMONE, GUARCINO, PIGLIO, SERRONE, TORRE CAJETANI, TREVI PESCOSOLIDO, S DONATO VAL DI COMINO, SETTEFRATI, SORA NEL LAZIO, TRIVIGLIANO, VEROLI, VICO NEL LAZIO COLTURA Valore Sup. -

Piano Comunale Di Protezione Civile
Comune di Trivigliano PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 1 Lista di distribuzione N° Soggetto Formato 1 Regione Lazio, Agenzia Protezione Civile Cartaceo/PDF/Gis files 2 Prefettura di Frosinone Cartaceo/PDF/Gis files 3 Provincia di Frosinone Cartaceo/PDF/Gis files 4 Comando provinciale Vigili del Fuoco Cartaceo/PDF/Gis files 5 Corpo Forestale dello Stato Cartaceo/PDF/Gis files 6 Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno Cartaceo/PDF/Gis files 7 XII Comunità Montana Monti Ernici Cartaceo/PDF/Gis files N° Revisione Data e Timbro Descrizione 00 Prima emissione ed Adozione AUTORI Andrea Morinelli, Manager dell’Emergenza, Geologo In collaborazione con: Geom. Fabio Avoli Geom. Marco Pietrogiacomi Comune di Trivigliano 2 INDICE Premessa 1. Inquadramento territoriale 2. Elaborazione Scenario di Rischio locale 3. Condizione Limite per l’Emergenza 4. Organizzazione del Sistema Comunale di Protezione Civile 5. Risorse per la gestione dell’emergenza 6. Procedure operative 7. Formazione, informazione, addestramento Cartografia: • tav.1 Carta di Inquadramento Territoriale • tav.2 Carta delle Aree di Emergenza e degli Edifici Strategici • tav.3 Carta dello Scenario di Rischio Idrogeologico e Geologico • tav.4 Carta dello Scenario di Rischio Sismico • tav.4b Carta delle Condizioni Limite dell’Emergenza • tav.5 Carta dello Scenario di Rischio Incendio e Incendio di interfaccia Allegati: • Glossario • Schemi di ordinanze • Scheda Rilievo Centro Operativo Comunale • Schede Rilievo Aree accoglienza e ricovero • Analisi CLE • Convenzioni attivate 3 PREMESSA Il seguente Piano Comunale di Protezione Civile è stato redatto in base alle normative in vigore (più avanti indicate) con la logica fondamentale della semplificazione, al fine di renderlo facilmente utilizzabile da tecnici del settore, nonché sintetizzabile per la divulgazione ai non addetti ai lavori (volontari, cittadini ecc.) anche per facilitare la partecipazione e la consapevolezza di questi ultimi all’importanza della tutela e prevenzione nel proprio territorio. -

Le Città Fortificate E I Monti Ernici Fortified Towns and the Ernici Mountains
LE CITTÀ FORTIFICATE E I MONTI ERNICI FORTIFIED TOWNS AND THE ERNICI MOUNTAINS LUNGO IL LIRI ED IL FIBRENO NELLA TERRA DI CICERONE ALONG THE LIRI AND FIBRENO: IN THE LAND OF CICERO CIOCIARIA ARCHEOLOGICA E SOTTERRANEA ARCHAEOLOGICAL AND UNDERGROUND CIOCIARIA LA VALLE DEL SACCO E DELL’AMASENO THE SACCO AND THE AMASENO VALLEYS LE CITTÀ FORTIFICATE E I MONTI ERNICI Tra le cime verdeggianti dei monti Ernici sorgono antichi borghi fortificati, testimonianze preziose del cammino della cristianità nel cuore dell’Italia antica Nel cuore d’Italia, nel meridione del Lazio, dove in origine furono gli Ernici, il misterioso popolo italico, si nascondono tesori incantevoli, cittadine antiche dove il segno della storia parla di Roma e del Papa Re, dove la natura incorrotta e sublime fa da corte ideale alle bellezze nate dal genio degli antichi. Questa è la Ciociaria storica, crocevia di popoli, di santi e di eserciti che fin dall’antichità transitavano per queste montagne, i Monti Ernici appunto. La zona che fu assai impervia, è fitta di alte colline ricche di boschi secolari e di borghi ‘ciclopici’ dove nacquero grandi personalità di Roma antica e quattro tra i Papi più celebri dell’età medievale e del Rinascimento. Oggi quel carattere ‘imper- vio’ non è più tale, ma certo ha permesso che gli aspetti più rigogliosi e splendidi di questa natura siano giunti a noi quasi vergini. Stessa sorte è toccata alle cittadine sorte tra questi colli: i tratti della storia sono ancora lì, ben visibili, attentamente conservati e recuperati al vivere contemporaneo. Su e giù tra boschi e colline si può tracciare un idea- le percorso, un fazzoletto di verde, vagamente rettangolare ai cui margini si adagiano la bella Alatri, l’erudita Veroli, l’inespugnabile Ferentino e la ricca Anagni. -

Comune Di Ausonia PEC: [email protected]
Investimenti, Ingegneria della Manutenzione, ACEA ATO5 In Partenza Prot. n. 0373401/20 del 23/12/2020 PROTOCOLLOPatrimonio ATO5 e Progettazione ACEA ATO 5 S.p.A. Comune di Ausonia PEC: [email protected] Comune di Castelnuovo Parano PEC: [email protected] Comune di Colle San Magno PEC: [email protected] Comune di Esperia PEC: [email protected] Comune di Ferentino PEC: [email protected] Comune di Fontechiari PEC: [email protected] Comune di Isola del Liri PEC: [email protected] Comune di Piedimonte San Germano PEC: [email protected] Comune di Pignataro Interamna PEC: [email protected] Comune di Pofi PEC: [email protected] Comune di Pontecorvo PEC: [email protected] Comune di Roccasecca PEC: [email protected] Comune di Sant’Ambrogio Sul Garigliano PEC: [email protected] Comune di Sant’Elia Fiume Rapido PEC: [email protected] Acea Ato 5 SpA – Viale Roma, snc, 03100 - Frosinone / T 0775 883 100 Cap.Soc. Euro 10.330.000,00 iv CF, P.IVA 02267050603 CCIAA FR REA 140926 http://www.gruppo.acea.it Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis Acea SpA - CF 05394801004 Investimenti, Ingegneria della Manutenzione, Patrimonio e Progettazione ACEA ATO 5 S.p.A. Comune di Veroli PEC: [email protected] Oggetto: Accordo quadro avente ad oggetto i lavori di bonifica delle reti idriche del servizio idrico integrato Acea Ato5 S.p.A. GARA n. 8800001283/EMA - Lotto 2 CIG 7423624851 Comunicazione avviso ai creditori Luogo di esecuzione: Comune Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campodimele, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle S. -

Curriculum Vitae
Geom. Ercolani Fernando CURRICULUM VITAE Geom. Ercolani Fernando FERNANDO ERCOLANI nato a Villa S. Stefano il 03.01.1959, ed ivi residente in Via XI^ Settembre, n. 6 – Tel 0775/632405 – Cell. 347/1219979 C.F. RCL FNN 59°03 I364I TITOLI CULTURALI Diploma Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Francesco Severi - Frosinone A.S. 1979-80; Nell’anno 1983 consegue il diploma riconosciuto dalla Regione Lazio di dattilografia con la votazione finale di 29/30; Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Statale Filippo Brunelleschi - Frosinone - A.S. 1990-91. LAVORO Il 31.12.1986 a seguito di concorso viene assunto dal Comune di Villa S. Stefano con le mansioni di applicato – 4^ Livello. Il 20.10.1998, risulta vincitore di concorso per n. 1 posto di Istruttore Tecnico – 6 q.f; In data 20.10.1998 ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro per vincitore di concorso interno di istruttore tecnico VI q.f.; In data 30.06.2003 risulta vincitore di concorso per n. 1 posto di Istruttore tecnico direttivo – Cat. D1; Dal 21.10.1998 ad oggi, viene individuato e nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Villa S. Stefano – P.O.; A far data 01.08.2001, a seguito di convenzione stipulata tra i comuni di Collepardo e Villa S. Stefano, viene nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Collepardo– P.O.; A far data 01.11.2006, a seguito di convenzione stipulata tra i comuni di Villa S. Stefano e la XXI^ Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni e Valliva di Villa S. -

La Grotta Regina Margherita Di Collepardo: “Museo Italico Della Natura”
150 anni di Preistoria e Protostoria in Italia MICAELA ANGLE* - FABIO CATRACCHIA** - DANIELA MANCINI*** La Grotta Regina Margherita di Collepardo: “Museo Italico della Natura” RIASSUNTO - LA GROTTA REGINA MARGHERITA DI COLLEPARDO: “MUSEO ITALICO DELLA NATURA” - Definita nel 1855 da F. Gori “Museo Italico della Natura”, la Grotta Regina Margherita di Collepardo è stata da sempre meta di visitatori, naturalisti, geologi e personaggi illustri del tempo che ne hanno decantato le bellezze, incrementandone la notorietà. Il primo approccio scientifico alla grotta si ebbe nel 1852-53 quando G. Ponzi studiò le brecce ossifere recuperando fauna pleistocenica. Nella seconda metà del ‘900 le indagini di A. G. Segre (1948), I. Biddittu (1976- 77) e, soprattutto, di A. Guidi (1981) permisero di rinvenire reperti ceramici, faunistici ed osteologici risalenti alle fasi iniziali del Bronzo medio ed a sporadiche occupazioni di epoche storiche successive. Nel 2008 sono stati effettuati scavi stratigrafici che hanno attestato un uso prevalentemente funerario e frequentazioni da collegare probabilmente ad attività rituali connesse al culto dei defunti nel Bronzo medio iniziale. SUMMARY - THE REGINA MARGHERITA CAVE OF COLLEPARDO: “MUSEO ITALICO DELLA NATURA” - In 1855 the Re- gina Margherita cave of Collepardo was described by F.Gori as “Museo Italico della Natura”. The cave has always been a desirable destination for visitors, naturalists, geologists and celebrities, who praised its notoriety. In 1852- 53 there was the first scientific project carried out on the cave. In this occasion G. Ponzi studied the fossil breccias, finding out pleistocenic fauna. During the second half of XX century A. G. Segre (1948), I. Biddittu (1976-77) and, mostly, A.