Il Binomio Giuliano-Scelba Un Mistero Della Repubblica?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guerilla Warfare a Sicilian Bandit
RIGHT An American Marine medic administers plasma to a wounded soldier behind the front line in the streets of San Agata, during the Allied invasion of Sicily. Guerilla Warfare With a small but extremely tough volunteer army, the movement for independence in Sicily—which represented a variation on the old and unattainable Mafi a dream of becoming a state—began its armed struggle in the autumn of 1944, partly as a reaction to the continual and arbitrary attacks carried out by the police forces against its offi ces and supporters. Their attempt to bring about a separatist insurrection gave rise to vehement resistance, leading to guerilla warfare. The Italian government was forced to send the army to Sicily to support the police and Carabinieri and to put down the revolt. On June 17, 1945, the commander and founder of the separatist army, Antonio Canepa, was killed in a gunfi ght with the Carabinieri. His death pro- voked many well-founded suspicions that the Mafi a was directly responsible. Given their antipathy to words such as “socialism” and “revolution,” they were no doubt keen to rid themselves of such a subversive combatant. A Sicilian Bandit Concetto Gallo became the new head of the separatist army and then entered into an alliance with the bandits hoping to achieve victory for the revolt. He proposed that the most famous and wanted bandit in all of Sicily, Salvatore Giuliano, should join the volunteer army for the movement for Sicilian independence. Giuliano accepted, and he and his band carried out a series of attacks on the police and Carabinieri as well as on the troops sent by Rome to halt the progress of the rebel- lion. -

Università Degli Studi Di Catania Catania E I Sindaci
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE TESI DI DOTTORATO DI RICERCA IN PENSIERO POLITICO E ISTITUZIONI NELLE SOCIETÀ MEDITERRANEE XXIV CICLO CARMELO LA ROCCA CATANIA E I SINDACI DEL SECONDO DOPOGUERRA PERCORSI POLITICI E AMMINISTRATIVI COORDINATORE E TUTOR CH.MO PROF . GIUSEPPE ASTUTO 0 INDICE INTRODUZIONE 1 Le Istituzioni e la politica 3 2 La ricerca e le fonti 11 1° CAPITOLO La fine della guerra 1.1 Lo sbarco degli alleati 16 1.2 Si ricomincia… 20 1.3 La rinascita dei partiti 25 1.4 Catania e le aspirazioni separatistiche del MIS 33 2° CAPITOLO Dal Podestà al Sindaco 2.1 Dal Sindaco dell’età liberale al Podestà 40 2.2 Gli ultimi Podestà di Catania 42 2.3 …il Sindaco 47 3° CAPITOLO Le elezioni del 1946 3.1 Si vota! 61 3.2 Le “amministrative” a Catania 68 3.3 Il nuovo Consiglio comunale 73 3.4 Le 136 preferenze di Pittari 76 3.5 Un monarchico liberale 82 3.6 La D.C. resta ancora a guardare 85 4° CAPITOLO Magrì e La Ferlita 4.1 La Democrazia Cristiana 90 4.2 Le elezioni del 25 maggio 1952 93 4.3 “La politica per Catania… 97 4.4 Un Sindaco per sette anni 104 4.5 La Ferlita… lascia 111 1 5° CAPITOLO Da Papale a Nino Drago 5.1 Novembre 1960 116 5.2 Il Piano Regolatore Generale 125 5.3 Lo scandalo edilizio 128 5.4 La sindacatura Drago 132 6° CAPITOLO I Sindaci di Drago 6.1 Giuseppe Gulli 140 6.2 Il Pigno ha sete 145 6.3 Tra politica e sport: Marcoccio 153 6.4 Le elezioni del 15 giugno 1975 160 6.5 Le nuove giunte Magrì 166 6.6 Le ultime amministrazioni Magrì 173 6.7 Salvatore Coco 176 6.8 Angelo Munzone 182 7° CAPITOLO Bianco… per caso 7.1 Il professore Mirone 187 7.2 Si scioglie il Consiglio 190 7.3 Bianco… per caso 195 7.4 Ritorna la D.C., ma… 200 7.5 Direttamente Bianco 204 Conclusioni 208 Bibliografia 214 2 INTRODUZIONE 1. -

Piersanti Mattarella
Piersanti Mattarella Piersanti Mattarella nacque a Castellammare del Golfo il 24 maggio 1935. Secondogenito di Bernardo Mattarella, uomo politico della Democrazia Cristiana e fratello di Sergio, 12° Presidente della Repubblica Italiana. Piersanti si trasferì a Roma con la famiglia nel 1948. Studiò al San Leone Magno, retto dai Fratelli maristi, e militò nell’Azione cattolica mostrandosi battagliero sostenitore della dottrina sociale della Chiesa che si andava affermando. Si laureò a pieni voti in Giurisprudenza alla Sapienza con una tesi in economia politica, sui problemi dell’integrazione economica europea. Tornò in Sicilia nel 1958 per sposarsi. Divenne assistente ordinario di diritto privato all'Università di Palermo. Ebbe due figli: Bernardo e Maria. Entrò nella Dc tra il 1962 e il 1963 e nel novembre del 1964 si candidò nella relativa lista alle elezioni comunali di Palermo ottenendo più di undicimila preferenze, divenendo consigliere comunale nel pieno dello scandalo del “Sacco di Palermo”. Erano, infatti, gli anni della crisi della Dc in Sicilia, c’era una spaccatura, si stavano affermando Lima e Ciancimino e si preparava il tempo in cui una colata di cemento avrebbe spazzato via le ville liberty di Palermo. Nel 1967 entrò nell’Assemblea Regionale. In politica adottò uno stile tutto suo: parlò di trasparenza, proponendo di ridurre gli incarichi (taglio degli assessorati da dodici ad otto e delle commissioni legislative da sette a cinque e per l'ufficio di presidenza la nomina di soli due vice, un segretario ed un questore) e battendosi per la rotazione delle persone nei centri di potere con dei limiti temporali, in modo da evitare il radicarsi di consorterie pericolose. -

20Th Century Communism 16.Indd
The University of Manchester Research Book Review: Second World, Second Sex. Socialist Women’s Activism and Global Solidarity during the Cold War Document Version Final published version Link to publication record in Manchester Research Explorer Citation for published version (APA): Müller, T. R. (2019). Book Review: Second World, Second Sex. Socialist Women’s Activism and Global Solidarity during the Cold War. Twentieth Century Communism, (16), 150-154. Published in: Twentieth Century Communism Citing this paper Please note that where the full-text provided on Manchester Research Explorer is the Author Accepted Manuscript or Proof version this may differ from the final Published version. If citing, it is advised that you check and use the publisher's definitive version. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the Research Explorer are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Takedown policy If you believe that this document breaches copyright please refer to the University of Manchester’s Takedown Procedures [http://man.ac.uk/04Y6Bo] or contact [email protected] providing relevant details, so we can investigate your claim. Download date:02. Oct. 2021 The Communist Party of Cyprus, the Comintern and the uprising of 1931 125 Reviews Richard J Evans; Eric Hobsbawm: a Life in History (London: Little, Brown; 2019), 1408707411, 785pp Biographical advantages This is truly a monumental biography, well deserving of its subject. At nearly 800 pages, eight-one of them endnotes, it is not likely to be superseded anytime in the near future. -

Ragione Sociale Nome Dell'esercizio Partita IVA Sigla Denominazione Comune Denominazione Strada Civico CAP Regione Tip Chiusura Note AL.CA
Ragione sociale Nome dell'esercizio Partita IVA Sigla Denominazione Comune Denominazione Strada Civico CAP Regione Tip chiusura Note AL.CA. SRL R7 SUPERMERCATI CITY 02667500843 AG AGRIGENTO VIALE LEONARDO SCIASCIA 100 92100 SICILIA G MAI ALCA SRL FORUM BAR 02576870840 AG AGRIGENTO VIA GIUSEPPE MAZZINI 140 92100 SICILIA E DOMENICA ATENEA SNC DI RAGUCCIA SALVATORE & C. CAFE ATENEA BAR 02507540843 AG AGRIGENTO VIA ATENEA 301 92100 SICILIA F DOMENICA BAMBU' GERLANDA CASH AND CARRY DALLI CARDILLO GASTRONOMIA 01912040845 AG AGRIGENTO VIA PIERSANTI MATTARELLA 263 92100 SICILIA G MERCOLEDI' CAFFE' DEI FIORI 2 SRL CAFFE' DEI FIORI BAR 2 01912220843 AG AGRIGENTO CONTRADA CONSOLIDA SNC 92100 SICILIA F MAI C/O OSPEDALE SAN GIOVANNI COSTA GIUSEPPE COSTA BAR 01581350848 AG AGRIGENTO VIA DANTE ALIGHIERI 3 92100 SICILIA F DOMENICA CUCCHIARA FABIO ZANZI ... BAR 02512070844 AG AGRIGENTO VIA PIERSANTI MATTARELLA 345 92100 SICILIA F DOMENICA DALLI CARDILLO GIUSEPPE SAS BAR LA VELA 02311400846 AG AGRIGENTO PIAZZA ASTER 2 92100 SICILIA F MAI LOCALITA SAN LEONE DANILE ERNESTO BABY LUNA BAR 02297920841 AG AGRIGENTO VIA ALESSANDRO MANZONI 215 92100 SICILIA F MAI DET.AL DI MACALUSO MICHELINA SAS DI MEGLIO MARKET 01911330841 AG AGRIGENTO VIALE EMPORIUM 90 92100 SICILIA G MERCOLEDI' DI NOLFO GIOVANNI CHEZ JEAN 2 RISTORANTE PIZZERIA 02046980849 AG AGRIGENTO VIA CICERONE 23 92100 SICILIA E LUNEDI' DIVINAE SNC DI FERLISI E SODANO DIVINAE OPERA RISTORANTE PIZZERIA 02596100848 AG AGRIGENTO VIA ATENEA 239/241 92100 SICILIA E LUNEDI' F.LLI CAPOSTAGNO SAS DI CAPOSTAGNO MASSIMILIANO & C. CONAD 01906930845 AG AGRIGENTO VIALE DEI GIARDINI 52 92100 SICILIA G DOMENICA F.LLI NANTELE S. -

Who Was Partisan Canepa?
GLORY TO OUR COMRADE ANTONIO CANEPA and to the partisans of the Volunteer Army for the Independence of Sicily! NO to the hypocritical tricoloured Liberation Day and to the tainted May Day celebrations! World War II (1939-1945). After the facts were cleaned out by the ideologies, our very own Memory was "purified", what is left of the second WORLD WAR is a lethal confrontation between competing Powers, which turned into the division of the World in two parts, of a divided Europe, a divided Germany, a divided Berlin. And in the long-lasting withdrawal of the old colonialist European Empires, that had "won" the war, triggering India's independence, and most of all the foundation of Mao's People's Republic of China. In July 1943 - with Operation Husky - the "Allies" (supported by an efficient Resistance against Nazi- fascism) occupy Sicily. It was the beginning of the end of a Regime, but, as we will see, it was not what the Sicilian Partisans had fought for. The 24th October 1943, beyond the temporary AMGOT (Allied Military Government for Occupied Territories), was also the birthdate of Washington's "SICILY REGION 1" in the Mediterranean, which remains like an "unsaid" under this sky that is populated by foreign planes, assassin drones, dysfunctional saints and a G7 on a tourist trip. This Sicily is a fought-over island, played like a geopolitical card by Rome, the real mafia capital, and its strategic relation with the AmeriKan friend. A treasure island reduced to Europe's poorhouse, with its habitants being forced to emigrate. -

Riflessioni Sull™Enigmatica Strage Di Portella Delle
www.laltrasicilia.org RIFLESSIONI SULL’ENIGMATICA STRAGE DI PORTELLA DELLE GINESTRE Dott. Salvatore Riggio Scaduto Nel giugno del 1987 a Montelepre veniva pubblicato dalla casa editrice “La Rivalsa” un corposo libro di 342 pagine, avente inoltre un’appendice fotografica e documentale, intitolato “MIO FRATELLO SALVATORE GIULIANO” degli autori Marianna Giuliano e Giuseppe Sciortino Giuliano, rispettivamente sorella e nipote di Salvatore Giuliano. Dall’introduzione firmata solo dal secondo autore, figlio di Marianna Giuliano, apprendiamo, però, che il libro è stato scritto soltanto da questo, tanto è vero che a pag. 8 si legge che “Il merito maggiore va a mia madre....La sorella di Turiddu, che con lui condivise gli ideali e che lo affiancò nella lotta sia armata che politica. Senza di lei... Forse non sarei mai riuscito nel mio compito”. Il detto libro ha chiaramente e certamente finalità apologetiche e giustificative del personaggio che per circa sette anni tenne a scacco nell’immediato dopoguerra le forze dello Stato Italiano, ma è altrettanto certo che la sorella di Turiddu Giuliano, Marianna, coniugata con Pasquale Sciortino, fu la confidente prediletta del fratello e quindi la depositaria di tantissimi segreti. Uno storico attento e scrupoloso non può liquidare sic et simpliciter i fatti riportati nel detto libro come non veritieri perché di parte, ma deve saper sottoporre a vaglio critico tali fatti con le risultanze di altre fonti. Volendo anch’io strizzare qualche gocciolina della mia penna nel fiume impetuoso d’inchiostro versato sull’oscura strage di Portella delle Ginestre del 1° Maggio 1947, mi cimenterò con il presente scritto a fare alcune considerazioni tenendo anche presente “la verità” ammanitaci in proposito del detto libro da pag. -

Banca Del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.P.A
Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. Inaugural Social Bond Executive Summary • Strategic Government-linked entity promoting investments in the South of Italy • Unique business model focused on development support • Strong financials within the Italian banking system • Rated Ba1 by Moody’s / BBB- by S&P • Inaugural Social Bond Transaction 2 Content 1 MedioCredito Centrale ("MCC") Overview 2 Financial Overview 3 Social Framework 4 Transaction Overview MCC Overview Group Profile and Mission MCC at a Glance MedioCredito Centrale S.p.A.: a Bank 100% owned by Italian State through Invitalia MCC Evolution and Overview Board of Directors • Established in 1952 as a public entity, its mission was Chairman Massimiliano CESARE focused on delivering public finance and supporting the expansion of Italian companies overseas. In 2011, following CEO Bernardo MATTARELLA the MEF developing program for the southern Italy, its corporate name was changed to Banca del Mezzogiorno- Directors Pasquale AMBROGIO MedioCredito Centrale Gabriella FORTE • Since August 2017 the Bank has been owned by Invitalia Leonarda SANSONE S.p.A. (formerly Sviluppo Italia S.p.A.) and regulated by the Bank of Italy with a full banking licence • No branch network (Banca di II Livello), MCC operates under Shareholding Structure cooperation agreements with the main Italian banking groups • Total employees as of 31/12/2018, 283: 14 managers, 163 senior officers and 106 employees (and 9 trainees) Board of Statutory Auditors Chairman Paolo PALOMBELLI Standing Auditors Carlo FEROCINO 100% Marcella GALVANI 100% Alternative Auditors Roberto MICOLITTI Sofia PATERNOSTRO 5 Key Stages of MCC’s Development A more than 60 years long history of success, with focus on South of Italy SMEs development since 2011 1952 1994 1999 2007 2011 2017 TODAY Poste Italiane acquires 100% of Law no. -

Società E Cultura 65
Società e Cultura Collana promossa dalla Fondazione di studi storici “Filippo Turati” diretta da Maurizio Degl’Innocenti 65 1 Manica.indd 1 19-11-2010 12:16:48 2 Manica.indd 2 19-11-2010 12:16:48 Giustina Manica 3 Manica.indd 3 19-11-2010 12:16:53 Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo di fondi di ricerca del Dipartimento di studi sullo stato dell’Università de- gli Studi di Firenze. © Piero Lacaita Editore - Manduria-Bari-Roma - 2010 Sede legale: Manduria - Vico degli Albanesi, 4 - Tel.-Fax 099/9711124 www.lacaita.com - [email protected] 4 Manica.indd 4 19-11-2010 12:16:54 La mafia non è affatto invincibile; è un fatto uma- no e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fe- nomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze mi- gliori delle istituzioni. Giovanni Falcone La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un mo- vimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità… Paolo Borsellino 5 Manica.indd 5 19-11-2010 12:16:54 6 Manica.indd 6 19-11-2010 12:16:54 Alla mia famiglia 7 Manica.indd 7 19-11-2010 12:16:54 Leggenda Archivio centrale dello stato: Acs Archivio di stato di Palermo: Asp Public record office, Foreign office: Pro, Fo Gabinetto prefettura: Gab. -
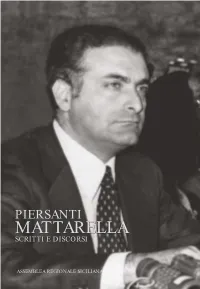
Piersanti Mattarella Scritti E Discorsi
PIERSANTI MATTARELLA SCRITTI E DISCORSI ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PIERSANTI MATTARELLA nato a Castellammare del Golfo (Tp) il 24 maggio 1935, assassinato a Palermo il 6 gennaio 1980, gior- no dell’Epifania. Ha ricoperto importanti incarichi diocesani, regiona- li e nazionali nella gioventù di azione cattolica, della cui presidenza ha fatto parte per cinque anni. Consigliere comunale di Palermo dal 1964 al 1967. Componente della direzione regionale, del Consiglio nazionale e della direzione centrale della Democrazia cristiana. Deputato regionale eletto per la D.C. nel collegio di Palermo nella sesta (11 giugno 1967), settima (13 giugno 1971) e ottava legislatura (20 giugno 1976). Nella sesta legislatura è stato componente delle Commissioni legislative permanenti per gli affari interni e per la pubblica istruzione, della giunta di bilancio, della Commissione per il regolamento interno, della Commissione speciale per la riforma burocratica e della Commissione speciale per la rifor- ma urbanistica. Nella settima legislatura ha ricoperto ininterrotta- mente la carica di Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio, carica nella quale è stato riconfermato nel primo governo della ottava legislatura. Dal 16 marzo 1978 era Presidente della Regione. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA XIII LEGISLATURA SCRITTI E DISCORSI di PIERSANTI MATTARELLA VOLUME SECONDO 2 QUADERNI DEL SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL’A.R.S. – NUOVA SERIE – SCRITTI E DISCORSI DI PIERSANTI MATTARELLA Introduzione di LEOPOLDO ELIA VOLUME SECONDO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA Il ruolo delle regioni meridionali per una nuova politica economica dello Stato (*) Palermo, 31 gennaio 1971 Il problema principale da affrontare e risolvere al fine di pervenire ad una nuova politica meridionalistica è eminentemente quello politico della creazione di una forza di pressione nel Sud capace di controbilanciare le spinte e le sollecitazioni che sull’apparato politico-buro- cratico riesce ad esercitare la struttura socio-finanziaria del Nord. -

CATTOLICI, CHIESA E MAFIA Aspetti Storici, Politici E Religiosi Convegno Di Studi (Università Di Messina, 27-29 Novembre 2003)
CATTOLICI, CHIESA E MAFIA Aspetti storici, politici e religiosi Convegno di Studi (Università di Messina, 27-29 novembre 2003) Giovedì 27 novembre (Aula Magna dell’Università), ore 9:30 Inaugurazione del Convegno Gaetano Silvestri (Magnifico Rettore) Saluti introduttivi S.E. Mons. Giovanni Marra (Arcivescovo di Messina) Francesco Malgeri, (Istituto “Luigi Sturzo”, Roma) Presiede: Guido Pescosolido (Preside Facoltà di Lettere, Università “La Sapienza”, Roma) Angelo Sindoni (Università di Messina) Cattolici e mafia nella storia d’Italia: una questione aperta. Salvatore Cusimano (giornalista RAI, TV, caporedattore, Palermo), Il fenomeno mafioso nella rappresentazione dei mass media. Francesco M. Stabile (Facoltà Teologica, Palermo), Percezione del fenomeno mafioso nell’episcopato siciliano (1948-1970). Berardino Palumbo (Università di Messina), Subcultura mafiosa, religiosità e vita quotidiana nei piccoli centri. S.E. Mons. Michele Pennisi (Vescovo di Piazza Armerina), Pastoralità, ecclesialità e contrasto alla mafia. Giovedì 27 novembre, ore 15:30 Presiede: Agostino Giovagnoli (Università Cattolica, Milano) Francesco Malgeri (Università “La Sapienza”, Roma), Scelba ministro dell’Interno e il fenomeno mafioso. Luigi Masella (Università di Bari), Girolamo Li Causi, Il PCI, la DC e l’analisi della questione mafia. Giovanni Bolignani (Università di Messina), Bernardo Mattarella. Salvatore Butera (Presidente Fondazione Banco di Sicilia, Palermo), Piersanti Mattarella. Angelo Romano (Pontificia Università Urbaniana, Roma), Don Pino Puglisi. Ida Abate (Agrigento), Il giudice Rosario Livatino. S.E. Mons. Gian Carlo Bregantini (Vescovo di Locri), L’educazione alla legalità nella società meridionale. Venerdì 28 novembre (Aula Magna dell’Università), ore 9:30 Presiede: Sergio Zoppi (Università “S. Pio V”, Roma) Agostino Giovagnoli (Università Cattolica, Milano), La DC e la nascita della Commissione Antimafia. -

N. Autori Titolo Luogo Edizione Anno 1 AA.VV (ANTIMAFIA, N.3/2009), Sulla Nostra Pelle Fermo 2009 2 AA.VV
N. Autori Titolo Luogo Edizione Anno 1 AA.VV (ANTIMAFIA, n.3/2009), Sulla nostra pelle Fermo 2009 2 AA.VV. (Almanacco Guanda), Malaitalia. Dalla mafia alla cricca e oltre Parma 2010 3 AA.VV. (ANTIMAFIA N. 2/2010), Sistemi criminali Milano 2010 4 AA.VV. (Fondazione Rocco Chinnici), I costi dell'illegalità Bologna 2008 5 AA.VV. (Fondazione RES), Alleanze nell'ombra Roma 2011 6 AA.VV. (Progetto legalità-ANM) La memoria ritrovata Palermo 2005 7 AA.VV. Cultura e politica contro l'ndrangheta Cosenza 1987 8 AA.VV. Dalla mafia allo Stato Torino 2005 9 AA.VV. Falcone dieci anni dopo Roma 2000 10 AA.VV. I ragazzi e le mafie Roma 2008 11 AA.VV. Il segreto e il dogma Milano 1998 12 AA.VV. Il sentire mafioso Milano 1989 13 AA.VV. La Costituzione illustrata Bologna 2008 14 AA.VV. La legge antimafia tre anni dopo Milano 1986 15 AA.VV. La polis mafiosa Milano 2005 16 AA.VV. Le guide di Mafia Connection Milano 1992 17 AA.VV. L'immaginario mafioso. La rappresentazione sociale della mafia Bari 1986 18 AA.VV. Mafia Cartoon Torino 2006 19 AA.VV. Mafia 'ndrangheta camorra. Nelle trame del potere parallelo Roma 2005 20 AA.VV. Mafia o sviluppo Trapani 2011 21 AA.VV. Micromega n.1/2000. Dei delitti e delle pene Roma 2000 22 AA.VV. Micromega n.4/2003 Roma 2003 23 AA.VV. 'Ndrangheta. La relazione dell'antimafia Palermo 2008 24 AA.VV. Nonviolenza e mafia Trapani 2005 25 AA.VV. Nuovo dizionario di mafia e antimafia Torino 2008 26 AA.VV.