Le Signorie Dei Rossi Di Parma Tra XIV E XVI Secolo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Typical Products and Local Development: the Case of Parma Area
Typical products and local development: the case of Parma area Filippo Arfini1, Cristina Mora2 1 Department of Agricultural Economics and Forestry, University of Parma, is responsible for § 2 2 Department of Agricultural Economics and Forestry, University of Parma, is responsible for § 1 and 3 Contribution appeared in Arfini, F. and Mora, C. (Eds.) (1997) “Typical and Traditional Products: Rural Effect and Agro-Industrial Problems”, proceedings of the 52nd EAAE Seminar, pp. 11 - 40 June 19-21, 1997 Parma, Italy Copyright 1997 by Filippo Arfini and Cristina Mora. All rights reserved. Readers may make verbatim copies of this document for non-commercial purposes by any means, provided that this copyright notice appears on all such copies. Typical and traditional productions: Rural effect and agro-industrial problems 52"d EAAE Seminar - Parma, June 19-21 1997 FILIPPO ARFINI, CRISTINA MORA ZANETTl Typical products and local development: the case of Parma area ABSTRACT The pwpose of this study is to check the presence of reciprocal synergies between typical and traditional products and local development. The area in question is the province of Parma, where the presence and intensification of relations between the primmy and secondmy1 sector were, in the first fifty years of the centwy, the deciding factors of the economic development (Basini and Forestieri, 1989; Giacomini and Mora, 1996). To analyse this case we used the method of the chain-analyses, to study Parmigiana Reggiano Cheese (PR), and the idea of agro-industrial districts to examine Parma Raw Ham case. 1. THELOCALECONOMY 1.1 The development: an outline 2 Parma faced the first fifty years of the century with a renewed agriculture , from a technological point of view, and a large number of firms which undertook the processing of ' F. -

The Province of Parma
PARMA MANUFACTURERS’ ASSOCIATION www.upi.pr.it Parma and its enterprises October 2020 1 Preface Parma Manufacturers’ Association is pleased to offer this study whose purpose is to provide an up-to-date source of information for public and private institutions and organizations specifically interested in issues and questions related to industrial development in our province. More specifically, the aim of “Parma e le sue imprese” (Parma and its Enterprises) is to provide an overview of industrial activity in our province, focusing on the wide variety of manufacturing and service sectors and the specialized activity thereof. In fact, even if the core of Parma’s manufacturing tradition is to be found in the production and processing of agricultural products –Parma ham and parmesan cheese that have made it known around the world are good examples of this – there are many other sectors, some connected to this core activity and others not, which have contributed to make our productive capacity one of the most important in Italy today, fully capable of meeting the needs of our modern world and an increasingly globally-oriented future. Special thanks go to the Studies and Research Department for their tireless efforts in the preparation of this study. Annalisa Sassi President of Parma Manufacturers’ Association 2 The Province of Parma 3 The Province of Parma Map Albareto Felino Noceto Sorbolo Bardi Fidenza Palanzano Terenzo Bedonia Fontanellato Parma Tizzano Val Parma Berceto Fontevivo Pellegrino Parmense Tornolo Bore Fornovo taro Polesine Parmense -

Guida Dei Servizi in Inglese
Guide of services 2 Guide of services Index Introduction page. 4 About Us page. 5 company page. 5 Mission page. 7 Organizational Structure page. 8 with the citizen and the working method page. 10 the relationship What we are doing page. 11 Adolescent Family page. 11 Childhood Seniors page. 13 Adults page. 17 Disabled page. 18 Work for integration and autonomy page. 20 Immigrants page. 21 Interventions in support of income page. 21 social Taxi page. 23 Residential and Public Building Fund rent page. 23 Social and Health Services on the network page. 24 Guide of services 3 Introduction After a year and a half after its formation and the assumption of all social services of municipalities of United Pedemontana establishment (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala-Baganza Traversetolo e) the Company "social Pedemontana establishment provides that the citizens user-friendly guide, which lists all the references to contact the staff of the establishment and are briefly described all the managed services. The philosophy that inspired the social Pedemontana establishment is to provide persons and families of the five municipalities fair welfare and access to opportunities through answers, professionally qualified and integrated at all in the social needs and welfare, ensuring an integrated system of services and interventions in collaboration with all entities that interact in various ways: the Southern District - East establishment USL, schools, the Third Sector and Volunteering. The choice made by the Municipalities Organizational owners provides the presence in each area of one-stop social "where are the social workers who deal with older people, children and adults, the administrative staff, secretarial available to guarantee the reception and provide information to every need of a Social care. -

(Aeegsi) Codice Impianto Distribuzione
Dati identificativi impianti distribuzione/Comuni/REMI gas naturale IMPIANTO DI PRESSIONE GAS COMUNE/PORZIONE COMUNE DISTRIBUZIONE DENOMINAZIONE IMPIANTO CODICE IMPIANTO DISTRIBUZIONE (Codice CODICE REMI CODICE REMI DENOMINAZIONE REMI PUNTI DI NOME IMPRESA SERVITO DA IMPIANTO INTERCONNESSO DISTRIBUZIONE (AEEGSI) univoco AEEGSI) AGGREGATO (Punto di riconsegna) /CENTRALE GPL CONSEGNA FISICI DI TRASPORTO DISTRIBUZIONE CON ALTRI (bar minimo) IMPIANTI AREA PARMA BUSSETO CAPOLUOGO BUSSETO BUSSETO 34611501 34611501 SANT'ANDREA 7 NO SNAM RETE GAS BUSSETO CAPOLUOGO BUSSETO BUSSETO 34611502 34611502 BUSSETO CA' BOTTA 7 NO SNAM RETE GAS 34611704 CONVENTINO COLLECCHIO CENTRO COLLECCHIO COLLECCHIO 34611700 27 NO SNAM RETE GAS 34611705 FILAGNI COLLECCHIO COLLECCHIO GAIANO COLLECCHIO GAIANO 34611702 34611702 GAIANO 25 NO SNAM RETE GAS SALA BAGANZA COLORNO 34611801 CAPOLUOGO COLORNO COLORNO **GAS NATURALE MEZZANI 34611800 34611802 SACCA 13 NO SNAM RETE GAS TORRILE FELINO FELINO FELINO 34612101 34612101 CALICELLA 27 NO SNAM RETE GAS FONTANELLATO FONTEVIVO CENTRO FONTEVIVO FONTEVIVO 34612401 34612401 CAPOLUOGO 7 NO SNAM RETE GAS NOCETO FONTEVIVO PONTETARO PONTETARO 34612403 34612403 PONTETARO 7 NO SNAM RETE GAS NOCETO FORNOVO FORNOVO FORNOVO DI TARO 34612501 34612501 FORNOVO 23 NO SNAM RETE GAS LANGHIRANO LANGHIRANO LANGHIRANO 34612602 34612602 LANGHIRANO 27 NO SNAM RETE GAS COLORNO MEZZANI MEZZANI 34612901 34612901 MEZZANI 15 NO SNAM RETE GAS MEZZANI MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO MONTECHIARUGOLO 34613101 34613101 MONTECHIARUGOLO 27 NO SNAM RETE GAS -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2020
Ufficio del territorio di PARMA Data: 28/10/2020 Ora: 12.26.25 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2020 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA N.1 - ALTO TARO REGIONE AGRARIA N.2 - ALTO PARMA Comuni di: ALBARETO, BARDI, BEDONIA, BORE, BORGO VAL DI Comuni di: BERCETO, CORNIGLIO, MONCHIO DELLE CORTI, TARO, COMPIANO, SOLIGNANO, TORNOLO, VALMOZZOLA, VARSI PALANZANO, TIZZANO VAL PARMA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 4000,00 SI 4000,00 SI BOSCO D`ALTO FUSTO 6000,00 SI 6000,00 SI BOSCO MISTO 3500,00 SI 3500,00 SI CASTAGNETO DA FRUTTO 7500,00 7500,00 CASTAGNETO DA PALERIA 6000,00 6000,00 COLTIVO ABBANDONATO 2500,00 2500,00 INCOLTO PRODUTTIVO 1500,00 1500,00 INCOLTO STERILE 1000,00 1000,00 PASCOLO 3000,00 3500,00 PASCOLO CESPUGLIATO 2000,00 2000,00 PRATO 3500,00 3500,00 SEMINATIVO ARBORATO DI COLLINA 6000,00 SI 6000,00 SI SEMINATIVO ARBORATO DI 4500,00 SI 4500,00 SI MONTAGNA SEMINATIVO DI COLLINA 7000,00 6000,00 Pagina: 1 di 6 Ufficio del territorio di PARMA Data: 28/10/2020 Ora: 12.26.25 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2020 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA N.1 - ALTO TARO REGIONE AGRARIA N.2 - ALTO PARMA Comuni di: ALBARETO, BARDI, BEDONIA, BORE, BORGO VAL DI Comuni di: BERCETO, CORNIGLIO, MONCHIO DELLE CORTI, TARO, COMPIANO, SOLIGNANO, TORNOLO, VALMOZZOLA, VARSI PALANZANO, TIZZANO VAL PARMA COLTURA Valore Sup. -

Hiking Guide for Slow Walkers by Roberto Cavanna
From Parma … … to the sea on foot Hiking guide for slow walkers by Roberto Cavanna This guide has the pourpose to describe the possible routes that make one to reach, by foot, the Riviera di Levante, leaving from Parma or, alternavely, from other places of the province. TheoreAcally, the possible routes are infiniAve, but, as they all request more days of hiking, those which generally offer more possibiliAes for accomodaons were selected, while on this part of the Appennino are rather rare. For this reason, for example, the Via del Sale has not been described: it passes from Langhirano and arrives to Aulla crossing the Pass of Lagastrello. I hope that in the future I will be able to add this path, together with others, whenever the condiAons for accomodaons will be improved. The most interesAng aspect of these treks is the climb over of the Apennine ridge. ALer a short stretch in the lowland, the climb begins gently on the first hilly area between vineyards and culAvated fields. Soon, as you climb and move away from the plain, the forest begins to take over, increasingly intertwining with the rare fields that are now used only for hay harvesAng. When you reach the ridge you will find a very wild context where the human presence is very sporadic and in some parts completely absent. If you follow the Via Francigena you will be immersed in the history witnessed by the beauAful and ancient villages of Lunigiana and the archaeological remains of Luni. If you choose the other desAnaons you will walk along a long ridge where nature is the absolute master and when you start the descent towards the sea, you will see a landscape that changes quickly: you leave the vast forests of oaks, beeches and firs and you cross ancient abandoned pastures that are slowly engulfed by the Mediterranean thicket. -
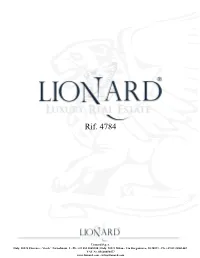
Brochure, in Any Form, Is Provided for Informational Purposes Only; It Is Not Binding and Does Not Represent an Offer in Accordance with the Relevant Legal Regulation
Rif. 4784 Lionard S.p.A. Italy, 50123 Florence - Via de’ Tornabuoni, 1 - Ph. +39 055 0548100 | Italy, 20121 Milan - Via Borgonuovo, 20 20121 - Ph. +39 02 25061442 VAT Nr. 01660450477 www.lionard.com - [email protected] Lionard Luxury Real Estate Via de’ Tornabuoni, 1 50123 Florence Italy Tel. +39 055 0548100 Parma 18th-century estate for sale in Parma DESCRIPTION This 18th-century estate surrounded by nature, full of refined architectural elements and finishes, is for sale in the heart of Parma. This luxury property for sale has 18th-century origins and is composed of a main villa, a panoramic turret and a private chapel. An elegant courtyard leads towards a quaint covered loggia with three polycentric archades that gives access to the main villa. The loggia is surmounted by a big clock and a lyre-shaped bell tower dating back to 1789; there is also a terrace offering a lovely view of the surroundings. The Medieval-style three-storey tower features a recently-renovated coloured bust depicting Lionard S.p.A. Italy, 50123 Florence - Via de’ Tornabuoni, 1 - Ph. +39 055 0548100 | Italy, 20121 Milan - Via Borgonuovo, 20 20121 - Ph. +39 02 25061442 VAT Nr. 01660450477 www.lionard.com - [email protected] Giuseppe Garibaldi. This luxury villa for sale measures 2,000 sqm overall and in on several floors. The ground floor features a particularly interesting spacious central hall, which is completely painted and flanked by well-preserved cornices with Pompeian motifs. All rooms are perfectly-renovated, spacious, well-designed and well-furnished. On the left of the courtyard there is an oratory dedicated to the Virgin Mary, completed by a small sacristy and decorated with Louis-XVI decorations. -

Graduatoria Definitiva 2019
PER CONTO DEL DISTRETTO SUD EST COMUNI DI CALESTANO,COLLECCHIO, CORNIGLIO, FELINO, LANGHIRANO, LESIGNANO DE’ BAGNI, MONCHIO DELLE CORTI, MONTECHIARUGOLO, NEVIANO DEGLI ARDUINI, PALANZANO, SALA BAGANZA, TIZZANO VAL PARMA, TRAVERSETOLO. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 L.R. 24/2001 - ANNO 2019 INIZIALI CONTRIBUTO DA POSIZIONE IN NUMERO CONTRIBUTO RICHIEDE Comune Residenza CONTRIBUTO TEORICO ESITO ECONOMIE GRADUTORIA RICEVUTA REGIONE NTE COMUNALI 1 46 BP LANGHIRANO 1.200,00 AMMESSA 1.200,00 2 24 FDM COLLECCHIO 1.000,00 AMMESSA 1.000,00 3 240 AFCN FELINO 900,00 AMMESSA 900,00 4 54 AM COLLECCHIO 1.000,00 AMMESSA 1.000,00 5 113 CA MONTECHIARUGOLO 800,00 AMMESSA 800,00 6 164 SVRD LANGHIRANO 1.022,00 AMMESSA 1.022,00 7 122 MM TRAVERSETOLO 1.000,00 AMMESSA 1.000,00 8 109 SA COLLECCHIO 900,00 AMMESSA 900,00 9 191 AA TRAVERSETOLO 1.120,00 AMMESSA 1.120,00 10 30 TE TRAVERSETOLO 760,00 AMMESSA 760,00 11 158 SN TRAVERSETOLO 920,82 AMMESSA 920,82 12 110 GM COLLECCHIO 900,00 AMMESSA 900,00 13 255 WLG FELINO 1.200,00 AMMESSA 1.200,00 14 150 CN LANGHIRANO 900,00 AMMESSA 900,00 15 286 DF MONTECHIARUGOLO 1.100,00 AMMESSA 1.100,00 16 53 MS COLLECCHIO 1.000,00 AMMESSA 1.000,00 17 152 BI LESIGNANO BAGNI 1.060,00 AMMESSA 1.060,00 18 174 BMH SALA BAGANZA 900,00 AMMESSA 900,00 19 284 MF LANGHIRANO 800,00 AMMESSA 800,00 20 233 PGPS SALA BAGANZA 800,00 AMMESSA 800,00 21 12 NB NEVIANO ARDUINI 840,00 AMMESSA 840,00 22 13 DGG SALA BAGANZA 1.000,00 AMMESSA 1.000,00 23 116 SJ COLLECCHIO 860,00 AMMESSA 860,00 24 -

Felino IL GRANDE GIRO
Felino La Ciclopista - Il Grande Giro Guida alla lettura Guide to reading Strutturata su una rete di sentieri utilizzati fin dai tempi antichi, La catena del Grande Giro MTB comprende trentacinque anelli uniti fra Consigli per i bikers The chain of the Grand MTB Tour includes thirty five loops connected to each Advice for bikers la Ciclopista MTB porta alla scoperta dell’Appennino Parma Est loro e contraddistinti dall’insieme di dieci colori RAL della segnaletica Ogni attività sportiva ha le proprie regole di comportamento. Quelle other and characterized by the ten RAL colors and by signs located along the Each sports activity has its own code of conduct. The code of conduct collocata lungo i percorsi. Sessanta sono le varianti e le connessioni lungo codificate dalla NORBA (National Off Road Bicycle Association) sono routes. There are sixty variants and connections along alternative paths. This established by NORBA (National Off Road Bicycle Association) is a good abbinando all’attività sportiva, la scoperta di bellezze naturalistiche, sentieri alternativi. Questa rete capillare lunga complessivamente 1000 di riferimento per tutti. Ogni comportamento scorretto incide soprattutto capillary net is 1000 kilometers long in its entirety, and connects all the towns guideline for everyone. Incorrect behavior has a negative impact on the artistiche e culturali. km, collega fra loro tutti i comuni dell’Appennino Parma Est: Langhirano, sull’ambiente naturale che attraversiamo, influenzando negativamente of the Eastern Apennine in the province of Parma: Langhirano, Calestano, natural environment where you travel, giving a bad impression of the entire Il risultato è una selezione di percorsi, distinti in tratti principali Calestano, Corniglio, Monchio delle Corti, Palanzano, Tizzano Val Parma, il giudizio sull’intera categoria dei bikers. -

Nomine in Ruolo Da Conc. Ord. Ddg 85/2018 E Da Grad
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA NOMINE IN RUOLO DA CONC. ORD. DDG 85/2018 E DA GRAD. AD ESAURIMENTO DOCENTI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2019/2020 SEDI ASSEGNATE NELLA CONVOCAZIONE DEL 21/08/2019 Disponibilita' Disponibilita' Pro Cattedre Cattedre vin Classe di Concorso/Tipo Interne dopo i Esterne dopo cia Codice Scuola Denominazione Scuola Denominaz. Comune Posto Movimenti i Movimenti NOMINATIVO DOCENTE A001 - ARTE E IMMAGINE PR PRMM06400X FIDENZA - "ZANI" FIDENZA SC. I GR. 1 0 MONTECHIARUGOLO - A001 - ARTE E IMMAGINE PR PRMM80601X "G. MARCONI" MONTECHIARUGOLO SC. I GR. 1 0 NOCETO - "BIAGIO A001 - ARTE E IMMAGINE 16 NOCETO + PR PRMM80801G PELACANI" NOCETO SC. I GR. 0 2 MEDESANO SAVI CRISTINA (DELEGA) NEVIANO - "GIUSEPPE NEVIANO DEGLI A001 - ARTE E IMMAGINE PR PRMM81501P VERDI" ARDUINI SC. I GR. 1 0 SAN SECONDO A001 - ARTE E IMMAGINE PR PRMM83001R DI SAN SECONDO PARMENSE SC. I GR. 1 0 VIDON CRISTIAN CENTRO A022 - TERRITORIALE SAN SECONDO ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,G PR PRCT70100L PERMANENTE PARMENSE EOG.SC.I GR 1 0 CENTRO A022 - TERRITORIALE ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,G PR PRCT70200C PERMANENTE FORNOVO DI TARO EOG.SC.I GR 1 0 A022 - ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,G PR PRMM06400X FIDENZA - "ZANI" FIDENZA EOG.SC.I GR 1 0 AZZONI STEFANIA A022 - TRECASALI "C.A. ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,G PR PRMM805014 DALLA CHIESA" SISSA TRECASALI EOG.SC.I GR 1 0 A022 - TRECASALI "C.A. ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,G PR PRMM805014 DALLA CHIESA" SISSA TRECASALI EOG.SC.I GR 1 0 A022 - TRECASALI "C.A. ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,G PR PRMM805014 DALLA CHIESA" SISSA TRECASALI -

Parma Sissa Trecasali
Legenda Isolivello PROVINCIA DI PARMA Case Cocconi 45 ≤ dB(A) < 50 Eia 50 ≤ dB(A) < 55 Servizio Viabilità PARMA Stradone Martiri della Libertà, n°15 55 ≤ dB(A) < 60 43123 - PARMA 60 ≤ dB(A) < 65 65 ≤ dB(A) < 70 A cura di: 70 ≤ dB(A) < 75 75 ≤ dB(A) Oggetto: Legenda ECUden Fognano PIANO D'AZIONE RELATIVO GLI ASSI STRADALI PRINCIPALI ECUden ≤ 55 DI COMPETENZA PROVINCIALE (art. 4 D.Lgs. 194/05) 55 < ECUden ≤ 70 MAPPA CONFLITTI Lden 70 < ECUden ≤ 75 IT_a_rd0060005 75 < ECUden ≤ 80 SP10 "DI CREMONA" - 1° Tratto 80 < ECUden ≤ 85 Case Cocconi Eia - ANTE OPERAM - 85 < ECUden ≤ 90 90 < ECUden ≤ 95 PARMA 95 < ECUden ≤ 100 Progetto: Revisione: Data: Arco stradale: AS0095 1.0 Maggio 2018 100 < ECUden Scala: Codice ditta: Disegnatore Versione: 1:10.000 6AQ01par GC 1.0 SP10 Legenda ECUden Note: No Conflitto 0 < db(A) ≤ 5 Legenda Generale Legenda Edifici ¬ 5 < db(A) ≤ 10 Fognano Strada Altri Edifici 10 < db(A) ≤ 15 Asfalto Fonoassorbente Residenziali Limite Velocità 15 < db(A) MAPPA CONFLITTI Ln Limite + Asfalto fonoassorbente Scuole Barriera Ospedali e strutture socio assistenziali Terrapieno Tunnel Comuni PARMA Case Cocconi POLESINE PARMENSEZIBELLO ROCCABIANCA Eia SISSA BUSSETO COLORNO SORAGNA SAN SECONDO PARMENSE MEZZANI TRECASALI TORRILE ID: 116387 FONTANELLATO Val: 81,2 n° Ab. 16 ID: 116757 FIDENZA Val: 82,9 n° Ed. 6 ID: 117127 FONTEVIVO SORBOLO n° Ab. 33 n° Ed. 15 Val: 83,2 n° Ab. 40 n° Ed. 11 SALSOMAGGIORE TERME NOCETO PARMA COLLECCHIO PELLEGRINO PARMENSE MEDESANO Fognano BORE MONTECHIARUGOLO ID: 118609 SALA BAGANZA VARANO DE`MELEGARI Val: 84,4 FELINO n° Ab. -

I Caduti Della Grande Guerra Di Felino: Una Ricerca Storica
I caduti della Grande Guerra di Felino: una ricerca storica Ermanno e Graziana Lori Felino, novembre 2015 Premessa Questa ricerca sui Caduti di Felino della Prima Guerra Mondiale è un continuo con la ricerca genealogica sulla discendenza della mia famiglia - i Lori. La scintilla iniziale mi è venuta il 19 giugno 2010 durante la commemorazione del Fante Francesco Lori, classe 1911, nativo di Cevola e morto nella seconda decade di gennaio del 1943 sul Don – in Russia – disperso. Dopo 67 anni in modo fortunoso viene riportata in Italia la sua piastrina di riconoscimento da alcuni camperisti italiani passati da quelle parti durante le loro ferie. Per me è stato un momento di emozione, immedesimandomi in mio padre Mario, orfano di guerra a 18 mesi del padre Ermanno, Alpino del 4° Corpo d’Armata, che morì e restò disperso sul Monte Nero il 21 luglio 1915, e venne cercato invano da mio padre per oltre mezzo secolo. Nel veder riconsegnare ai parenti la piastrina di metallo, dopo tanti decenni di ricordi, di rimpianti, di bisogno di sapere, ho sentito dentro di me ed accolto un forte messaggio. La spinta a rafforzare i sentimenti e raccogliere informazioni per far sì che non si perdesse la memoria della nostra famiglia. Durante questo lavoro di ricerca - che mi ha impegnato per 4 anni – son venuto a conoscenza che nella nostra dinastia, oltre a mio nonno Ermanno, ci sono stati altri 12 caduti: 3 col cognome Lori, 1 figlio di madre Lori e 8 con cognomi legati alla parentela. Ho sentito il dovere di raccontare la storia di questi Eroi, poiché con il loro sacrificio, la loro dignità e l’onore dimostrato permettono a noi di vivere in libertà, democrazia e pace, e con la speranza di costruire un futuro migliore: nel maggio 2014, in prossimità del centenario ho pensato di iniziare un lavoro di approfondimento, cercando di ricostruire un profilo per ogni caduto, ed arricchendolo con dati e notizie trovati negli Archivi comunali.