Via Salaria “Tiberina”
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Circuito Etrusco Sabino 2019 Classifica Finale a Squadre
CIRCUITO ETRUSCO SABINO 2019 CLASSIFICA FINALE A SQUADRE 1 ASD Team Bike Palombara Sabina 58932 2 ASD Ciclimontanini.it 17172 3 GC Canino ASD 12903 4 ASD Temerari Tivoli 12562 5 ASD 'Vo2 Cycling Lab 11891 6 ASD Team Castello Bike-Race Mountain 11705 7 Team Bike Viterbo 2002 ASD 9976 8 ASD MTB Santa Marinella Cicli Montanini 9660 9 ASD Cicli Fatato 9383 10 Custom4 RDR Factory Team 9310 11 MTB CLUB VITERBO ASD 9201 12 ASD MBM (MOBILITY BIKE MOTION) 8540 13 ASD Bike Garage Racing Team 7668 14 Team Marathon Bike 7014 15 ASD CICLI CARLETTI 6628 16 ASD Wb Family 6550 17 ASD MA.AN.RT. 6403 18 ASD NW Sport Cicli Conte Fans Bike 5655 19 ASD ANIENE BIKE TEAM 5177 20 Team Vittorio Bike ASD 5145 21 ASD Il Biciclo Team New Limits 4809 22 ASD CICLO TECH 4769 23 ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE 4649 24 ASD BIKESHOP TEAM ROMA 4498 25 ASD Kento Racing Team 4497 26 GRUPPO MTB PEDALANDO 3910 27 Team Bike Race Mountain Civitavecchia 3719 28 ASD Team Bike Civitavecchia 3532 29 Triono Racing Medical Frem 3489 30 ASD NUOVA CICLISTI FORANO 3484 31 ASD BIKE FARM RACE TEAM 3460 32 CICLISTICA L'AQUILA A.PICCO ASD 3406 33 ASD Alatri Bike 3104 34 AS Dilettantistica Bike Lab Scuola 3085 35 ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM 3024 36 ASD Vittorio Bike Montefogliano 2930 37 Asd Team Eurobici Orvieto 2911 38 ASD Tibur Bike Team 2725 39 Asd Team Carbon Lr Bike 2704 40 ASD Civitavecchiese F.lli Petito 2473 41 ACD Sc Centro Bici Team Terni 2403 42 ASD G.C. -

Elenco Permanente Degli Enti Iscritti 2020 Associazioni Sportive Dilettantistiche
Elenco permanente degli enti iscritti 2020 Associazioni Sportive Dilettantistiche Prog Denominazione Codice fiscale Indirizzo Comune Cap PR 1 A.S.D. VISPA VOLLEY 00000340281 VIA XI FEBBRAIO SAONARA 35020 PD 2 VOLLEY FRATTE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 00023810286 PIAZZA SAN GIACOMO N. 18 SANTA GIUSTINA IN COLLE 35010 PD 3 ASSOCIAZIONE CRISTIANA DEI GIOVANI YMCA 00117440800 VIA MARINA 7 SIDERNO 89048 RC 4 UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 00128330313 VIA GIOVANNI RISMONDO 2 GORIZIA 34170 GO 5 LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI BRINDISI 00138130745 VIA AMERIGO VESPUCCI N 2 BRINDISI 72100 BR 6 SCI CLUB GRESSONEY MONTE ROSA 00143120079 LOC VILLA MARGHERITA 1 GRESSONEY-SAINT-JEAN 11025 AO 7 A.S.D. VILLESSE CALCIO 00143120319 VIA TOMADINI N 4 VILLESSE 34070 GO 8 CIRCOLO NAUTICO DEL FINALE 00181500091 PORTICCIOLO CAPO SAN DONATO FINALE LIGURE 17024 SV 9 CRAL ENRICO MATTEI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 00201150398 VIA BAIONA 107 RAVENNA 48123 RA 10 ASDC ATLETICO NOVENTANA 00213800287 VIA NOVENTANA 136 NOVENTA PADOVANA 35027 PD 11 CIRCOLO TENNIS TERAMO ASD C. BERNARDINI 00220730675 VIA ROMUALDI N 1 TERAMO 64100 TE 12 SOCIETA' SPORTIVA SAN GIOVANNI 00227660321 VIA SAN CILINO 87 TRIESTE 34128 TS 13 YACHT CLUB IMPERIA ASSOC. SPORT. DILETT. 00230200081 VIA SCARINCIO 128 IMPERIA 18100 IM 14 CIRCOLO TENNIS IMPERIA ASD 00238530083 VIA SAN LAZZARO 70 IMPERIA 18100 IM 15 PALLACANESTRO LIMENA -ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA 00256840281 VIA VERDI 38 LIMENA 35010 PD 16 A.S.D. DOMIO 00258370329 MATTONAIA 610 SAN DORLIGO DELLA VALLE 34018 TS 17 U.S.ORBETELLO ASS.SP.DILETTANTISTICA 00269750535 VIA MARCONI 2 ORBETELLO 58015 GR 18 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA D.CAMPITELLO 00270240559 VIA ITALO FERRI 9 TERNI 05100 TR 19 PALLACANESTRO INTERCLUN MUGGIA 00273420323 P LE MENGUZZATO SN PAL AQUILINIA MUGGIA 34015 TS 20 C.R.A.L. -

Documento Del 30 Maggio 2020 Classe V B Linguistico
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Liceo Statale Classico – Scientifico – Linguistico “Lorenzo Rocci”. Via Colle della Felce s.n.c. – 02032 Passo Corese – Fara in Sabina (RI) tel. 0765/ 487219 fax 0765/486029 c.f. 90053850575 - [email protected] ; [email protected] Documento del 30 maggio 2020 Classe V B Linguistico Il Consiglio di Classe Lingua e letteratura italiana prof.ssa CECILIA PORTACCIO firmato Lingua e cultura inglese prof. CHRISTIAN ORSINI firmato Lingua e cultura francese prof.ssa MARIA GRAZIA RAMACOGI firmato Lingua e cultura spagnola prof.ssa VALENTINA TANZI firmato Conversazione lingua inglese prof.ssa DEBRA GLENDENNING firmato Conversazione lingua francese prof.ssa VALÉRIE MARTUCCI firmato Conversazione lingua spagnola prof.ssa ANA ISABEL MARRERO GONZALES firmato Storia e filosofia prof.ssa VALERIA BRUCCOLA firmato Matematica e fisica prof. CLAUDIO MARTINELLI firmato Scienze naturali prof.ssa TIZIANA LEPRE firmato Storia dell’arte prof.ssa JESSICA PLANAMENTE firmato Scienze motorie e sportive prof.ssa TATIANA SINOGHEIKINA firmato Religione cattolica prof.ssa BEATRICE NICOLETTI firmato Il Dirigente Scolastico prof.ssa CATERINA FEMIA 2 Indice del documento Presentazione della scuola ............................................................................................................... 5 Consiglio di classe .......................................................................................................................... 7 -

Pentathlon-Catalogue.Pdf
Modern Pentathlon 1 University of Bath Archives MODERN PENTATHLON COLLECTION A catalogue of the papers and correspondence of Pentathlon GB (1923-2017) Title: Catalogue of the papers and correspondence of Pentathlon GB (formerly the Modern Pentathlon Association of Great Britain) Compiled by: Adrian Nardone & Lizzie Richmond Description level: Fonds Date of material: 1923-2017 Extent of material: 95 boxes, c 2895 items Deposited in: University of Bath Library Reference code: GB 1128 Modern Pentathlon Collection 2018 Library, University of Bath. Cover image: Modern Pentathlon World Championship, Fort Sam Houston, Texas, USA, 1-5 October 1977 (G/1/128). Modern Pentathlon 2 Modern Pentathlon 3 University of Bath Archives University of Bath Archives LIST OF CONTENTS Items Page GENERAL INTRODUCTION 4 SECTION A MODERN PENTATHLON ASSOCIATION A/1-A/10 8 OF GREAT BRITAIN/PENTATHLON GB SECTION B UNION INTERNATIONALE DE PENTATHLON B/1-B/3 44 MODERNE (UIPM) SECTION C ARMED FORCES MODERN PENTATHLON C/1-C/5 61 ORGANISATIONS SECTION D CIVILIAN MODERN PENTATHLON D/1-D/9 88 NOT ALL THE MATERIAL IN THIS COLLECTION ORGANISATIONS MAY YET BE AVAILABLE FOR CONSULTATION. ENQUIRIES SHOULD BE ADDRESSED IN THE SECTION E PRESS CUTTINGS E/1, E/2 98 FIRST INSTANCE TO: SECTION F RESEARCH, HISTORIES, EXHIBITIONS F/1-F/3 102 THE ARCHIVIST & BIOGRAPHICAL MATERIAL LIBRARY UNIVERSITY OF BATH SECTION G PHOTOGRAPHIC MATERIAL G/1-G/3 108 CLAVERTON DOWN BATH BA2 7AY SECTION H COMPETITIONS H/1, H/2 147 SECTION J EPHEMERA J/1-J/4 290 Modern Pentathlon 4 Modern Pentathlon 5 University of Bath Archives University of Bath Archives GENERAL INTRODUCTION Northern Ireland. -

Concessions for Free Transport on City Buses, Trolleybuses and Trams for All Holders of an Olympic Card Were Granted by the Municipal Transport Authority
Concessions for free transport on City buses, trolleybuses and trams for all holders of an Olympic Card were granted by the Municipal transport authority. But the most difficult negotiations were those with the Ministry of Transport for the concession of a reduction on State Railways for travellers to Rome and from Rome to other sites of Olympic events. Unfortunately TABLE NO. 1. FREE TRIPS FOR OFFICIALS AND JOURNALISTS NUMBER OF GUESTS COUNTRIES TRIPS TOTAL 1958 1959 1960 France 2 10 10 20 Belgium 2 10 10 20 Spain 1 5 5 10 Greece 1 5 5 Austria 2 10 5 15 Tunisia 1 5 5 Holland 1 10 10 Switzerland 2 10 5 15 Kenya, Uganda, Tanganyika 1 10 10 U.S.A. 4 20 20 40 India 1 10 10 Israel 1 5 5 Germany 3 15 10 25 Ethiopia, Somalia, Sudan 1 10 10 Rhodesia 1 5 5 Brazil 1 10 10 Uruguay 1 5 5 Portugal 1 5 5 Canada 1 5 5 Venezuela 2 5 10 15 Argentine 1 10 10 Great Britain 2 20 20 Lebanon 1 5 5 Iran 1 5 5 South Africa 1 10 10 Libya 1 5 5 TOTALS 38 30 185 85 300 440 these negotiations were not wholly successful, although a reduction of 20%, valid for not more than two months within the period of 20th June-20th September, was granted to holders of the Olympic Card only. In this con- nection, mention must be made of reductions on the railways conceded by other Countries, i.e. Bulgaria 25 %, Portugal 20 %, Spain 25 %, and Turkey 25 %. -

Une Femme Vindicative
Septième Année. — N° 073 Eureii^i^u Jour/iai : rue de la Mairie, ô. Mercredi ^ÎS Sovernb ON S'ABONNE : -2 Cithot'S, bureau du Journal, PRIX DES INSERl chez A. LAYTOU, imprimeur, ANNONCES ^ on en lui adressant franco un mandat 23 centimes la ligue? sur la poste. RÉCLAMES • PRIX DE L'ABONNEMENT» 80 centimss la ligne. COT, AVBVBOf, CANTAL, Les Annonces et Avis sont r eus SÎB, DOR DOGNlS, LOT- £T-6AttONNB, TARU-ET-GARONNK : à Cahors au bureau du Journal rue de a Mairie, 6, et se paient On an...' *6 fr, d'avance. Six mois 9 fr. ,flU%Sy„ £es Lettres ou paquets non Trois mois 5 fr. rN — O/àffranchis sont rigoureusement n- AUTRES DÉPARTEMENTS: POLITIQUE, LITTERAIRE, AGRICOLE ET COMMERCIAL Un an, 20 fr.; Six mois, 4 4 fr. r ] L'ABOKNEMENT L'abonnement part du l« ou du 16 s vc^« pale d'avauee. et se paie «l'avance. M. HAVAS, rue J.-J. Rousseau, 3, et MM. LAFFITE-BULL1ER et Ce, place de la Bourse, 8 sont seuls chargés, àParis, de recevoirles annonces pour le Jourrmldu Lot. Cakors, imp. de A. LAYTOD rue de la Mairie, 6. L'acceptation du le' numéro «ni sait nn abonnement On! est considérée Ctxuene on réaisonnesiaenS. Avlm de renvoyer ce numéro, quand on voudra se désabonner 1 Les Annonces Judiciaire et Légales seront insérées, en 1867 : Pour l'arrondissent de Cahors, dans les journaux : Les annonces judiciaires : dans le journal le Courrier du Loi. Les annonces administratives : dans le journal le Journal du Lot (qui insérera, en outre, des extraits des Pour l'arrondissement de Figeac, dans les journaux : (Annonces judiciaires et administratives), l'Echo du annonces judiciaires et administratives des arrondissements de Figeac et de Gourdon). -

Fara in Sabina-Orario in Vigore Dal 18 Jan 2021 Al 31 Jan 2021 Partenza Da
Fara in Sabina - Orario in vigore dal 18 Jan 2021 al 31 Jan 2021 Partenza da: Corese Terra /S.Spirito (Corese Terra) Arrivo a: Fara in Sabina - p.le Roma Lunedì – Venerdì: 06:53(P1) 08:30(a) 09:13(P1) 16:13(P2) 17:09(P3) 18:13(P2) Sabato: 06:53(P1) 09:13(P1) 16:13(P2) 17:09(P3) 18:13(P2) Festivo: P1. Corese Terra - Canneto - Montegrottone - Prime Case Bv - Farfa Quattro Venti P2. Corese Terra - Prime Case Bv P3. Corese Terra - Canneto - Prime Case Bv Partenza da: Corese Terra /S.Spirito (Corese Terra) Arrivo a: Fara in Sabina - Autostazione FS (Passo Corese) Lunedì – Venerdì: 04:45(P1) 05:24(P1) 06:15(P2) 06:24(P3) 07:37(P4) 09:07(P4) 13:24(P1) 14:25(P5) 14:42(P6) 15:09(P1) 17:00(a) Sabato: 04:45(P1) 05:24(P1) 06:15(P2) 06:24(P3) 06:29(P3) 07:37(P4) 13:24(P1) 14:42(P6) 15:09(P1) Festivo: P1. Corese Terra - Borgo Quinzio P2. Corese Terra P3. Corese Terra - Borgo Quinzio - Salaria N., Borgo Quinzio Bv - Passo Corese Bar Mori P4. Corese Terra - Passo Corese Bar Mori P5. Passo Corese Sansificio - Borgo S.Maria Salaria Vecchia - Corese Terra - Passo Corese Bar Mori P6. Corese Terra - Borgo Quinzio - Salaria N., Borgo Quinzio Bv - Borgo S.Maria Ri - Passo Corese Bar Mori Legenda: (a) BUS INTEGRATIVO Stampato il 15/01/2021 pag. 1/87 Fara in Sabina - Orario in vigore dal 18 Jan 2021 al 31 Jan 2021 Partenza da: Corese Terra /S.Spirito (Corese Terra) Arrivo a: Fara in Sabina - Polo Didattico (Passo Corese) Lunedì – Venerdì: 07:37(P1) 09:07(P1) Sabato: 07:37(P1) Festivo: P1. -
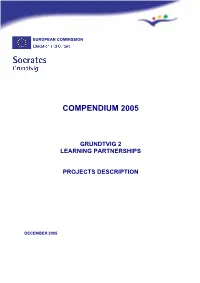
Socrates Programme
EUROPEAN COMMISSION COMPENDIUM 2005 GRUNDTVIG 2 LEARNING PARTNERSHIPS PROJECTS DESCRIPTION DECEMBER 2005 EXPLANATORY NOTE The Learning Partnerships are grouped in the Compendium according to the country of their coordinating institution. The countries appear alphabetically and in the following order by EU, EFTA/EEA and Acceding/ Candidate countries respectively: BELGIUM CZECH REPUBLIC DENMARK GERMANY (Deutschland) ESTONIA GREECE (Ellas) SPAIN (España) FRANCE IRELAND ITALY LATVIA LITHUANIA HUNGARY (Magyarorszag) MALTA THE NETHERLANDS AUSTRIA (Österreich) POLAND PORTUGAL SLOVENIA SLOVAK REPUBLIC SUOMI/FINLAND SWEDEN UNITED KINGDOM ICELAND NORWAY BULGARIA ROMANIA TURKEY TABLE OF CONTENTS BELGIUM (FLEMISH COMMUNITY)...........................................................................................16 Support for parents with intellectual disabilities................................................................................................................. 16 European Learning Partnership on easy-to-read and plain language.................................................................................. 17 MIDI-ART-EDUCATION....................................................................................................................................................... 18 Let’s Go For It: Learning English to start going forward into intereuropean travel ............................................................. 19 MEET: Methods Experience Exchange Teachers............................................................................................................... -
Riaccendiamo La Nostra Fiaccola Sportiva Editoriale
Periodico di ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE Anno XXI, n. 8/9 - Agosto-Settembre 2020 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% Roma Aut C/RM/08/2016 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 70% Roma RIACCENDIAMO LA NOSTRA FIACCOLA SPORTIVA EDITORIALE Periodico di ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE Anno XXI, n. 8-9 SOMMARIO Agosto-Settembre 2020 Reg.ne Trib. Roma n. 634/97 L’orgoglio Iscr. al Registro Nazionale della Stampa numero p.7650 3 Editoriale editore Claudio Barbaro Claudio Barbaro 6 Un quadro che racconta lo sport Fabio Argentini direttore Italo Cucci di essere dell’Asi 8 Lo sport è sfida: storia di epici duelli Marco Cochi direttore responsabile 12 Sportcity, il futuro delle città Gianluca Montebelli L’essere cresciuti Federico Pasquali coordinamento editoriale richiederà di 16 Monaco 1972, sangue sui cinque cerchi Sandro Giorgi Massimiliano Morelli implementare capo redattore 18 Uomini alla riscossa le nostre competenze e Fabio Argentini Donatella Italia l’offerta sportiva di cui 20 Il 53^ trofeo Bravin da scacco alla pandemia hanno collaborato > Claudio Barbaro oggi siamo portatori. che la nostra capacità di incidere poli- Gianluca Montebelli Donatella Italia, GianMaria Italia, ticamente sulle dinamiche di governo Marco Cochi, Chiara Minelli, 25 I Giochi di Roma Massimiliano Morelli, Federico Pasquali, Perché, per quanto si dello sport italiano. Grazie alla vostra Fabio Argentini Umberto Silvestri. Un altro quadriennio si avvicina al ter- debba essere orgogliosi spinta, infatti, sono diventato Senato- 38 Un pugno al Covid mine. Sono stati anni carichi di fatti re della Repubblica. Attraverso questo Fabio Argentini marketing capaci di riempirci il cuore di orgoglio, degli obiettivi centrati, incarico, stimolato da un confronto Achille Sette ma allo stesso tempo di metterci alla costante con voi e con i principali at- 41 Pagine di sport esistono ampi margini Fabio Argentini direzione e amministrazione prova e preludere a nuove e importan- di miglioramento. -

Alma Mater Studiorum – Università Di Bologna
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Corso di laurea magistrale in Sociologia e Servizio sociale Tesi di Laurea in Sociologia delle migrazioni I PROCESSI DI INCLUSIONE DEGLI STRANIERI IN EMILIA-ROMAGNA: IL RUOLO DELLA SCUOLA DI ITALIANO PENNY WIRTON CANDIDATO RELATORE Jacopo Brigotti Prof. Maurizio Bergamaschi Appello IV Sessione Anno Accademico 2018-2019 INDICE Introduzione .................................................................................................................. pag. 3 Capitolo 1 L’INCLUSIONE DEGLI IMMIGRATI ................................................. pag. 7 1.1. Politiche di immigrazione e politiche per gli immigrati: un breve confronto ..... pag. 7 1.2. I modelli di inclusione ........................................................................................ pag. 9 1.2.1. I modelli temporaneo, assimilativo e pluralista 1.2.2. Il caso italiano: un modello implicito di integrazione 1.2.3. Ulteriori classificazioni 1.3. Le società multietniche ................................................................................... pag. 20 1.4. La "civic integration" nelle politiche migratorie ............................................ pag. 22 1.5. I servizi per gli stranieri .................................................................................. pag. 28 1.5.1. Il dibattito tra "generalismo" e "specializzazione" 1.5.2. La scelta della Regione Emilia-Romagna Capitolo 2 LA DIMENSIONE TERRITORIALE E LE POLITICHE LOCALI pag. 31 2.1. Territorio e localismo .................................................................................... -

Indexes and References—Vol. 2
I N D E X E S AND REFERENCES Once again, I wish to give special thanks to the same people whom I indicated at ACKNOWLEDGMENTS the end of Volume One, which the reader is referred to. To them I would like to add: Bernini Renato, Chief Executive Officer of SEAT spa, Turin - Considerable im- pulse to carry on and improve the work. Bianucci, Piero, Editor-in-Chief of the insert “Tuttoscienze” in the daily newspaper La Stampa of Turin - Special commitment in spreading the work. Celardo, John, Chief, Appraisal and Disposition Branch, National Archives and Records Administration - Northeast Region, New York, NY - Research on Garibaldi’s journey to Havana on board steamer Georgia. De Julio, Umberto, Director General of Telecom Italia spa, Rome - Structural and financial support for carrying on research on Antonio Meucci. Flaumenhaft, Daniel, Research Assistant of the Chemical Heritage Foundation, Philadelphia, PA, for useful information on the first electroplating and stearic industries of the United States. Guglielmi, Silvia, ASIA sas, Rome - Special care and closeness to the letter and spirit of the original text, in her translation of the work into English. Ravizza, Vittorio, Editor of the insert “Tuttoscienze” in the daily newspaper La Stampa of Turin - Author of an article (see bibl.) on Dr. Catania’s findings on Antonio Meucci’s discovery of the inductive loading of telephone lines. 744 Antonio Meucci 1. Felice Foresti, Spielberg’s martyr (p. 11) - Portrait, author and date unknown, PICTURE CREDITS photographed by M. Vianocchi and on display at the «Museo del Risorgimento» in Rome. 2. Lorenzo da Ponte (p. -

SR 313 Di Passo Corese E Degli Indicatori Fondamentali Dell’Incidentalità Relativamente Al Triennio 2012 E 2014 (Aggiornamento Della Base Conoscitiva: Maggio 2017)
CENTRO DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA REGIONE LAZIO L'INCIDENTALITÀ STRADALE SULLA SR 313 PASSO CORESE PERIODO 2001-2014 L'INCIDENTALITÀ SULLA R E T E STRADALE ASTRAL S R 3 1 3 P a s s o C o r e s e Redatto a cura di: Ing. Tommaso Caligiuri Ing. Francesco Girolami Ing. Marco Valerio Salucci Coordinamento ASTRAL SpA: Ing. Adriana Elena Dott. Ivo Vernieri MAGGIO 2017 . CENTRO DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA REGIONE LAZIO L'INCIDENTALITÀ STRADALE SULLA SR 313 PASSO CORESE PERIODO 2001-2014 Sommario 1 SINTESI DEL DOSSIER ..................................................................................................... 3 2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO ....................................................................................... 7 3 DEFINIZIONE DEGLI INDICI DI INCIDENTALITÀ .......................................................... 8 VALORI ASSOLUTI DI INCIDENTALITÀ .................................................................. 8 COSTO SOCIALE .................................................................................................... 8 MISURE RELATIVE DI INCIDENTALITÀ ................................................................... 8 4 INQUADRAMENTO GENERALE ED EVOLUZIONE DELL’INCIDENTALITÀ NEL PERIODO 2001-2014 ........................................................................................................... 10 QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE ........................................................... 10 L’INCIDENTALITÀ, IL COSTO SOCIALE E LA LORO EVOLUZIONE DAL 2001 AL 2014 ...............................................................................................................................