Carlevaro: "Costruire Una Lingua"
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Latinidaj Planlingvoj (AIS-Kurso, 1 Studunuo)
Vĕra Barandovská-Frank: Latinidaj planlingvoj (AIS-kurso, 1 studunuo) La Latina apartenas al la italika grupo de la hindeŭropa lingvofamilio (tiu ĉi lingvofamilio ampleksas i.a. preskaŭ ĉiujn eŭropajn lingvojn, ekz. grupon ĝermanan kaj slavan), el la Latina evoluiĝis etnaj lingvoj nomataj Romanaj ( = latinidaj), precipe itala, romanĉa, sarda, franca, okcitana, hispana, kataluna, galega, portugala, gudezma, rumana, moldava. Latinidaj planlingvoj estas similaj al la Romanaj lingvoj kaj ofte imitas ilian evoluon. Latina skribo (el la greka kaj etruska alfabetoj): originale 20 majusklaj literoj (maiuscula): A B C D E F H I K L M N O P Q R S T V X . Literon I oni uzis ankaŭ por la sono [j], literon C ankaŭ por G, poste diferenciĝis [k] kaj [g]. U kaj V estis la sama litero: majuskle ekzistis nur V, poste minuskle (minuscula) u: VENIO – uenio (minuskloj evoluiĝis el la mezepoka karolinga alfabeto). En la klasika latina ne estis K, k, J j, U, u, v, W, w, Y, y, Z, z poste trans- prenitaj aŭ el la greka alfabeto (K, U, Y, Z ), aŭ faritaj el jam ekzistantaj literoj (J, W). Restaŭrita prononco: vokaloj longaj kaj mallongaj. La litero V/u estas aŭ konsonanta [ŭ] aŭ vokala [u]; i (j) aŭ konsonanta [j] aŭ vokala [i]. La litero c prononciĝis kiel [k]; qu kiel [kŭ]; au kiel [aŭ]; ae kiel [aj]; oe kiel [oj]. h estis antikve ĉiam prononcata, sed iom post iom malaperis. En helenaj pruntvortoj estis uzataj ch, ph, th [kh]/[ĥ], [ph], [th], poste [k], [p], [t]. La akcento ĝenerale troviĝis sur la antaŭlasta silabo, se ĝia vokalo estis longa, aŭ je la antaŭantaŭlasta, se mallonga, ekz. -

Om Babelstårnet Og Hvad Der Deraf Fulgte! - Kunstsprogsamlinger I Det Kongelige Bibliotek
3 Om Babelstårnet og hvad der deraf fulgte! - Kunstsprogsamlinger i Det kongelige Bibliotek - af forskningsbibliotekar, cand.mag. Ruth Bentzen Hele Menneskeheden havde et Tungemaal og samme Sprog — Derpaa sagde de: Kom, lad os bygge os et Taarn , hvis Top naar til Himmelen, og skabe os et Navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele Jorden. Men Herren steg nedfor at se Byen og Taarnet, som Menneskebørnene byggede og sagde: Se, de er eet Folk og har alle eet Tungemaal; og naar de nu først er begyndt saaledes, er intet, som de sætter sig for umuligt for dem; lad os derfor stige ned og forvirre deres Tungemaal der, saa de ikke forstaar hver andres Tungemaal! Da spredte Herren dem fra det Sted ud over hele Jorden, og de opgav at bygge Byen. Derfor kaldte man den Babel, thi der forvirrede Herren al Jordens Tungemaal og derfra spredte Herren dem ud over Jorden. (1. Mosebog, kap. 11, vers 1-9) Bibelens fortælling om sprogenes oprindelse og Babelstårnet mindes de fleste sikkert fra deres barndomsskoles religionsundervisning. Udtrykket babelsk/ babylonisk for virring dukker op i de flestes bevidsthed, når man står i situationer med sprogligt vir var og dermed følgende forståelsesvanskeligheder eller som man vel snarere vil sige idag kommunikationsbrist. Gennem tiderne har folk stedse, når de i deres færden bevægede sig udenfor lo kalsamfundet været i situationer, hvor der var en forståelseskløft, de skulle over. Tan ken om eet fælles sprog, der kunne lette kommunikationen folkeslag imellem er fra tid til anden dukket op. Man har til forskellig tid hjulpet sig på forskellig vis. -

Nos Presenta Interlingua
Nos presenta Interlingua Ferenc Jeszensky Summario le imperio de Alexandro le Grande que comprehendeva ultra le territorios habitate ab longe per le grecos an- Iste articulo del prof. Ferenc Jeszensky presenta Inter- que Asia Minor e Egypto (pro un brevissime tempore lingua per le medio de un ample analyse del situation mesmo Persia e un parte de India). Ma post le morte de linguistic in le mundo occidental, como e proque le lin- su fundator (323 a.Chr.) illo se decomponeva in quattro guas plus influente del cultura international acquireva regnos independente. lor forma actual. Depost haber describite le solutiones Le interprisa de Alexandro totevia non dispareva sin inadequate del linguas construite, ille presenta le prin- lassar ulle tracia. In le territorio del statos successor de cipios de Interlingua. su imperio, in despecto del cessation del unitate politic, le unitate cultural non cessava. Al contrario, un stadio novelle del cultura grec se evolveva: le hellenistic, que 1 Le via del lingua Latin se inricchiva de elementos del culturas minorasiatic e egyptian. (Ab le latino classic usque al latino “implicite”) 1.0.3 Le lingua del grecos 1.0.1 Le linguas indoeuropee Le linguas del mundo pertine a varie familias. Illos que In le tempores le plus ancian super que nos ha ancora pertine al mesme familia ha un origine commun. cognoscentias le varie tribos grec parlava non un lin- Un del familias de linguas es le indoeuropee a cuje gua unitari ma varie dialectos de un lingua.De illos le brancas le plus importante pertine le linguas indoira- iono-attic perveniva al significantia le major proque illo nian, grec, italic, celtic, germanic, baltic e slave. -

The Esperantist Background of René De Saussure's Work
Chapter 1 The Esperantist background of René de Saussure’s work Marc van Oostendorp Radboud University and The Meertens Institute ené de Saussure was arguably more an esperantist than a linguist – R somebody who was primarily inspired by his enthusiasm for the language of L. L. Zamenhof, and the hope he thought it presented for the world. His in- terest in general linguistics seems to have stemmed from his wish to show that the structure of Esperanto was better than that of its competitors, and thatit reflected the ways languages work in general. Saussure became involved in the Esperanto movement around 1906, appar- ently because his brother Ferdinand had asked him to participate in an inter- national Esperanto conference in Geneva; Ferdinand himself did not want to go because he did not want to become “compromised” (Künzli 2001). René be- came heavily involved in the movement, as an editor of the Internacia Scienca Re- vuo (International Science Review) and the national journal Svisa Espero (Swiss Hope), as well as a member of the Akademio de Esperanto, the Academy of Es- peranto that was and is responsible for the protection of the norms of the lan- guage. Among historians of the Esperanto movement, he is also still known as the inventor of the spesmilo, which was supposed to become an international currency among Esperantists (Garvía 2015). At the time, the interest in issues of artificial language solutions to perceived problems in international communication was more widespread in scholarly cir- cles than it is today. In the western world, German was often used as a language of e.g. -

A Visual Inter Lingua Neil Edwin Michael Leemans Worcester Polytechnic Institute
Worcester Polytechnic Institute Digital WPI Doctoral Dissertations (All Dissertations, All Years) Electronic Theses and Dissertations 2001-04-24 VIL: A Visual Inter Lingua Neil Edwin Michael Leemans Worcester Polytechnic Institute Follow this and additional works at: https://digitalcommons.wpi.edu/etd-dissertations Repository Citation Leemans, N. E. (2001). VIL: A Visual Inter Lingua. Retrieved from https://digitalcommons.wpi.edu/etd-dissertations/154 This dissertation is brought to you for free and open access by Digital WPI. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations (All Dissertations, All Years) by an authorized administrator of Digital WPI. For more information, please contact [email protected]. VIL: A Visual Inter Lingua by Neil Edwin Michael (Paul) Leemans A Dissertation Submitted to the Faculty of the WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Computer Science by ____________________ April 2001 APPROVED: _____________________________________________ Dr. Lee A. Becker, Major Advisor _____________________________________________ Dr. David C. Brown, Committee Member _____________________________________________ Dr. Norman Wittels, Committee Member, Department of Civil and Environmental Engineering _____________________________________________ Dr. Stanley S. Selkow, Committee Member __________________________________________________ Dr. Micha Hofri, Head of Department VIL: A Visual Inter Lingua _____________________________________________________________________ -

The Foreign Service Journal, February 1954
"r^ Vji.i: liswl is X s •• -4 S^L :wc m <=> a* ^r.u •*> i JV* & % t" ■ ■ ' .SB r • ' -* “No, paisan. Io dico, ‘Make Mine “The only whisky bottled under 909’! Ca-na-da Schenley 909.” supervision of the Govern- “Ah, si—whisky di Canada!” mento di Canada at exactly “No, not just any Canadian 90.9 proof, the one proof of whisky. Bring me the one with perfection. Nove — zero— the naturally fine taste . the nove—909—capisc'?” one that fills your glass with the “Nove—zero—nove! Natural- beauty and magic of Canada.” mente . il benissimo*!” “Non capisc'.” ^(translation: naturally . tin* finest!) ©1954 Canadian Schenley, Ltd. AGED AND BOTTLED UNDER SUPERVISION OF THE CANADIAN GOVERNMENT- CANADIAN SCHENLEY, LTD., VALLEYFIELD, P. Q.r CANADA How the two parts of a great country achieve unity in spite of a 1,000-mile separation ... by means of modern radio broadcasting Six years ago Pakistan had neither a of communication, of enlightenment. pindi . operating a total broadcast government nor a capital. There were Radio Pakistan came into being ... at¬ time of 96 program hours a day. over 77 million people and 360,000 tracted competent engineers to its pro¬ Radio Pakistan is completely co¬ square miles of land, but commerce was gram ... developed into a compact pow¬ ordinated. Its nine transmitters link all almost at a standstill . transportation erful voice. To RCA was given the job sections of the nation into one united and communications were disrupted. of providing the powerful radio equip¬ network ... as well as being an enlight¬ And the greatest migration in history ments installed by Radio Pakistan. -

Saussure Esperantista
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di Laurea in Civiltà letterarie e Storia delle civiltà RELAZIONE FINALE SAUSSURE ESPERANTISTA Relatore: Chiar.mo Prof. Davide Astori Correlatore: Char.ma Prof.ssa Fabienne Winkler Laureanda: Stefania Rinaldi Matricola n.175562 ANNO ACCADEMICO 2009/2010 1 INDICE Introduzione............................................................................................3 1 Breve storia della nascita dell'esperanto..............................................5 2 René de Saussure...................................................................................15 2.1. Notizie biografiche, inserimento e movimenti all'interno dell'ambiente esperantista.................................................15 2.2. Le origini della Nuova Lingua: Il Nov-Esperanto, o Esperanto II.........................................................................20 2.3. La moneta unica per un'unica Nazione: Lo Spesmilo.....29 2.4. Il ricordo di René de Saussure...........................................32 3 René, Ferdinand e l'Esperanto.................................................................37 4 Bibliografia analitica della vita di René de Saussure..........................43 5 Conclusioni....................................................................................................55 6 Appendice......................................................................................................57 7 Bibliografia....................................................................................................63 -

Interlingvistiko Kaj Esperantologio (Diversaj Planlingvaj Temoj)
Parto 7: Interlingvistiko kaj esperantologio (diversaj planlingvaj temoj) 2 INTERLINGVISTIKO ABLEMONDE (lingvo, 1932) KAJ ESPERANTOLOGIO Efemera aposteriora planlingva projekto sur (diversaj planlingvaj temoj) romanid-ĝermana bazo, ellaborita de iu Gus- tav Schwarz kaj publikigita sub la titolo Klefo di Ablemonde en 1932 en la revuo Interlan- guages (n-roj 49 kaj 50, Paris 1932). Specimena teksto: Ablemonde vice able la lo Enkonduko: monde; boko di la mondo, mondoboko; arbe- En ĉi tiu parto de la enciklopedio, titolita pome vice pomale: pomiero; veneruje vice ‘Interlingvistiko kaj esperantologio’ (diversaj rujeste: redijar. Lo anje soy dije la lu: no tim planlingvaj temoj), oni trovas informojn kaj nokos! Mi nuntse vu une novam ko vay porte artikolojn pri interlingvistikaj kaj lingvistikaj la omne poblor un grande joyonte. Bibl.: G. Schwarz: Klefo di «Ablemonde». En: Inter- temoj, kiuj ne trovis lokon en la antaǔaj en- languages, 50/1932. ciklopediaj partoj. Ĉi tiu parto de la enciklo- pedio do unuflanke raportas, en alfabeta ordo, pri efemeraj planlingvaj projektoj kaj ANTIDO I (lingvo, 1907) donas sciigojn pri centraj interlingvistikaj Antido I: Temas pri la unua el multaj re- institucioj kaj organizaĵoj, aliflanke ĝi pre- formprojektoj sur la bazo de Eo, detale ella- zentas personecojn, t.e. ĉefe sciencistojn- borita en la tempo de la Ido-skismo far tRe- lingvistojn, kiuj ludis gravan rolon en la né de Saussure (1868-1943; kiu mem uzis la interlingvistika diskuto aǔ aplikadis plurajn pseŭdonimon Antido) kaj publikigita en Anti- planlingvojn samtempe. do I, Saussure, R. de, Grammaire élémentaire de la Langue Internationale avec recueil En la ĉefa svisa volapüklingva gazeto d’exercices / Elementala gramatiko de la Schweizerpost / Jveizapot (Zürich) aperis en Lingwo internaciona kun exercaro di Antido, majo 1890 interesa artikolo, verkita supo- Genève 1907 (2a kaj 3a eld. -

Universidade Federal De Juiz De Fora Programa De Pós-Graduação Em Letras – Estudos Literários
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – ESTUDOS LITERÁRIOS Warleson Peres As tríades do Portunhol Selvagem de Douglas Diegues: entre textos e sujeitos, uma língua poeticamente calculada Juiz de Fora 2019 Warleson Peres As tríades do Portunhol Selvagem de Douglas Diegues: entre textos e sujeitos, uma língua poeticamente calculada Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Letras: Estudos Literários, área de concentração em Teorias da Literatura e Representações Culturais, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Letras. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Silvina Liliana Carrizo. Juiz de Fora 2019 Dedico este trabalho à tríade que embasa minha vida: Deus, família e amigos. AGRADECIMENTOS A Deus e à Maria, em seus títulos de Nossa Senhora, que velam incessantemente por mim. Aos inúmeros Warleson’s que me habitam, que, por muito tempo, pensei que sufocavam o pesquisador, mas, na verdade, contribuíam para que ele amadurecesse. De modo especial, agradeço ao menino que um dia eu fui e, ao longo desses últimos quatro anos, pôde se reaproximar do homem. Este trabalho representa um aceno de paz. Aos meus pais, Rute e Antônio, pelos exemplos e valores ensinados. À minha esposa Ana Flávia e aos meus filhos, João Victor e Ana Luísa, pela compreensão e amor incondicionais. Obrigado por me amarem tanto assim! Aos meus irmãos, Wederli e Wesley, pelas oportunidades de me fazer crescer. Aos professores Ana Beatriz Gonçalves e Marcos Tanure, anjos amigos que Deus enviou para me incentivar a trilhar esse caminho do doutorado, quando nem eu mesmo acreditava nessa possibilidade. -
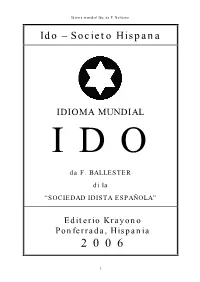
Manual De Uso Del Soroban
Idioma mundial Ido, da F. Ballester Ido – Societo Hispana IDIOMA MUNDIAL I D O da F. BALLESTER di la “SOCIEDAD IDISTA ESPAÑOLA” Editerio Krayono Ponferrada, Hispania 2 0 0 6 1 Idioma mundial Ido, da F. Ballester AVERTO LEKTENDA: Ta libro rieditesas kom pdf-dokumento gratuite en la internet-pagino www.publikaji.tk danke edituro originala donacita da sioro Günter Anton a la Ido-Societo Hispana. Nulakaze la libro rieditesas intence obtenar profito ekonomiala. La libro-kopioyuri ya apartenas a la legala proprietanto. La opinioni pri irga temo quin onu povas lektar en la texto di ta libro esas opiniono di la autoro od autori di la texto. Editerio Krayono ne oblige konkordas pri ta opinioni. Informo: Originala edituro: Idioma mundial Ido, de F. Ballester. Sociedad Idista Española, Rosellón, 279, 2º, Barcelona, España, 1956. Yena edituro: Idioma mundial Ido, da F. Ballester. Ido-Societo Hispana, Ponferrada, Hispania, 2006. Fernando Tejón / Editerio Krayono Los claveles nº 6, E-24400 Ponferrada, Hispania. [email protected] www.publikaji.tk http://es.geocities.com/krayono IDO – SOCIETO HISPANA Los claveles nº 6, E-24400 Ponferrada, Hispania. [email protected] 2 Idioma mundial Ido, da F. Ballester La Sociedad Idista Española (“Hispana Ido Societo"), saluda a todos los amantes de la cultura y de la Paz, rogándoles la fiel interpretación de este folleto, y procurándole su máxima divulgación. SOCIEDAD IDISTA ESPAÑOLA Rosellón, 279, BARCELONA 3 Idioma mundial Ido, da F. Ballester INTRODUCCION Al iniciar la publicación de este folleto, nos proponemos satisfacer los deseos de quienes, sabiendo escuchar la vibración de su yo interno, buscan con afán, algo para poder contribuir al progreso moral, en consonancia con la época en que vivimos. -

Auxiliary Schedule 3 : Language
AUXILIARY SCHEDULE 3 : LANGUAGE (1) This separate schedule is an auxiliary to the enumerated classes 2/9, A/Z. The concepts in it are available only to qualify those classes, and their classmarks are not to be used on their own. (2) These classmarks may be added to any class where the instruction appears to add letters from Schedule 3; e.g. in Class J Education, JV is special categories of educands, and at JVG Language groups, Non-English (or favoured language) speaking appears the instruction: Add to JVG letters C/Z from Schedule 3; so Education of Bantus would be JVG HN. Or, in Schedule 2, BQ is Linguistic group areas, and BQH N would be Bantu-speaking areas. (3) A prominent use of the Schedule will be to specify translations, version, etc., of particular works in classes like Literature, Religion and Philosophy; e.g. PM6 Versions of the New Testament, has the instruction Add to PM6 letters C/Z from Schedule 3; so PM6 RF is Greek versions. (4) Where no such special provision is made, the language of a document can be specified by adding Schedule 3 notation to 2X from Schedule 1, e.g. Encyclopaedia of economics, in French T3A 2XV. (5) If a library wishes to give a preferred position with a short classmark to a particular language (e.g. that of the place where the library is situated) the letter F or Z may be used. (6) Any language may be qualified by the preceding arrays C/E by direct retroactive synthesis; e.g. -

In 2018 Linguapax Review
linguapax review6 62018 Languages, Worlds and Action Llengües, mons i acció Linguapax Review 2018 Languages, Worlds and Actions Llengües, mons i acció Editat per: Amb el suport de: Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Exterior Relacions Institucionals i Transparència Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea Coordinació editorial: Alícia Fuentes Calle Disseny i maquetació: Maria Cabrera Callís Traduccions: Marc Alba / Violeta Roca Font Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons CONTENTS - CONTINGUTS Introduction. Languages, Worlds and action. Alícia Fuentes-Calle 5 Introducció. Llengües, mons i acció. Alícia Fuentes-Calle Túumben Maaya K’aay: De-stigmatising Maya Language in the 14 Yucatan Region Genner Llanes-Ortiz Túumben Maaya K’aay: desestigmatitzant la llengua maia a la regió del Yucatán. Genner Llanes-Ortiz Into the Heimat. Transcultural theatre. Sonia Antinori 37 En el Heimat. Teatre transcultural. Sonia Antinori Sustaining multimodal diversity: Narrative practices from the 64 Central Australian deserts. Jennifer Green La preservació de la diversitat multimodal: els costums narratius dels deserts d’Austràlia central. Jennifer Green A new era in the history of language invention. Jan van Steenbergen 101 Una nova era en la història de la invenció de llengües. Jan van Steenbergen Tribalingual, a startup for endangered languages. Inky Gibbens 183 Tribalingual, una start-up per a llengües amenaçades. Inky Gibbens The Web Alternative, Dimensions of Literacy, and Newer Prospects 200 for African Languages in Today’s World. Kọ́lá Túbọ̀sún L’alternativa web, els aspectes de l’alfabetització i les perspectives més recents de les llengües africanes en el món actual.