Senato Della Repubblica - 257 - Camera Dei Deputati
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Marcelle Padovani Marcelle Padovani
EDIZIONI DELLA BATTAGLIA Gioacchino Nania San Giuseppe e la mafia Nascita e sviluppo del fenomeno nell’area dello Jato Introduzione di Marcelle Padovani 1 Attraverso documenti, in massima parte inediti, questo lavoro ricostruisce, in maniera sistemati ca, nascita e sviluppo del fenomento mafioso nell'area dello Jato a partire dall'abolizione dei diritti feudali, nel 1812, sino ai tempi moderni con particolare riferimento a San Giuseppe Jato e San Cipirello. Due comuni, in unica realtà urbana, ubicati a lle spalle di Palermo in posizione baricentrica rispetto al circolo formato da Monreale, Piana degli Albanesi, Corleone, Alcamo, Partinico, Montelepre. Comuni noti per i Brusca, Di Maggio, Siino, Salamone e per la base operativa insediatavi, negli ultimi d ecenni, da Salvatore Riina. Comuni che, con motivazioni diverse, si rilevano nelle biografie non solo di Calvi, Insalaco, Salvo, Sindona ma anche di Marco Minghetti, Benito Mussolini, V.E. Orlando o dei parlamentari Rocco Balsano, Alfredo Cucco, Lanza di Trabia, Giovanni Lo Monte, Francesco Termini, Nicolò Zito. Sono i comuni di Portella della Ginestra e dell' "ideologo" della banda Giuliano, Pasquale Sciortino. Comuni di luminari, professori, professionisti e di straordinari arricchimenti attraverso mediat ori, assicuratori, industrie conserviere e portuali, mulini e pastifici . Nel 1927 l'on. Rocco Balsano dichiarava dinanzi al giudice Triolo: " Se un comune vi era in Sicilia dove la maffia era onnipotente era proprio quello di San Giuseppe Jato ". Erano gli anni del ducino on. Alfredo Cucco, plenipotenziario del fascismo in Sicilia, legato alla mafia dei comuni jatini attraverso il suo compare d'anello Santo Termini, Sindaco di San Giuseppe Jato. -

Capitolo IV. Le Ramificazioni Territoriali Della Mafia (Formato PDF 3051
Senato della Repubblica — 257 — Camera dei Deputati LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI CAPITOLO QUARTO LE RAMIFICAZIONI TERRITORIALI DELLA MAFIA SEZIONE PRIMA sembrò subito -a taluni un'emanazione della mafia siciliana ma sulle prime non ne ebbe né LA MAFIA ALL'ESTERO i caratteri né le origini né i legami con i ceti dirigenti sociali o ipolitici: si trattava sol- tanto di un'associazione delinquenziale nata 1. / collegamenti della mafia con organizza- per .finalità di mutua assistenza del gruppo et- zioni criminose straniere. nico e della colonia di immigrati siciliani, ohe vi contentò di operare perenni esclusivamen- La mafia non è mai stata un fatto soltanto te nei circoli e nelle colonie dei nostri .immi- siciliano. In tutti i tempi sono state frequen- gra-ti. Tutti gli italiani dovevano pagare un ti ed estese le infiltrazioni mafiose in Paesi contributo, una specie di taglia o decima, stranieri e in più occasioni le cronache, •han- che poteva ammontare da un dollaro alla no registrato l'esistenza di saldi rapporti tra settimana ai 5 mila dollari richiesti a Enri- la mafia e determinate organizzazioni crimi- co Caruso. L'attività fondamentale della Ma- nali straniere, specialmente nord-americane. no Nera era quella delle estorsioni e delle ra- In particolare, per quanto (riguarda gli Sta- pine attraverso lettere ricattatorie ohe sol- ti Uniti, tali rapporti hanno un'origine tut- lecitavano versamenti in denaro e le cui ri- t'altro che recente, poiché sorsero, si può di- chieste dovevano essere soddisfatte, pena la re, nel 'momento stesso in cui sì sviluppò <l'e- morte per chi si rifiutava o denunciava la co- migrazione siciliana e quindi l'emigrazione sa alla Polizia. -

Cahiers D'études Italiennes, 6
Cahiers d’études italiennes Filigrana 6 | 2007 La Nouvelle italienne du Moyen Âge à la Renaissance Johannes Bartuschat (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/cei/835 DOI : 10.4000/cei.835 ISSN : 2260-779X Éditeur UGA Éditions/Université Grenoble Alpes Édition imprimée Date de publication : 15 mai 2007 ISBN : 978-2-84310-096-3 ISSN : 1770-9571 Référence électronique Johannes Bartuschat (dir.), Cahiers d’études italiennes, 6 | 2007, « La Nouvelle italienne du Moyen Âge à la Renaissance » [En ligne], mis en ligne le 15 novembre 2008, consulté le 19 mars 2021. URL : http:// journals.openedition.org/cei/835 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cei.835 Ce document a été généré automatiquement le 19 mars 2021. © ELLUG 1 SOMMAIRE Avant-propos Johannes Bartuschat La nouvelle face à l'histoire : fictions, faits historiques, récits Banditi e pirati nella narrativa medievale: alcuni casi di fuorilegge cortesi Federica Veglia Histoire et quête d’authenticité dans le Novellino. Quelques pistes de réflexion Alessandra Stazzone « E io scrittore » : stratégies narratives et vérité historique dans le Trecentonovelle de Franco Sacchetti Irena Prosenc Šegula « Per autentiche istorie approbate » : les fonctions de l’histoire dans le Novellino de Masuccio Salernitano Maria Cristina Panzera Nouvelle et Histoire : incertitudes génériques dans les Novelle de Matteo Bandello Serge Stolf La nouvelle et les autres genres : genèses et contacts Dalla legenda alla novella: continuità di moduli e variazioni di genere. Il caso di Boccaccio Filippo Fonio Pontano, Castiglione, Guazzo : facétie et normes de comportement dans la trattatistica de la Renaissance Florence Bistagne Un capitolo minore della narrativa cinquecentesca: gli Apologi di Bernardino Ochino (Ginevra, 1554). -
Commissione Parlamentare D'inchiesta Sul Fenomeno
La provincia di Messina è un capitolo estratto della relazione commissione antimafia XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI XIV LEGISLATURA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE Relazione finale di minoranza Relatori: LUMIA Giuseppe, SINISI Giannicola , RUSSO SPENA Giovanni , SANTULLI Paolo , CEREMIGNA Enzo , ZANCAN Giampaolo , AYALA Giuseppe Maria , BATTAGLIA Giovanni , BOVA Domenico , BRUTTI Massimo , BURTONE Giovanni Mario Salvino , CALVI Guido , DALLA CHIESA Nando , DIANA Lorenzo , GAMBALE Giuseppe , LEONI Carlo , MINNITI Marco , MANZIONE Roberto , MARINI Cesare , MARITATI Alberto , VERALDI Donato Tommaso La provincia di Messina è un capitolo estratto della relazione commissione antimafia XIV LEGISLATURA La provincia di Messina è un capitolo estratto della relazione commissione antimafia XIV LEGISLATURA La provincia di Messina La Commissione Antimafia istituita nella XIII legislatura, sull’onda emotiva di un eclatante omicidio (quello del professore universitario Matteo Bottari, primario di endoscopia al locale policlinico universitario) che aveva destato sconcerto e allarme nell’opinione pubblica dell’intera nazione, aveva doverosamente dedicato grande attenzione alla città di Messina ed alla sua provincia. Dopo una corposa attività di acquisizione di informazioni, particolarmente incentrata sulle dinamiche del fenomeno mafioso nel messinese, sulle infiltrazioni mafiose negli ambienti politici, imprenditoriali ed accademici e, infine, sulle cause della -
02Ledichiarazionideicollaboratori.Pdf
CAPITOLO SECONDO I collaboratori nel presente processo 1) ANZELMO Francesco Paolo Ha rivestito il ruolo di vice rappresentante della “famiglia” della Noce, prima del 1983 inserita nel mandamento di Porta Nuova di cui era capo CALO’ Giuseppe. Nel novembre del 1982, conclusa con la vittoria della fazione corleonese la fase più acuta della c.d. seconda guerra di mafia, erano state ricostituite le “famiglie”, era cioè stato ridisegnato l’organigramma delle cariche di vertice, almeno nelle “famiglie” in cui avevano sino ad allora ricoperto ruoli importanti elementi della c.d. mafia perdente, e GANCI Raffaele, persona assai legata a RIINA Salvatore, era stato eletto rappresentante con votazione unanime degli “uomini d’onore” di quella “famiglia”, mentre lo ANZELMO era stato prescelto come suo vice. Nel gennaio del 1983 la fedeltà del GANCI era stata premiata con l’attribuzione al medesimo della carica di capomandamento, essendo stata la “famiglia” della Noce scorporata dal mandamento di Porta Nuova. La stretta vicinanza dello ANZELMO ad una delle persone che maggiormente aveva contribuito all’attuazione della strategia criminale perseguita dal RIINA, ha comportato il suo coinvolgimento in alcuni dei più efferati delitti di mafia, quali l’omicidio del Capitano dei Carabinieri D’ALEO; la strage in cui perse la vita il consigliere istruttore del Tribunale di Palermo CHINNICI; l’omicidio del Commissario della P.S. CASSARA’; il plurimo omicidio impropriamente noto come la “strage della Circonvallazione di Palermo”, in cui vennero uccisi il boss catanese FERLITO Alfio e gli uomini addetti alla sua traduzione dal carcere; l’omicidio del Generale DALLA CHIESA, Prefetto di Palermo. -

Parte Seconda
I documenti originali in formato PDF li trovate al seguente indirizzo: http://archiviopiolatorre.camera.it/ Senato della Repubblica - Camera dei Deputati LEGISLATURA VI DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA MAFIA (20 dicembre 1962 - 4 luglio 1976) LEGISLATURA VI - 1976 - PARTE TERZA - Relazione PISANO' 991 PARTE SECONDA (Relazione del senatore PISANO') http://www.eleaml.org – Febbraio 2015 LEGISLATURA VI - 1976 - PARTE TERZA - Relazione PISANO' 992 http://www.eleaml.org – Febbraio 2015 LEGISLATURA VI - 1976 - PARTE TERZA - Relazione PISANO' 993 MAFIA, POLITICA E POTERI PUBBLICI ATTRAVERSO LA STORIA DI LUCIANO LEGGIO http://www.eleaml.org – Febbraio 2015 LEGISLATURA VI - 1976 - PARTE TERZA - Relazione PISANO' 994 http://www.eleaml.org – Febbraio 2015 LEGISLATURA VI - 1976 - PARTE TERZA - Relazione PISANO' 995 Nel capitolo quarto della Relazione di maggioranza («Le ramificazioni territoriali della mafia»), dopo avere trattato l'evoluzione del fenomeno mafioso in questo dopoguerra, attraverso una rapida sintesi della vita di Luciano Leggio dall’inizio della sua attività criminale fino aJla sua cattura avvenuta a Milano il 16 maggio 1974, si afferma (paragrafo 7): «Naturalmente sarebbe vano cercare di individuare le responsabilità personali che hanno permesso a Leggio di non essere chiamato a rispondere dei suoi crimini con la necessaria tempestività... ». Ebbene, noi non concordiamo con questa affermazione. Le testimonianze e i documenti raccolti dalla Commissione antimafia offrono pienamente la possibilità -

Positivo Imzio Per La Treguah
*!>' '•f'-.v-'Vt « /•«-.v;;_\ ;'">• 'If-:.*' *t?^ V*t>''- .^"/# :**W; '«* vVV'W.. •vv i t*<*\> #'V &.';%'. •,.'(« &< •A.-;Xi*>. $&P •\*W P :/ :\ *$zwwm?!*.;.:$$&'* >:'>' •&V; Quotidiano / Sptd. abb. postal* /. Lira 50 ^ Anno XV / N.195 / Mtrcolcdi 17 luglio 1963 -'.-•'.• 11 DOMANI v ronta/fi ecff/i m sc/opero il PIONIERE Comiz/o a Coraca/la ,'r ll dell' Unita ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO i .* X.'W.; Stabilita ercussioni crisi Le trattative a Mosca monetaria » j/i Positivo A NCHE il 5 ministro * del Bilancio, sen. Medici, come gia il presidente del Consiglio e ancor prima ij governatore della Banca, d'ltalia, illustrando lu- nedi scorsc al Senato la situazione economica nazio- nale, ha insistito molto sulla necessita di difendere la stabilita monetaria. Lo ha fatto pero in modo .*• •' • s imzio per abbastanz- • singolare per un ministro che ha ' la massima responsabilita nella direzione della politica Come Giuliano a Castelvetrano economica nazionale: senza, cioe, dare alcuna spie- gazione delie cause che sono all'origine dell'attuale pressione inflazionistica e senza indicare quali siano le misure. che il governo intende adottare per far fronte ai pericoli che stanno dinanzi al Paese. ' : Grossocap la treguaH Ora, se sf vuole effettivamente impedire l'ulte- riore asces dei prezzi e del costo della vita, occorre individuarne con 1 chiarezza le cause ed operare quindi <•.•»*> energia perche siano rimosse. Quali siano e d.c. Un comunicato uf- queste cause e stato da noi, e da altre forze demo- cratiche, piu volte messo in luce. Si tratta essen- DOMENICA ficiale definisce zialmente della politica dei grandi gruppi monopo listic e della speculazione (sui prodotti agricoli, amichevoli le con sulle importazioni, sulle aree edificabili ecc.) che, tratto in 21 luglio sempre ; present]'. -
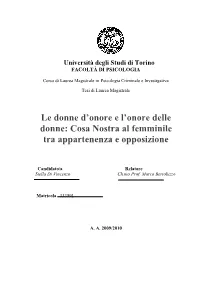
Le Donne D'onore E L'onore Delle Donne
Università degli Studi di Torino FACOLTÀ DI PSICOLOGIA Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Criminale e Investigativa Tesi di Laurea Magistrale Le donne d’onore e l’onore delle donne: Cosa Nostra al femminile tra appartenenza e opposizione Candidato/a Relatore Stella Di Vincenzo Ch.mo Prof. Marco Bertoluzzo Matricola 333591 A. A. 2009/2010 A mio Nonno A Maria Aurora Gueli Ai miei insostituibili genitori A me, Stella… INDICE INTRODUZIONE p.6 CAPITOLO I Cosa Nostra 1.1 Genesi e rappresentazione sociale: tra realtà e apparenza p.10 1.2 L’istituzione della legge Rognoni-La Torre p.16 1.2.1 I contenuti dell’art 416 bis p.20 1.3 La sospensione delle ordinarie regole di trattamento: l’art. 41 bis o.p. p.26 1.3.1 Analisi dei contenuti applicativi del regime di “carcere duro” p.30 CAPITOLO II Donna o Madre 2.1 Il ruolo materno nell’universo mafioso p. 36 2.1.1 Le madri “modello” p.42 2.1.2 Gli angeli vendicatori p.46 2.2 Famiglia e famiglia: un possibile conflitto p.51 2.3 Gli “intoccabili”: donne e bambini uccisi dalla mafia p.59 CAPITOLO III L’altra metà dalla mafia 3.1 La criminologia femminile e lo stereotipo culturale p.68 3 3.1.1Lo stereotipo della donna dentro Cosa Nostra p.73 3.2 L’impunità della donna di mafia: il paternalismo giudiziario p.76 3.3 Le attività criminali della donna di mafia. Droga e prostituzione p.86 3.3.1 Da messaggere a manager p.93 3.3.2 Le funzioni direttive p.99 3.4 La decostruzione dello stereotipo p.105 3.4.1 L’emancipazione femminile all’interno della mafia p.108 CAPITOLO IV Le donne del disonore 4.1 L’emergenza pentiti: supporto delle donne al pentimento p.112 4.1.1 L’opposizione al pentimento p.117 4.2 Le collaboratrici di giustizia p.129 CAPITOLO V L’onore delle donne 5.1 Le testimoni di giustizia p.158 5.1.1 Il modello emancipativo p.166 5.1.2 Le donne si costituiscono parti civili p.174 5.1.3 Commenti conclusivi p.190 5.2 Le Associazioni Antimafia p.194 CAPITOLO VI 6.1. -

Parte Seconda. Relazione Del Senatore Pisanò
Senato della Repubblica — 99Ì •— Camera dei Deputati LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI PARTE SECONDA (Relazione del senatore PISANO) Senato della Repubblica — 993 — Camera dei Deputati LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI MAFIA, POLITICA E POTERI PUBBLICI ATTRAVERSO LA STORIA DI LUCIANO LEGGIO 63. Senato della Repubblica — 995 — Camera dei Deputati LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Nel capitolo quarto della Relazione di I documenti e le testimonianze esistenti maggioranza (« Le ramificazioni territoriali negli archivi della Commissione antimafia della malìa »), dopo avere 'trattato l'evolu- (e che noi citeremo nel corso della nostra zione del fenomeno mafioso in questo do- relazione) portano infatti a collegare il no- poguerra, attraverso una rapida sìntesi della me di Luciano Leggio e ile vicende di cui è vita di Luciano Leggio dall'inizio della sua stato protagonista il dottor Pietro Scaglio- attività criminale fino al/la sua cattura av- ne, Procuratore capo dal/la Repubblica di venuta a Milano ii 16 maggio 1974, si affer- Palermo, assassinato il 5 maggio 1971, al dottor Angelo Vicari, già prefetto di Pa- ma (paragrafo 7): lermo e Capo della polizia dal 1960 al 1973, « Naturalmente sarebbe vano cercare di a Salvatore Lima, già sindaco democristia- individuare le responsabilità personali che no di Palermo, eletto quindi deputato e di- hanno permesso a Leggio di non essere chia- venuto Sottosegretario idi Stato alle finanze mato a rispondere dei suoi crimini con la con ii secondo Governo Andreotti, al ban- necessaria tempestività... ». chiere De Luca, già creatura di Sindona, che, Ebbene, noi non concordiamo con questa attraverso il suo Banco di Milano, ci porta affermazione. -

Senato Della Repubblica Camera Dei Deputati Xiv Legislatura
SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI XIV LEGISLATURA Doc. XXIII n. 16-bis COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITA` ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE (istituita con legge 19 ottobre 2001, n. 386) (composta dai senatori: Centaro, Presidente, Dalla Chiesa, Segretario; Ayala, Battaglia Giovanni, Bobbio, Boscetto, Brutti Massimo, Bucciero, Calvi, Cirami, Crino`, Curto, Ferrara, Florino, Gentile, Manzione, Marini, Maritati, Novi, Peruzzotti, Ruvolo, Thaler Ausserhofer, Veraldi, Vizzini, Zancan; e dai deputati: Ceremigna, Napoli Angela, Vice Presidenti; Parolo, Segretario; Bertolini, Bova, Burtone, Cicala, Cristaldi, Diana, Drago, Fallica, Gambale, Grillo, Lazzari, Leoni, Lisi, Lumia, Minniti, Misuraca, Palma, Russo Spena, Santulli, Sinisi, Taglialatela, Taormina) Relazione conclusiva di minoranza presentata nella seduta del 18 gennaio 2006 (Relatore: onorevole LUMIA) Comunicata alle Presidenze il 20 gennaio 2006 ai sensi dell’articolo 1 della legge 19 ottobre 2001, n. 386 TIPOGRAFIA DEL SENATO (300) Senato della Repubblica–2– Camera dei deputati XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Senato della Repubblica–3– Camera dei deputati XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI INDICE Premessa. La finalita` della relazione e le critiche di fondo alla gestione della Commissione Antimafia nella XIV legislatura ..... Pag. 5 Prospettive di lavoro per la prossima legislatura . ......... »25 Parte Prima L’ATTIVITA` DELLA COMMISSIONE I Beni Confiscati. Le scelte del Governo e la relazione di mi- noranza ........................................ » 27 Mafia e economia. Gli appalti: la riduzione del numero delle stazioni, il controllo dei cantieri, i protocolli di legalita` di nuova generazione ............................. » 46 Convenzione ONU di Palermo. Lo scandalo del ritardo nella ratifica. ........................................ » 58 Racket e usura. Il licenziamento di Tano Grasso e le nostre proposte ...................................... -

Thieves' World
THIEVES' WORLD The Threat of the New Global Network of Organized Crime CLAIRE STERLING No one has benefited more from the political changes of the 1990s than international organized crime. Within the space of just three or four years, the world's great crime syndicates have joined in a planet-wide criminal consortium unlike any in history. A Pax Mafiosa has emerged— an agreement to avoid conflict, devise common strategy, and exploit the planet peaceably togeth- er—linking the American and Sicilian mafias, Russian organized crime, the Chinese Triads, the Japanese Yakuza, and Colombia's cocaine cartels. It threatens the liberty, security, and political integrity of the U.S., Europe, and all free societies. For these giants of the underworld, the creation of the European Community in Western Europe and the collapse of the Soviet Empire in the east have erased borders and made the commerce of crime easier than ever. In Thieves' World, outstanding international investigative reporter Claire Sterling traces the stunning advance of this global criminal enterprise since 1990: the proliferation of its criminal interests and growth of its investment capital to a quarter of a trillion dollars, its deepening penetration of worldwide money markets, its spreading powers of blackmail and corruption, and its alarming colonization of Western Europe and America. Above all, Claire Sterling describes the great shift of worldwide criminal attention to eastern Europe and Russia, showing how a country covering a sixth of the earth's land mass has been taken captive by the mafias of the world in partnership with Russian criminals, looting the nation systematically, crippling its economic capacity, contaminating its body politic, and suffocating its political will—all at enormous peril to the West. -

Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style
Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style Letizia Paoli OXFORD UNIVERSITY PRESS MAFIA BROTHERHOODS STUDIES IN CRIME AND PUBLIC POLICY Michael Tonry and Norval Morris, General Editors Making Crime Pay: Law and Order in Contemporary American Politics Katherine Beckett Community Policing, Chicago Style Wesley G. Skogan and Susan M. Hartnett Crime Is Not the Problem: Lethal Violence in America Franklin E. Zimring and Gordon Hawkins Hate Crimes: Criminal Law and Identity Politics James B. Jacobs and Kimberly Potter Politics, Punishment, and Populism Lord Windlesham American Youth Violence Franklin E. Zimring Bad Kids: Race and the Transformation of the Juvenile Court Barry C. Feld Gun Violence: The Real Costs Philip J. Cook and Jens Ludwig Punishment, Communication, and Community R. A. Duff Punishment and Democracy: Three Strikes and You’re Out in California Franklin E. Zimring, Gordon Hawkins, and Sam Kamin Restorative Justice and Responsive Regulation John Braithwaite Maconochie’s Gentlemen: The Story of Norfolk Island and the Roots of Modern Prison Reform Norval Morris Can Gun Control Work? James B. Jacobs Penal Populism and Public Opinion: Lessons from Five Countries Julian V. Roberts, Loretta J. Stalans, David Indermaur, and Mike Hough Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style Letizia Paoli MAFIA BROTHERHOODS ORGANIZED CRIME, ITALIAN STYLE Letizia Paoli 1 2003 1 Oxford New York Auckland Bangkok Buenos Aires Cape Town Chennai Dar es Salaam Delhi Hong Kong Istanbul Karachi Kolkata Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Mumbai Nairobi São Paulo Shanghai Taipei Tokyo Toronto Copyright © 2003 by Oxford University Press, Inc. Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York 10016 www.oup.com Oxford is a registered trademark of Oxford University Press All rights reserved.