Intellettuali E Uomini Di Regime Nell'italia Fascista
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dai Rifiuti Al Re Nasce Il Regime Fascista Fatale Per L’Italia La Miopia Della Classe Dirigente 1 Dicembre 1919
Anno XXXVII – N. 2 Dicembre 2020 AVVISO ALLE POSTE Sped. in a.p. 70% In caso di mancata consegna inviare Poste Italiane Spa – Filiale di Milano TRIMESTRALE DI CULTURA E POLITICA al CMP di Roserio per la restituzione al mittente, che si impegna a pagare la relativa tassa. DAI RIFIUTI AL RE NASCE IL REGIME FASCISTA Fatale per l’Italia la miopia della classe dirigente 1 dicembre 1919. Dal discorso della Corona: “... Il Parlamento, presidio di ogni libertà, difesa e garanzia di tutte le istituzioni democratiche, deve essere oggi più che mai circondato dalla fiducia del Paese… Il nostro Paese raggiunge con la guerra quei confini che la natura gli diede…”. 11 giugno 1921. Dal discorso della Corona “… Perché quest’opera di riassestamento proceda nella concordia delle classi sociali, occorrerà che il Parlamento rivolga l’attività propria all’ordinato ascendere delle classi lavoratrici così delle officine come dei campi… Sarà vanto di questa assemblea… rafforzare gli istituti cooperativi… per consentire alle classi operaie di abilitarsi gradualmente al difficile governo dell’attività economica”. “La rivoluzione fascista si fermò davanti a un trono”* B. Mussolini Vittorio Emanuele III si oppone al fascismo 1918 L’Italia è compiuta 20 novembre 1918. Ore 14. Camera dei Deputati. Vittorio Emanuele Orlando, presidente della Camera: “Onorevoli colleghi! L’Italia è compiuta… Le nostre istituzioni, essenzialmente democratiche, consentono ogni sviluppo e ogni trasformazione. L’Italia, che si fece pari a sé stessa nella guerra, saprà sorpassare sé stessa nella pace”(1) Riprende la vita parlamentare, ma il Direttore del Cor- riere della Sera, Luigi Albertini, senatore e membro del Fascio parlamentare di difesa nazionale, raggruppamento patriottico di partiti durante la guerra, il 21 novembre scri- ve: “I fasci devono ora rappresentare la fine dei vecchi partiti”. -

ARCHIVI DI FAMIGLIE E DI PERSONE, Materiali Per Una Guida, II
206 Archivi di famiglie e persone 2083. NEGRI AS Novara. Vèrsamento. Dati complessivi: bb. 11 (1537-1931 con docc. in copia dal 1167). Elenco. Carte patrimoniali della famiglia Negri, conservate nell'archivio dell'Ospedale maggiore della carità, riguardanti case di Novara e tenute agricole che Giuseppe Negri, nel 1900, lasciò in eredità all'ospedale stesso. BIBi., Guida, III, p. 183. 2084. NEGRONI Giovanni AS Novara. Deposito. Dati complessivi: bb. 3 (1812-1843). La documentazione è costitnita da carte professionali e personali del magistrato e awocato Giovanni Negroni. È conservata in Raccolte. e miscellanee, Mano scritti. 2085. NEGROTTO Biella, Fondazione Sella. Dati complessivi: scatole 6 (XIX-XX). Carte della famiglia Negrotto di Genova; si segualano quelle relative a Pericle f N egrotto, tenente colonnello dei bersaglier� irredentista e nazionalista. 2086. NIBBIA AS Novara. Versamento. Dati complessivi: b. 1 (1561-1780). Elenco. I! piccolo fondo, conservato nell'archivio dell'Ospedale maggiore della carità, contiene carte patrimoniali della famiglia, pervenute all'ente insieme con le pro prietà lasciate in eredità da Carlo Nibbia, chirurgo. BIBi., Guida, III, p. 183. ' , 2087. NICOLIS ,AS Novara. Versamento. Dati complessivi: pergg. 68 (1386-1492). Regesto; in ventario 1457. Le pergamene sono conservate nell'archivio dell'Ospedale maggiore della carità. Con testamento dell'anno 1401 Giovannino Nicolis destinò i propri beni alla fon dazione, in Novara, dell'Ospedale di S. Antonio, poi concentrato (1482) nell'Ospedale della carità. Un piccolo nucleo dell'archivio Nicolis (23 pergame ne) si trova nella raccolta Canetta (vedi scheda relativa). BIBe., Guida, III, p. 183. l. Codicetto contenente privilegi della famiglia Ponzone. Secolo XVI in. -

La Marcia Su Roma
MARIO BUSSONI Mattioli 1885 Mattioli LA MARCIA SU ROMA VIAGGI NELLA STORIA ® 978-88-6261-236-4 Mattioli 1885 LA MARCIA SU ROMA | BUSSONI • INTRODUZIONE STORICA • BIOGRAFIE DEI PERSONAGGI • ITINERARI STORICO-TURISTICI • INDIRIZZI UTILI LA MARCIA SU ROMA di Mario Bussoni www.viaggiestoria.com viaggi nella storia ® by www.viagginellastoria.it B Mattioli 1885 Milano Cremona Perugia Monterotondo Civitavecchia Mentana Santa Marinella Tivoli ROMA Comando Centri di Raccolta Città importante In un quadro del pittore Giacomo Balla: l'ingresso a Roma. Mentana Tivoli abc 4 La Marcia su Roma La Marcia su Roma prima edizione Aprile 2012 © Mattioli 1885 srl - Strada della Lodesana, 649/sx, Loc. Vaio, 43036 Fidenza (Parma) tel. 0524.892111 - www.mattioli1885.com Grafica e Impaginazione Officine Grafiche Multimediali Via del Torrione, 27 - 43122 Parma Viaggi nella storia ® by www.viagginellastoria.it www.viaggiestoria.com Testi: Mario Bussoni Editing: Riccardo Baudinelli Coordinamento collana: Marcello Calzolari Foto di copertina: "L'Azione", statua del Vittoriano, Roma Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, non è consentita senza la preventiva autorizzazione scritta dell’editore. Viaggi nella Storia 5 PRESENTAZIONE Celebrata dal Regime come l’epilogo della Rivoluzione fascista, cosa è stata realmente la Marcia su Roma: una semplice manifestazione di piazza, sostanzialmente sopravvalutata, un vero e proprio colpo di stato o piuttosto una manifestazione violenta, un azzardo, fortunosamente andato a buon fine? Nelle pagine che seguono ne abbiamo ricostruito con precisione la dinamica, partendo dal 24 ottobre 1922, quando, nel corso del raduno delle camicie nere a Napoli, Benito Mussolini afferma sicuro: “O ci daranno il governo o lo prenderemo calando a Roma”. -

JENS PETERSEN the Italian Aristocracy, the Savoy Monarchy, and Fascism
JENS PETERSEN The Italian Aristocracy, the Savoy Monarchy, and Fascism in KARINA URBACH (ed.), European Aristocracies and the Radical Right 1918-1939 (Oxford: Oxford University Press, 2007) pp. 91–110 ISBN: 978 0 199 23173 7 The following PDF is published under a Creative Commons CC BY-NC-ND licence. Anyone may freely read, download, distribute, and make the work available to the public in printed or electronic form provided that appropriate credit is given. However, no commercial use is allowed and the work may not be altered or transformed, or serve as the basis for a derivative work. The publication rights for this volume have formally reverted from Oxford University Press to the German Historical Institute London. All reasonable effort has been made to contact any further copyright holders in this volume. Any objections to this material being published online under open access should be addressed to the German Historical Institute London. DOI: 6 The Italian Aristocracy, the Savoy Monarchy, and Fascism JENS PETERSEN What political role did the aristocracy play in the early decades of a unified Italy? Researchers are widely divided in their opin- ions on this question. They range from the rose-tinted view of Arno Mayer, who regarded the ancien regi,me nobility as still at the core of Italy's social and political system, to opinions that speak of a rapid and unstoppable decline. 1 Although aristocratic values continued to shape the path of upward mobility for the middle classes, nobility as such did not play an important role in the Italian nineteenth-century social structure, because it did not constitute a well-defined group in itself, due to its regional more than national status. -

Questionariostoria
QuestionarioStoria 1 In seguito a quale evento bellico l'esercito del Regno 7 A seguito di quale accusa fu sciolto il Partito d'Italia poté entrare in Roma nel 1870? Socialista Italiano nel 1894? A) Alla sconfitta dei Francesi a Sedan A) L'accusa di aver appoggiato i Fasci siciliani B) Alla sconfitta dei Prussiani a Verdun B) L'accusa di spionaggio a favore della Seconda Internazionale socialista C) Alla sconfitta degli Austriaci a Sadowa C) L'accusa di voler attentare alla vita del sovrano D) Alla sconfitta dei Francesi a Lipsia D) L' accusa di aver attentato alla vita di Umberto I 2 Come reagì il governo Rudinì alle agitazioni popolari del 1898? 8 Tra quali nazioni l'irredentismo italiano fu causa di rapporti diplomatici tesi? A) Cercò alleanze in parlamento A) L'Italia e la Polonia B) Fece importanti concessioni ai dimostranti B) L'Italia e la Grecia C) Rassegnò le dimissioni C) L'Italia e l'Impero ottomano D) Si affidò all'esercito D) L'Italia e l'Austria - Ungheria 3 Nel 1884 il governo Depretis abolì un'imposta invisa alla popolazione. Quale? 9 In quale anno morì Camillo Cavour? A) La tassa sul macinato A) Nel 1865 B) La tassa doganale regionale B) Nel 1875 C) La tassa comunale di utilizzo delle acque pubbliche C) Nel 1861 D) La tassa sulla prima casa D) Nel 1871 4 Quali direttive di politica estera adottò Antonio 10 Nel 1861 espugnò, dopo un assedio, la fortezza di Rudinì nel marzo del 1896, quando fu incaricato di Gaeta, ultima roccaforte dei Borbone; condusse nella sostituire Francesco Crispi alla guida dell'Esecutivo? Terza guerra d'indipendenza le truppe dell'esercito che operavano sul basso Po. -

Italian Land Policy and Practice in Ethiopia, (1935-1941)
Haile M. Larebo THE MYTH AND REALITY OF EMPIRE BUILDING: ITALIAN LAND POLICY AND PRACTICE IN ETHIOPIA, (1935-1941) A Thesis Submitted To University Of London In Fulfilment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy School Of Oriental And African Studies February 1990 ProQuest Number: 11010607 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 11010607 Published by ProQuest LLC(2018). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States C ode Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106- 1346 TO ADAMA, IY ANN A, MANITO, PAULINE AND BELOVED PARENTS ABSTRACT Apart from being Italo-centric, the vast majority of scholarly work on the short-lived period of Italian occupation of Ethiopia is mainly preoccupied with political events and particularly with their repercussions on international diploma cy. With the exception of a few pioneering studies, Italian rule and its impact on Ethiopia is given marginal importance. The present thesis confines itself to one specific key area of Italian policy - land. Search for an outlet to settle Italy’s excess population and deploy its surplus capital, had sustained Italian imperialist ambitions from the 19th century and justified the conquest of Ethiopia against quasi universal international opposition. -

Thaon Di Revel” Launched in Muggiano
THE MULTIPURPOSE OFFSHORE PATROL SHIP “THAON DI REVEL” LAUNCHED IN MUGGIANO Trieste, June 15, 2019 –The launching ceremony of the Multipurpose Offshore Patrol Ship (PPA) “Paolo Thaon di Revel” took place today at Fincantieri’s shipyard in Muggiano (La Spezia), in the presence of the Italian Minister of Defence Elisabetta Trenta,. Godmother of the ceremony was Mrs. Irene Imperiali, nephew of the Admiral Paolo Thaon di Revel. The ceremony was attended among others by the Chief of Staff of the Italian Navy, Admiral Valter Girardelli, by Fincantieri’s Chairman Giampiero Massolo and CEO Giuseppe Bono. The PPA, first of seven units, will be delivered in 2021 and it is part of the renewal plan of the operational lines of the Italian Navy vessels, approved by the Government and Parliament and started in May 2015 (“Naval Act”). Vessel’s characteristics: PPA – Multipurpose Offshore Patrol Ship The multipurpose offshore patrol vessel is a highly flexible ship with the capacity to serve multiple functions, ranging from patrol with sea rescue capacity to Civil Protection operations and, in its most highly equipped version, first line fighting vessel. There will be indeed different configurations of combat system: starting from a “soft” version for the patrol task, integrated for self-defence ability, to a “full” one, equipped for a complete defence ability. The vessel is also capable of operating high-speed vessels such as RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) up to 11 meters long through lateral cranes or a hauling ramp located at the far stern. • 132.5 -
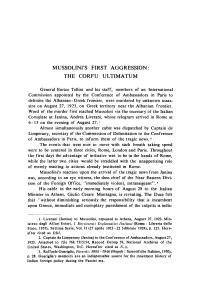
Mussolini's First Aggression: the Corfu Ultimatum
MUSSOLINI’S FIRST AGGRESSION: THE CORFU ULTIMATUM General Enrico Tellini and his staff, members of an International Commission appointed by the Conference of Ambassadors in Paris to délimité the Albanian - Greek frontier, were murdered by unknown assas sins on August 27, 1923, on Greek territory near the Albanian frontier. Word of the murder first reached Mussolini via the secretary of the Italian Consulate at Janina, Andrea Liverani, whose telegram arrived in Rome at 6: 15 on the evening of August 27. 1 Almost simultaneously another cable was dispatched by Captain de Limperany, secretary of the Commission of Delimitation to the Conference of Ambassadors in Paris, to inform them of the tragic news.2 3 * * The events that were now to move with such breath taking speed were to be centered in three cities, Rome, London and Paris. Throughout the first days the advantage of initiative was to be in the hands of Rome, while the latter two cities would be straddled with the unappetizing role of merely reacting to actions already instituted in Rome. Mussolini’s reaction upon the arrival of the tragic news from Janina was, according to an eye witness, the then chief of the Near Eastern Divi sion of the Foreign Office, "immediately violent, intransigeant”.9 His cable in the early morning hours of August 28 to the Italian Minister in Athens, Giulio Cesare Montagna, is revealing. The Duce felt that "without diminishing seriously the responsibility that is incumbent upon Greece, immediate and exemplary punishment of the culprits is indis- 1. Liverani (Janina) to Mussolini, repeated to Athens, August 27, 1923. -

Il Crollo Del Regime Fascista E Una Vertenza Cavalleresca
MemoriaWeb - Trimestrale dell'Archivio storico del Senato della Repubblica - n. 23 (Nuova Serie), settembre 2018 Il crollo del regime fascista e una vertenza cavalleresca di Fulco Lanchester1 Sommario: 1 - Premessa; 2 - La vertenza Perna - Rotigliano; 3 - Le trascurate premesse della vertenza: la richiesta del senatore Rotigliano in Commissione legislativa nel maggio 1943; 4 - Conclusioni 1 - Premessa - È periodo di anniversari: settanta anni fa fu promulgata la Costituzione repubblicana; cinque anni prima era crollato il regime fascista, cui seguì il periodo costituzionale transitorio e provvisorio2; ottanta anni fa la rottura dell'impianto statutario fu resa manifesta anche dal punto di vista formale, con il ricorso ad atti normativi. Nel 1938 l'istituzione del maresciallato dell'impero, l'approvazione delle leggi razziali e della legge istitutiva della Camera dei fasci e delle corporazioni 3 costituirono indicatori empirici del passaggio dallo Stato autoritario a tendenza totalitaria verso una forma nuova, che la guerra provvide ad interrompere. Le vicende belliche portarono - dopo l’arretramento sui fronti africano e russo - alla disaffezione della classe dirigente per il regime e alla ricerca di soluzioni alternative, che nel luglio 1943 condussero alla convocazione del Gran Consiglio del fascismo e ai noti eventi successivi. 2 - La vertenza Perna - Rotigliano - In questo specifico quadro il testo relativo alla vertenza Perna - Rotigliano4, pubblicato in Appendice, non solo aiuta a chiarire un retroscena trascurato dalla storiografia sulla vicenda del crollo del regime fascista, ma evidenzia come, contemporaneamente a questi avvenimenti, persistessero apparenti anacronismi (la sfida a duello tra due senatori del Regno5 per ragioni d'onore), capaci però di fornire lumi su radicate tradizioni culturali di cui il fascismo fu partecipe, ma non responsabile. -

Collana Storica Della Banca D'italia Serie Documenti
EDITOR! L"",.,lRZA 11ta ... ~ BANCA D'ITALIA 9 EUROS I STEMA COLLANA STORICA DELLA BANCA D'ITALIA SERIE DOCUMENTI- INDICI DEI VOLUMI COLLANA STORICA DELLA BANCA D'ITALIA- DOCUMENTI L'ITALIA E IL SISTEMA FINANZIARIO INTERNAZIONALE 1861-1914 a cura di Marcello De Cecco EDITORI LATERZA CSBI - Documenti, I [1990] INDICE DEL VOLUME Presentazione di Carlo A. Ciampi VII Prefazione di Carlo M. Cipolla IX Abbreviazioni XVI Introduzione l l. L'Italia nel sistema monetario internazionale 5 2. n debito pubblico estero italiano 22 2.1. I grandi prestiti della prima metà degli anni Sessanta, p. 23 • 2.2. Il prestito per l'abolizione del corso forzoso, 1881-82, p. 32 - 2.3. La conversione della Rendita del 1906, p. 39 3. Problemi di gestione del cambio, delle riserve e del cor so della Rendita all'estero 42 Conclusioni 52 Appendice Nota sulle fonti 55 l. Problemi generali di impostazione della ricerca 55 2. Le ricerche d'archivio effettuate 56 2.1. Archivi italiani, p. 56 - 2.2. Archivi esteri, p. 59 3. Lacune della documentazione disponibile 61 Documenti 63 Avvertenze 65 Parte prima L'Italia nel sistema monetario internazionale 67 l. Progetto di legge Cordova del l 0 febbraio 1862 69 2. Adunanza generale degli azionisti della Banca Nazionale 73 3. Progetto di legge Pepoli del 9 giugno 1862 76 CSBI - Documenti, I [1990] 1038 Indice del volume 4. Convenzione monetaria stipulata tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera a Parigi i123 dicembre 1865 94 5. Verbale degli interventi dei delegati italiani Carlo Rusconi e Cesare Baralis alla Conferenza monetaria internazionale di Parigi del 1878 104 6. -

Venice's Imperial Past And
Empire, city, nation: Venice’s imperial past and the ‘making of Italians’ from unification to fascism David Laven and Elsa Damien In the aftermath of the 1848-9 revolutions, even amongst those political commentators most deeply sympathetic to the cause of Italian unification, it remained a commonplace to decry not only the politically fragmented nature of the peninsula but the deep internal divisions within the Italian people. Thus, for example, the French historian François-Tommy Perrens, writing in a work completed shortly after New Year 1857, reflected that, Agreement is no more than a dream. Everywhere division rules, between subjects as much as between princes, between one province of city and another, even within the very heart of an individual city. Nothing can be done that requires collective effort. Much has been spoken of federations and leagues, without a single one ever having been formed. In vain has it been desired to unite Rome with Florence, Lombardy with Piedmont, Sicily with Naples; but no one can agree on anything, even on the battle field. […] These suspicions, these universal jealousies have made Italy fail in favourable circumstances that perhaps will not be seen again for many years. L’accord n’est qu’une vague aspiration. Partout règne la division, et entre les sujets comme entre les princes, d’une province d’une ville à l’autre et jusqu’au sein d’une même cité. Rien ne s’y fait de ce qui demande des efforts collectifs. On a beaucoup parlé de fédérations et de ligues sans en former une seule. Vainement on a voulu -

The Seaplane Base Ivo Monti at S. Nicola Varano (Fg): a Monument of Military Archeology, Between History and Protection
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-5/W1, 2017 GEOMATICS & RESTORATION – Conservation of Cultural Heritage in the Digital Era, 22–24 May 2017, Florence, Italy THE SEAPLANE BASE IVO MONTI AT S. NICOLA VARANO (FG): A MONUMENT OF MILITARY ARCHEOLOGY, BETWEEN HISTORY AND PROTECTION F. Mariano a *, M. Saracco b **, L. Petetta a *** a Dept. Dicea, Marche Polytechnic University, Via Brecce Bianche 12, Ancona, Italy - [email protected], [email protected] b Dept. Sfbct, University of Macerata, P.le Luigi Bertelli 1, Macerata, Italy - [email protected] KEY WORDS: restoration, conservation, reuse, ruins, military archeology ABSTRACT: Built in the years between 1915 and 1918, and located on the west bank of the “Varano” Lake, a bay running along the village of “Cagnano Varano”, the “Ivo Monti” seaplane base was erected on a pre-existing medieval settlement which belonged to the Benedictine Monks from the town of “San Nicola Imbuti”. During WWI, this seaplane base was turned, from a simple water airport, into a strategic military base for floatplanes. As a matter of fact, the large lagoon could be used as landing spot for the planes sent off to patrol the dalmatic coast, one of the historical regions of Croatia, then controlled by the Austrians. After WWI, after the seaplane became an outdated technology, the “Ivo Monti” base was progressively dismantled and then totally abandoned at the beginning of the 1950s. In 2014, considering the historical relevance of this site and the unmistakable architectural value of its elements, a research framework agreement was signed between the “DICEA” Department of Marche Polytechnic University and the city council of the town hosting the site, aimed at the development of shared scientific research projects revolving around the study, the valorisation, and the restoration of the military complex in question, which had been in a complete state of decay and neglect for too long.