Senato Della Repubblica Camera Dei Deputati Xvi Legislatura
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sul Concetto Di “Contronome” in Gomorra Di Roberto Saviano
ONOMÀSTICA 4 (2018): 49–62 | RECEPCIÓ 7.1.2018 | ACCEPTACIÓ 27.7.2018 Sul conceto di “contronome” in Gomorra di Roberto Saviano Giacomo Giuntoli [email protected] Abstract: Nel 2006 Mondadori pubblica Gomorra, libro di Roberto Saviano che presto diventa un caso editoriale fnendo per varcare anche i confni nazionali. Alcuni fra gli aspeti a torto meno studiati di questo romanzo sono i nomi presenti in esso e un con- ceto che merita di essere con atenzione analizzato, quello di “contronome”, cioè il soprannome che gli afliati alle cosche mafose danno ai membri di spicco. Questo è un conceto fondamentale per comprendere la rifessione onomastica che sta alla base del libro di Saviano. L*obietivo di questo saggio è spiegare questo conceto complesso atraverso alcuni esempi sia onomastici che toponomastici come quelli di Francesco Schiavone, deto “Sandokan” o di Las Vegas, una zona degradata di Napoli Nord che prende il nome dalla famosa cità americana. Parole chiave: Roberto Saviano, onomastica leteraria, toponomastica, “contronome”, soprannome, leteratura italiana On the Concept of “Countername” in Roberto Saviano’s Gomorra Abstract: In 2006 Mondadori published Gomorra, a book by Roberto Saviano that soon became a literary sensation and thanks to which the young Italian writer became fa- mous all over the world. Some of the least studied aspects of this fction are prop- er names and a concept that deserves to be carefully analyzed, that of “contronome” (countername). “Contronome” refers to the nickname that the members of the mafa gangs used to give to their most important members. Tis is a fundamental concept to understand the onomastic refection that underlies Saviano’s book. -

La Criminalità Organizzata
La criminalità organizzata Dalle origini ai giorni nostri di Tiziana Terribile e Salvatore Tonti Primo dirigente della Polizia di Stato Vice questore aggiunto della Polizia di Stato Direttore Divisione analisi del Servizio centrale operativo Capo della II sezione della Divisione analisi con la prefazione di Francesco Gratteri Direttore della Direzione centrale anticrimine SOMMARIO Prefazione ....................................................................................................................................................................................................................6 1. La Mafia siciliana ................................................................................................................................................................................................8 2. La ‘Ndrangheta ...................................................................................................................................................................................................11 3. La Camorra ...........................................................................................................................................................................................................15 4. La criminalità mafiosa pugliese ..............................................................................................................................................................17 INSERTO DI POLIZIAMODERNA - maggio 2008 mensile ufficiale della polizia di stato me alla polizia scientifica -

Le Mani Della Criminalità Sulle Imprese, 2011
Le mani della criminalità sulle imprese XIII Rapporto di Sos Impresa Aliberti Editore SosImpresa.indd 5 09/11/11 12:18 © 2011 Aliberti editore Tutti i diritti riservati Sede legale: Via dei Cappuccini, 27 - 00187 Roma Sede operativa: Via Meuccio Ruini, 74 - 42124 Reggio Emilia Tel. 0522 272494 Fax 0522 272250 - Ufficio Stampa 329 4293200 Aliberti sul web: www.alibertieditore.it blog.alibertieditore.it [email protected] SosImpresa.indd 6 09/11/11 12:18 A Libero Grassi, nel ventennale della scomparsa SosImpresa.indd 7 09/11/11 12:18 SosImpresa.indd 8 09/11/11 12:18 Il Rapporto di Sos Impresa Le mani della criminalità sulle imprese è frutto di numerosi apporti e collaborazioni senza i quali non sarebbe stato possibile realizzarlo. Un ringraziamento particolare va a Danila Bellino, Laura Galesi, Massi- mo Giordano, Nino Marcianò, Marcello Ravveduto, Valeria Scafetta e Ga- briella Sensi. I testi sono di Lino Busà e Bianca La Rocca. I dati che forniamo sono nostre elaborazioni sulla base delle statistiche Istat, delle rilevazioni fornite dal Ministero dell’Interno, dei sondaggi condotti da Swg per Confesercenti, delle ricerche del Centro Studi TEMI e delle numerose informazioni e testimo- nianze raccolte da Sos Impresa. Il Rapporto come sempre contiene molti nomi di persone, aziende, luo- ghi. Nomi presenti nelle inchieste giudiziarie, nelle relazioni degli organismi antimafia e delle Forze dell’ordine, nelle cronache giornalistiche. Per tutti coloro che sono chiamati in causa, eccezion fatta per quelli condannati in via definitiva, valgono la presunzione d’innocenza e le garanzie individuali costituzionalmente garantite. 9 SosImpresa.indd 9 09/11/11 12:18 Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia Quali sono le ragioni dell’inaudita potenza di alcuni? Dov’è la forza che assicura l’impunità ai loro delitti? Si chiede se sono costituiti in associazio- ni, se hanno statuti, pene per punire i membri traditori: tutti rispondono che lo ignorano, molti che non lo credono. -

L'inferno Dei Viventi Non E` Qualcosa Che Sara`
Camera dei Deputati —8— Senato della Repubblica XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI INTRODUZIONE 1. Viaggio nell’inferno « L’inferno dei viventi non e` qualcosa che sara`; se ce n’e` uno, e` quello che e` gia` qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo piu` . Il secondo e` rischioso e esige attenzione e appren- dimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non e` inferno e farlo durare, e dargli spazio », cosı` Italo Calvino nelle sue « citta` invisibili ». Anche il vasto universo della camorra napoletana si presenta come un inferno e, quel che piu` conta, rende inferno tutto cio` su cui si dispiega e anche in questo caso vi sono due modi per non soffrirne: accettare l’inferno magari negativizzan- dolo in maniera assoluta, senza tentare di indagarne le sue articolate ramificazioni, oppure impegnarsi in una analisi specifica dei suoi tratti caratterizzanti, dei suoi nuclei essenziali, dei suoi nodi fondamentali, perche´ l’inferno sia sempre piu` ridotto e, in prospettiva, eliminato nella sua configurazione e, ancor piu` decisivamente, nelle sue cause. E` questa seconda opzione la scelta che appare necessaria ed urgente, una scelta che non e` solo necessaria ma anche possibile per la corrispondenza e l’alimento che essa certamente ritrova nelle grandi energie del popolo di Napoli e della Campania, nelle risorse anche culturali e morali della citta` e della regione, nelle ricche esperienze di rinnovamento di tante citta` e tanti comuni. -

Le Cosche Tornano a Colpire. Ucciso Il Sindaco Anti-Camorra
Questo è l'articolo scritto da Roberto Saviano dieci anni fa dopo il delitto del sindaco di Pollica Angelo Vassallo da la Repubblica del 5 settembre 2020 Le cosche tornano a colpire: ucciso il sindaco anti-camorra di ROBERTO SAVIANO DUE pistole che sparano, le pallottole che colpiscono al petto, un agguato che sembra essere anche un messaggio. Così uccidono i clan. Così hanno ucciso Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, in provincia di Salerno. Si muore quando si è soli, e lui - alla guida di una lista civica - si opponeva alle licenze edilizie, al cemento che in Cilento dilaga a scapito di una magnifica bellezza. Ma Angelo Vassallo rischia di morire per un giorno soltanto e di essere subito dimenticato. Come se fosse normale, fisiologico per un sindaco del meridione essere vittima dei clan. E invece è uno scandalo della democrazia. Del resto - si dice - è così che va nel sud, accade da decenni. «Veniamo messi sulla cartina geografica solo quando sparano. O quando si deve scegliere dove andare in vacanza», mi dice un vecchio amico cilentano. In questo caso le cose coincidono. Terra di vacanze, terra di costruzioni, terra di business edilizio che «il sindaco-pescatore» voleva evitare a tutti i costi. Questa estate è iniziata all' insegna degli slogan del governo sui risultati ottenuti nella lotta contro le mafie. Risultati sbandierati, urlati, commettendo il grave errore di contrapporre l' antimafia delle parole a quella dei fatti. Ma ci si deve rendere conto che non è possibile delegare tutto alle sole manette o al buio delle celle. Senza racconto dei fatti non c' è possibilità di mutare i fatti. -
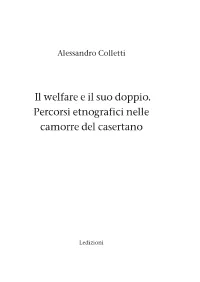
Il Welfare E Il Suo Doppio. Percorsi Etnografici Nelle Camorre Del Casertano
Alessandro Colletti Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Ledizioni © 2016 Ledizioni LediPublishing Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy www.ledizioni.it [email protected] Alessandro Colletti, Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Prima edizione: febbraio 2016 ISBN Cartaceo: 978-88-6705-426-8 Copertina e progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni I ricavi dai diritti d’autore saranno devoluti al Comitato Don Peppe Diana di Casal di Principe Indice Prefazione di Antonio La Spina 5 Introduzione 11 Metodi e fonti 17 Parte Prima. Un’analisi delle forme di egemonia delle mafie: tra controllo e assistenza 27 1. Il controllo territoriale nella storia delle camorre 29 Il riconoscimento istituzionale del potere camorrista 34 Il controllo territoriale nell’area campana 39 2. Forme organizzative e redistributive: la “cassa comune” 49 Le mafie come organizzazioni professionali 50 Il funzionamento della “cassa comune” 53 I capi cambiano, la struttura resta: dal “clan Bardellino-Iovine” al “clan dei casalesi” 63 3. La protezione sociale delle camorre casertane 73 Il clan La Torre 76 Il clan Belforte 82 I clan Schiavone e Bidognetti: alleati, federati, separati 89 Gerarchia e livelli stipendiali: il clan Schiavone 94 Forme di assistenza nei clan del casertano 101 Parte Seconda. Le politiche socio-assistenziali nella provincia di Caserta: un welfare (s)finito 113 1. Analisi delle forme di welfare pubblico: il sistema italiano 115 I territori del welfare: dallo Stato agli enti locali 118 Il livello territoriale dei servizi sociali 123 2. Zona di contatto: servizi alla persona nella provincia casertana 135 La dimensione territoriale dei servizi nella governance regionale 140 Uno sguardo alle pratiche locali di welfare nell’area casertana 143 Il welfare raccontato da chi lo dirige: le interviste ai coordinatori degli Uffici di Piano 148 3. -

Arrestato Il Boss Raccuglia «È Il Numero 2 Di Cosa Nostra»
14 www.unita.it LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2009 Italia p Corleonese è stato fermato nel territorio comandato da Matteo Messina Denaro p Latitante da 13 anni, ha tre ergastoli. Uno per la barbara uccisione di Santino Di Matteo Arrestato il boss Raccuglia «È il numero 2 di Cosa Nostra» Foto Ansa «Mimmo» ha finito la sua corsa ieri pomeriggio, poco dopo le 17,30 quando gli uomini della sezione Catturandi della Squa- dra Mobile di Palermo, insieme ai colleghi del Servizio centrale operativo, lo hanno fermato. DOMENICO VALTER RIZZO PALERMO [email protected] Gli stavano dietro da tredici anni, da quando aveva deciso di far per- dere le sue tracce e aveva scalato, uno ad uno, i gradini che lo han- no portato al vertice di Cosa no- stra e contemporaneamente an- che al vertice della classifica dei più pericolosi latitanti mafiosi. Un picciotto di rispetto che, a 43 anni, è diventato un capo. Dome- nico Raccuglia, detto «Mimmo» ha finito la sua corsa ieri pomerig- gio, poco dopo le 17,30 quando gli uomini della sezione Catturan- Un'immagine di archivio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Il figlio del pentito Santino, di della Squadra Mobile di Paler- mo, insieme ai colleghi del Servi- zio centrale operativo, lo hanno fonte e – anche grazie allo sgretola- tività», ma soprattutto è un perso- finalmente scovato, chiudendo mento del vecchio vertice corleone- naggio vicinissimo al boss trapane- così per sempre la sua latitanza. Il personaggio se, aveva esteso il suo potere in tut- se Matteo Messina Denaro, l’uomo Una caccia lunga, che nelle ulti- Il «veterinario» vicino to il territorio della provincia, ma considerato ormai il po l’arresto di me due settimane ha avuto un’ac- a Giovanni Brusca non solo, il suo ruolo oggi appare Provenzano e quindi dei Lo Picco- celerazione che ha portato gli in- infatti di maggiore livello rispetto lo. -

La Traduzione Di Gomorra, Dal Libro Al Film. Un'analisi Relativa a Italiano
Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Tjapke Van Quickenborne La traduzione di Gomorra, dal libro al film. Un’analisi relativa a italiano, francese e nederlandese. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in het Vertalen 2016 Promotor Prof. Dr. Manuela Caniato Vakgroep Vertalen Tolken Communicatie ABSTRACT Questo studio analizza la traduzione di due categorie di realia, cioè i soprannomi e i titoli, nelle versioni nederlandese e francese del libro Gomorra di Roberto Saviano e nei sottotitoli nederlandesi e francesi dell’omonimo film diretto da Matteo Garrone. In questa tesi si esamina quali sono le strategie traduttive utilizzate per la resa dei soprannomi e dei titoli e con quale frequenza esse vengono impiegate. L’individuazione delle strategie traduttive è basata sulla classificazione presentata da Pedersen (2011). L’analisi è basata su un corpus che contiene tutte le frasi e le loro traduzioni in nederlandese e francese in cui sono presenti soprannomi o titoli, sia nel film che nel libro. Oltre all’analisi quantitativa delle strategie traduttive, viene fatta anche un’analisi qualitativa di alcuni esempi. L’analisi dimostra principalmente che nella sottotitolazione l’omissione viene impiegata frequentemente per rendere i soprannomi e i titoli, sia in nederlandese che in francese. Nel libro invece ci sono maggiori differenze tra le due lingue. Nel caso dei soprannomi, la ritenzione è la strategia più frequentemente utilizzata in entrambe le lingue. Questo è anche il caso in nederlandese per la resa dei titoli onorifici e professionali, mentre in francese si opta più spesso per la sostituzione. Anche la strategia della traduzione diretta viene impiegata con una frequenza abbastanza alta in entrambe le lingue per la resa dei titoli. -

900-Criminale-2.0.Pdf
A cura dell’Associazione Lapsus 2 INDICE Prefazione 6. I riti della Mafia 1. Introduzione alla mostra 7. Gli anni settanta 7.1 POLITICA, CONFLITTI E MASSONERIA: LA 2. Italia liberale ‘NDRANGHETA SI ESPANDE 2.1 LE ORIGINI DELLA ‘NDRANGHETA: LA 7.2 L’ASCESA DELLA NUOVA CAMORRA PICCIOTTERIA CALABRESE ORGANIZZATA 2.2 LA BELLA SOCIETÀ RIFORMATA 7.3 LA CONQUISTA MAFIOSA DEL NARCOTRAFFICO 2.3 LA GENESI DELLA MAFIA: UN “CRIMINOSO 7.4 LEONARDO VITALE: IL PENTITO SODALIZIO” 2.4 UN OMICIDIO ECCELLENTE IL DELITTO 8. Pentitismo e Omertà NOTARBARTOLO 9. Gli anni ottanta 2.5 LA FINE DELLA BELLA CAMORRA 9.1 IL CONSOLIDAMENTO DEL POTERE 3. Il ventennio fascista ‘NDRANGHETISTA 3.1 ‘NDRANGHETA E FASCISMO: CONFLITTO E 9.2 IL CONFLITTO TRA NUOVA FAMIGLIA E NCO INTEGRAZIONE 9.3 L’ESCALATION DELLA VIOLENZA: LA SECONDA 3.2 IL “MAGGIORE DI FERRO” GUERRA DI MAFIA 3.3 LA MAFIA AI FERRI CORTI 9.4 IL TERREMOTO DEL 1980 IN CAMPANIA E IL 3.4 SBARCO ALLEATO SISTEMA DEGLI APPALTI 9.5 GIANCARLO SIANI 4. Il dopoguerra 4.1 L’ITALIA SCOPRE LA “‘NDRANGHITA” 10. Gli anni novanta 4.2 TRA CONTRABBANDO E AGGIOTAGGIO: LA 10.1 DA SAN LUCA A DUISBURG UN PRIMATO RINASCITA DELLA CAMORRA MONDIALE 4.3 TRA CITTÀ E CAMPAGNA: IL RIASSETTO DELLA 10.2 I NUOVI EQUILIBRI IN TERRA DI CAMORRA: MAFIA L’ASCESA DEI CASALESI 4.4 LA STRAGE DI PORTELLA DELLA GINESTRA 10.3 LE STRAGI DI MAFIA E L’AVVENTO DELLA 4.5 LA MAFIA “BUONA” SECONDA REPUBBLICA 10.4 IL MAXIPROCESSO 5. -

Preso Il Numero Due Di Cosa Nostra – S.Palazzolo – La Repubblica – 16-11-09
Tradito dalla tv. Nel suo rifugio di Calatafimi, in provincia di Trapani. Nel suo rifugio trovati pizzini e 100mila euro Preso il numero due di Cosa nostra – S.Palazzolo – La Repubblica – 16-11-09 Raccuglia era latitante dal 1996 PALERMO - Domenico Raccuglia, il padrino che ha ereditato i segreti finanziari di Bernardo Provenzano, si nascondeva in una stanza al buio di una vecchia palazzina a 4 piani di Calatafimi, provincia di Trapani. Ma non rinunciava ai talk-show della domenica. La televisione ha tradito il boss che polizia e carabinieri cercavano dal 1996, da quando faceva da carceriere, per ordine di Giovanni Brusca, al figlio tredicenne del pentito Santino Di Matteo. Per giorni quella palazzina di Calatafimi era apparsa disabitata ai poliziotti della Catturandi della squadra mobile di Palermo e ai colleghi del Servizio centrale operativo. Eppure, le indagini portavano tutte lì, in via del Cabbasino 20. Ieri pomeriggio, poco dopo le 17, i padroni di casa sono entrati e usciti velocemente. Poi, di nuovo tutto buio. Qualche attimo dopo, un televisore si è acceso al quarto piano. Ed è stata la conferma attesa da giorni. Il blitz è scattato mezz'ora dopo, quando da Palermo è arrivato il via libera del procuratore aggiunto Antonio Ingroia e dei sostituti Roberta Buzzolani e Francesco Del Bene. Mimmo Raccuglia ha lanciato uno zaino dalla finestra, ha impugnato il revolver e ha tentato una fuga sui tetti, ma non ha avuto scampo. Al suo arrivo in questura è stato accolto dagli slogan antimafia dei giovani di Addiopizzo. È finita così la latitanza del boss che il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso definisce "il numero due, per peso criminale, nella lista dei ricercati di Cosa nostra, dopo Matteo Messina Denaro". -

Oklahoma Property Developer Sent to Prison for Money Laundering - 29 December 2011
Oklahoma property developer sent to prison for money laundering - 29 December 2011 Derek Swann, a property developer in Oklahoma, has been sentenced to 40 months in prison for money laundering. Swann and his business partner Giovanni Stinson used false information to solicit investors for “The Falls”, their proposed commercial and residential development. According to the prosecution: “From 2006 to 2008, individuals invested more than US$5 million [about £3.2 million] into The Falls based on promises made by Swann. Swann then used investors’ monies for reasons different from what he told them: rather than paying for engineering, architectural or infrastructure costs... Swann used the investments for personal expenses and repayment of earlier investors.” Among the personal expenses cited, Swann and Stinson paid for golf and meals at the Oklahoma City Golf Club and leased BMW cars. The Falls was never completed. In February 2011, Swann admitted misusing some of the $255,000 put into the project by a Texan investor, and has been ordered to pay more than $4.3 million in restitution to more than two dozen investors. Stinson is awaiting sentencing after pleading guilty earlier this year to conspiracy to commit securities fraud. Back to top of page Australian executive to be extradited to the UK to face charges of corruption and money laundering - 29 December 2011 Bruce Hall, an Australian former aluminium executive, will be extradited to the UK to face charges of corruption and money laundering charges related to Alcoa’s sale of Australian alumina to Bahrain. Hall was arrested at his home in New South Wales on 20 October 2011 as part of an investigation by the Serious Fraud Office into millions of dollars allegedly paid by Alcoa to gain aluminium contracts. -

Verbali Della Commissione Parlamentare Antimafia
<pre>CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA XI LEGISLATURA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI 51 SEDUTA DI MARTEDI' 13 LUGLIO 1993 Pagina 2217 (AUDIZIONE DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA PASQUALE GALASSO) PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE INDICE pag. Audizione del collaboratore di giustizia Pasquale Galasso: Violante Luciano, Presidente 2223, 2224, 2225 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326 2327 2328, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2340, 2343 2344, 2347, 2350, 2351, 2352 Bargone Antonio 2244, 2333 2334, 2335 Boso Erminio Enzo 2342, 2343 Borghezio Mario 2248, 2343, 2344, 2345 Brutti Massimo 2329, 2330 Butini Ivo 2330 Cabras Paolo 2229, 2239, 2243 2244, 2261 2265, 2269, 2293, 2297, 2299, 2300, 2309, 2310, 2312 2314, 2318, 2321, 2327, 2328, 2329, 2345, 2346, 2347 Cafarelli Francesco 2335, 2336 Calvi Maurizio 2298, 2329, 2350, 2351 Florino Michele 2332, 2348, 2349 Frasca Salvatore 2307, 2311, 2315, 2331 Galasso