"CETERO PER ORAM OPPIDA a NESACTIO" (Plin., Nat
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vladimir-Peter-Goss-The-Beginnings
Vladimir Peter Goss THE BEGINNINGS OF CROATIAN ART Published by Ibis grafika d.o.o. IV. Ravnice 25 Zagreb, Croatia Editor Krešimir Krnic This electronic edition is published in October 2020. This is PDF rendering of epub edition of the same book. ISBN 978-953-7997-97-7 VLADIMIR PETER GOSS THE BEGINNINGS OF CROATIAN ART Zagreb 2020 Contents Author’s Preface ........................................................................................V What is “Croatia”? Space, spirit, nature, culture ....................................1 Rome in Illyricum – the first historical “Pre-Croatian” landscape ...11 Creativity in Croatian Space ..................................................................35 Branimir’s Croatia ...................................................................................75 Zvonimir’s Croatia .................................................................................137 Interlude of the 12th c. and the Croatia of Herceg Koloman ............165 Et in Arcadia Ego ...................................................................................231 The catastrophe of Turkish conquest ..................................................263 Croatia Rediviva ....................................................................................269 Forest City ..............................................................................................277 Literature ................................................................................................303 List of Illustrations ................................................................................324 -
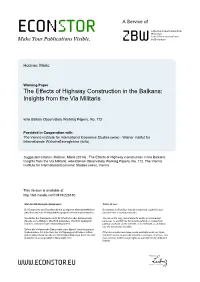
The Effects of Highway Construction in the Balkans: Insights from the Via Militaris
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Holzner, Mario Working Paper The Effects of Highway Construction in the Balkans: Insights from the Via Militaris wiiw Balkan Observatory Working Papers, No. 112 Provided in Cooperation with: The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw) - Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) Suggested Citation: Holzner, Mario (2014) : The Effects of Highway Construction in the Balkans: Insights from the Via Militaris, wiiw Balkan Observatory Working Papers, No. 112, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw), Vienna This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/226150 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents -

Ovdje Riječ, Ipak Je to Po Svoj Prilici Bio Hrvač, Što Bi Se Moglo Zaključiti Na Temelju Snažnih Ramenih I Leđnih Mišića
HRVATSKA UMJETNOST Povijest i spomenici Izdavač Institut za povijest umjetnosti, Zagreb Za izdavača Milan Pelc Recenzenti Sanja Cvetnić Marina Vicelja Glavni urednik Milan Pelc Uredništvo Vladimir P. Goss Tonko Maroević Milan Pelc Petar Prelog Lektura Mirko Peti Likovno i grafičko oblikovanje Franjo Kiš, ArTresor naklada, Zagreb Tisak ISBN: 978-953-6106-79-0 CIP HRVATSKA UMJETNOST Povijest i spomenici Zagreb 2010. Predgovor va je knjiga nastala iz želje i potrebe da se na obuhvatan, pregledan i koliko je moguće iscrpan način prikaže bogatstvo i raznolikost hrvatske umjetničke baštine u prošlosti i suvremenosti. Zamišljena je Okao vodič kroz povijest hrvatske likovne umjetnosti, arhitekture, gradogradnje, vizualne kulture i di- zajna od antičkih vremena do suvremenoga doba s osvrtom na glavne odrednice umjetničkog stvaralaštva te na istaknute autore i spomenike koji su nastajali tijekom razdoblja od dva i pol tisućljeća u zemlji čiji se politički krajobraz tijekom povijesnih razdoblja znatno mijenjao. Premda su u tako zamišljenom povijesnom ciceroneu svoje mjesto našli i najvažniji umjetnici koji su djelovali izvan domovine, žarište je ovog pregleda na umjetničkoj baštini Hrvatske u njezinim suvremenim granicama. Katkad se pokazalo nužnim da se te granice preskoče, odnosno da se u pregled – uvažavajući zadanosti povijesnih određenja – uključe i neki spomenici koji su danas u susjednim državama. Ovaj podjednako sintezan i opsežan pregled djelo je skupine uvaženih stručnjaka – specijalista za pojedina razdoblja i problemska područja hrvatske -

Map 20 Pannonia-Dalmatia Compiled by P. Kos and M. Šašel Kos, 1995
Map 20 Pannonia-Dalmatia Compiled by P. Kos and M. Šašel Kos, 1995 Introduction The map covers very heterogeneous landscapes ranging from the Adriatic coast to the Alps, and from the mountainous interiors of the provinces of Dalmatia and Pannonia with their rich ore sources to the Pannonian plain. The current state of research–to some degree reflected by the map–is uneven. Thus the Carinthian province of Austria (Piccottini 1989), Slovenia (ANSl 1975), and Bosnia and Herzegovina (ALBiH) are better explored topographically than other regions where no compilations of archaeological sites have been published. The results of topographical research conducted over the past thirty years by Bojanovski (1988) are of great importance. Much antiquarian and topographic information has been collected for Histria and Venetia by Vedaldi Iasbez (1994), with particular attention to Greek and Latin writers. Similarly substantial collection and assessment of data for the Dalmatian coast and islands are provided by Kozličić (1990). TIR Tergeste (1961), TIR Aquincum (1968) and TIR Naissus (1976) are also of value for the areas they cover, though not always reliable. Mócsy’s work (RE Suppl. 9 Pannonia) remains fundamental for the province of Pannonia. As Kozličić (1986) has shown, since antiquity geomorphological changes along the Dalmatian and Istrian coasts have been minimal, if only because no very large rivers flow into the Adriatic; the map therefore retains the modern coastline. The coast of the eastern Adriatic is, however, sinking at a minimal rate annually (Šegota 1976). Geographic names by no means always appear in the nominative in the Greek and Latin sources; the point applies especially to ItAnt, ItBurd, TabPeut and GeogRav, which often represent the only evidence. -
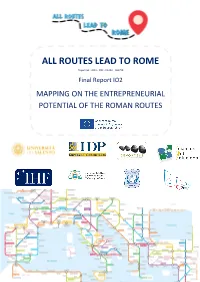
Download IO2 Final Report
ALL ROUTES LEAD TO ROME Project ref.: 2019 - IT02 - KA203 – 062798 Final Report IO2 MAPPING ON THE ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF THE ROMAN ROUTES a a a With the support of the Erasmus+ programme of the European Union. This document and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Content Content..................................................................................................................................... 2 1. Introduction ...................................................................................................................... 6 1.1. Grounding: Secondary Research ................................................................................ 6 1.2. Involvement: Primary Research ................................................................................. 7 2. The Sample ....................................................................................................................... 8 2.1. Descriptives ............................................................................................................... 8 2.2. The Roman Routes Questionnaire ............................................................................ 11 2.3. Results ..................................................................................................................... 12 2.4. Conclusions ............................................................................................................ -

From the 7Th Scientific Conference Methodology and Archaeometry
THINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE METHODOLOGY & ARCHAEOMETRY 07nd rd Zagreb, 2 ‒ 3 December 2019 PROCEEDINGS FROM THE 7TH SCIENTIFIC CONFERENCE METHODOLOGY AND ARCHAEOMETRY ISSN 2718-2916 2 METHODOLOGY & ARCHAEOMETRY 07 • INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE • PROCEEDINGS IMPRESSUM PUBLISHER Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb FOR THE PUBLISHER Miljenko Šimpraga EDITOR Ina Miloglav Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb EDITORIAL BOARD Predrag Novaković Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia Dimitrij Mlekuž Faculty of Arts, University of Ljubljana & Centre for preventive archaeology, Ljubljana, Slovenia Michela Spataro The British Museum, London, United Kingdom Duska Urem-Kotsou Democritus University of Thrace, Komotini, Greece Jasna Vuković Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia Rajna Šošić Klindžić Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia Jacqueline Balen Archaeological Museum in Zagreb, Croatia DESIGN & DTP Srećko Škrinjarić All papers were reviewed in the peer review process in which the identity of both reviewers and authors, as well as their institutions, are respectfully concealed from both parties. DOI https://doi.org/10.17234/METARH.2020 ISSN 2718-2916 Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb URL https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/series/MetArh http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/ Publishing of this e-book is supported by Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia This publication is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) which allows others to share, copy and redistribute the publication in any medium or format, as long as they give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. -

Your Name Your
Vedran Bileta ON THE FRINGES OF THE SHRINKING EMPIRE THE MILITARIZATION OF ADMINISTRATION AND SOCIETY IN BYZANTINE HISTRIA MA Thesis in Medieval Studies CEU eTD Collection Central European University Budapest May 2010 i CEU eTD Collection ii ON THE FRINGES OF THE SHRINKING EMPIRE THE MILITARIZATION OF ADMINISTRATION AND SOCIETY IN BYZANTINE HISTRIA by Vedran Bileta (Croatia) Thesis submitted to the Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, in partial fulfillment of the requirements of the Master of Arts degree in Medieval Studies Accepted in conformance with the standards of the CEU ____________________________________________ Chair, Examination Committee ____________________________________________ Thesis Supervisor CEU eTD Collection ____________________________________________ Examiner ____________________________________________ iii Examiner Budapest May 2010 CEU eTD Collection iv ON THE FRINGES OF THE SHRINKING EMPIRE THE MILITARIZATION OF ADMINISTRATION AND SOCIETY IN BYZANTINE HISTRIA by Vedran Bileta (Croatia) Thesis submitted to the Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, in partial fulfillment of the requirements of the Master of Arts degree in Medieval Studies Accepted in conformance with the standards of the CEU ____________________________________________ External Examiner CEU eTD Collection Budapest May 2010 v ON THE FRINGES OF THE SHRINKING EMPIRE THE MILITARIZATION OF ADMINISTRATION AND SOCIETY IN BYZANTINE HISTRIA by Vedran Bileta (Croatia) Thesis submitted to -

Alessio De Bon
ALESSIO DE BON 1. MANOSCRITTI E DATTILOSCRITTI busta 1 Quaderno manoscritto n. 1, docc. 1 (1) Quaderno rilegato manoscritto di 288 pagine: 26 pagine non numerate in testa, poi numerazione 1-259 fascicolo con quaderno rilegato Contiene testi, disegni e mappe manoscritti, e ritagli di fogli IGM; molte pagine lasciate bianche o solamente con intitolazione Quaderno manoscritto n. 2, docc. 1 (2) Quaderno rilegato manoscritto di 109 carte non numerate; intitolazione manoscritta sul recto della carta 1: "Alessio de-Bon / Prime note per lo studio generale / della via romana Claudia Augusta / Altinate (Adriatico - Val Drava) / per conto del R. Istituto / Veneto di Scienze Lettere / e Arti (Venezia) / Volume Secondo / Oderzo Feltre Trento" fascicolo con quaderno rilegato Contiene testi, disegni e mappe manoscritti, ritagli di fogli IGM e fotografie; alcune pagine lasciate bianche o solamente con intitolazione; alcune pagine presentano numerazione errata; iscrizione sulla costola: "A. de Bon / Claudia / Altinate / II / Oderzo / Feltre / Trento"; contiene disegni a carattere fantastico e ritratti slegati dalla trattazione Quaderno manoscritto n. 3, docc. 1 (3) Quaderno rilegato manoscritto di 219 carte numerate in modo errato (3-225); intitolazione manoscritta sul recto della carta 1: "Alessio de-Bon / Le strade consolari / nella Vicenza / Vicenza XVIII" fascicolo con quaderno rilegato Nella numerazione mancano le carte 7, 13, 37, 91, 124, 125, 162, 183, 186, 204, 206, 216; doppie le carte 8, 72, 136, 213, 225; 3 carte non numerate in testa, contenenti titolo ed indice degli itinerari; frequenti pagine o carte lasciate bianche o solamente con intitolazione; iscrizione sulla costola: "Vie Romane / X / Regio" 1940 Quaderno manoscritto n. -

The Original Documents Are Located in Box 16, Folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R
The original documents are located in Box 16, folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library. Copyright Notice The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material. Gerald R. Ford donated to the United States of America his copyrights in all of his unpublished writings in National Archives collections. Works prepared by U.S. Government employees as part of their official duties are in the public domain. The copyrights to materials written by other individuals or organizations are presumed to remain with them. If you think any of the information displayed in the PDF is subject to a valid copyright claim, please contact the Gerald R. Ford Presidential Library. Digitized from Box 16 of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library 792 F TO C TATE WA HOC 1233 1 °"'I:::: N ,, I 0 II N ' I . ... ROME 7 480 PA S Ml TE HOUSE l'O, MS • · !? ENFELD E. • lt6~2: AO • E ~4SSIFY 11111~ TA, : ~ IP CFO D, GERALD R~) SJ 1 C I P E 10 NTIA~ VISIT REF& BRU SE 4532 UI INAl.E PAL.ACE U I A PA' ACE, TME FFtCIA~ RESIDENCE OF THE PR!S%D~NT !TA y, T ND 0 1 TH HIGHEST OF THE SEVEN HtL.~S OF ~OME, A CTENT OMA TtM , TH TEMPLES OF QUIRl US AND TME s E E ~oc T 0 ON THIS SITE. I THE CE TER OF THE PR!SENT QU?RINA~ IAZZA OR QUARE A~E ROMAN STATUES OF C~STOR .... -

Als PDF Herunterladen
Namen und Daten : Beobachtungen zur Geschichte des römischen Strassenbaus Autor(en): Radke, Gerhard Objekttyp: Article Zeitschrift: Museum Helveticum : schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft = Revue suisse pour l'étude de l'antiquité classique = Rivista svizzera di filologia classica Band (Jahr): 24 (1967) Heft 4 PDF erstellt am: 06.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-20429 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich -

Flora Von Istrien“, Teil I
Joannea Botanik 12: 9–95 (05) Notizen zur „Flora von Istrien“, Teil I Walter K. ROTTENSTEINER Zusammenfassung: 9 Mitarbeiter haben insgesamt 458 Belege (+ 47 Dubletten) aus dem „Herbarium Istriacum“ (KL) und 118 Belege aus anderen, 5 öffentlichen (GJO, GZU, KL, TSB, WHB) und 4 privaten Herbarien (Herb. F. Essl, A-Wien; Herb. W. Guter- mann, A-Wien; Herb. P. Pilsl, A-Salzburg; Herb. H. Zwander, A-Köttmannsdorf) revi- diert. Die Dubletten aus dem Herbarium Istriacum werden an öffentliche Institu- tionen (B, BKF, CL, CLF, GJO, GOET, GZU, IBF, JACA, KRA, LE, LG, LI, LJU, M, MA, MBM, NY, OLD, OSC, PE, PRA, R, SAV, TBI, TK, UBC, US, W, WHB, WU, Z, ZA) und an private Herbarium (Herb. D. Koriakov, RU-Novosibirsk; Herb. J.-P. Reduron, F-Mülhau- sen) verteilt. Als neue Taxa für Istrien werden an dieser Stelle erstmals genannt: Achil lea crithmifolia, Epilobium ×confine, Epilobium ×persicinum nsubsp. persicinum (auch neu für Kroatien!), E . ×subhirsutum, Fumaria judaica subsp. judaica, Ophrys apifera × O . tetraloniae (auch neu für Italien!), Rorippa ×anceps, Rumex cristatus (auch neu für Kroatien!), Scrophularia umbrosa, Verbascum ×incanum (auch neu für Kroatien!), Verbascum ×lemenciacum (auch neu für Slowenien!) und Veronica serpyllifolia subsp. humifusa. – Chamaecytisus polytrichus, Glechoma hederacea var. villosa, Inula ×rigida, Ranunculus bulbosus und Rumex thyrsiflorus sind neu für die Insel Vögls. – Bombycilaena erecta, Ranunculus neapolitanus und Ranunculus sardous sind neu für die Insel Plaunig. -

LE VIE TRANSALPINE (Completo)
LE VIE TRANSALPINE (completo) …”Alpes e regione ea quae proxima est Hadriano mari ad Tuscum pacificavi nulli bello per iniuriam inlato”… (Res gestae Divi Augusti, XXVI, III) Introduzione: Le Alpi sono costituite da un corrugamento della superficie terrestre a forma di semicerchio che a partire dal Colle di Cadibona, a ridosso del Mar Ligure, corre verso ovest quindi si incurva verso nord e poi verso est fino ad attenuarsi con i Carpazi e le Alpi Dinariche nelle pianure orientali dell'Europa e nei Balcani. Questo grande corrugamento è caratterizzato da serie di valli trasversali, coronate da picchi rocciosi di notevole altezza, le comunicazioni dalla penisola italiana verso l'Europa, in qualsiasi direzione esse siano rivolte, devono negoziare queste creste rocciose. Il punto più stretto della catena alpina, verso il nord ovest della Pianura Padana, è il punto più facile da traversare e il più prossimo il linea d'aria al Mare del Nord, per questo motivi è qui che esistono i passi stradali più antichi della catena alpina: il passo dell'Alpis Graia (o Piccolo San Bernardo) e quello dell'Alpis Poenina (o Gran San Bernardo). Quelle che sono ovvie conclusioni risultanti da semplici osservazioni di carte geografiche, vengono ora confermate da recenti ricerche e studi di materiali archeologici effettuati nella Francia occidentale, nella valle del Rodano della Svizzera e nella Valle d'Aosta. Regolari comunicazioni attraverso questo settore della barriera alpina sembrano attestate almeno fin dal III millennio. Addirittura si parla di "una remota via di colonizzazione e di trasmissione di elementi culturali ed economici" (R.Mollo Mezzena, 1991).