Tortona E Viguzzolo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deliberazione Della Giunta Regionale 1 Marzo 2019, N. 26-8491
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 26-8491 Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL AL entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico di assistenza primaria. A relazione del Presidente Chiamparino: Visto l’art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell’assistibile, nei limiti oggettivi dell’organizzazione sanitaria; visto l’art. 33, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN MMG) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti; dato atto che attualmente l’ASL AL è articolata in 4 Distretti qui di seguito elencati: • Distretto di Acqui Terme-Ovada (risultante dalla fusione dell’ ex Distretto di Acqui -Terme con l’ ex Distretto di Ovada); • Distretto di Alessandria-Valenza (risultante dalla fusione dell’ ex Distretto di Alessandria con l’ ex Distretto di Valenza); • Distretto di Casale Monferrato; • Distretto di Novi Ligure- Tortona (risultante dalla fusione dell’ ex Distretto di Novi Ligure con l’ ex Distretto di Tortona); preso atto della deliberazione n. 782 del 28 novembre 2018, a firma del Direttore Generale dell'ASL AL (agli atti della Direzione Sanità, Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR) nella quale viene posto in evidenza che: a) con legge regionale n. 4 del 5 aprile 2017 è stato istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, il Comune di Cassano Spinola , afferente il Distretto di Novi Ligure-Tortona, risultante dalla fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana; b) con legge regionale n. -

Sub Ambito 01 – Alessandrino Istat Comune 6003
SUB AMBITO 01 – ALESSANDRINO ISTAT COMUNE 6003 ALESSANDRIA 6007 ALTAVILLA MONFERRATO 6013 BASSIGNANA 6015 BERGAMASCO 6019 BORGORATTO ALESSANDRINO 6021 BOSCO MARENGO 6031 CARENTINO 6037 CASAL CERMELLI 6051 CASTELLETTO MONFERRATO 6052 CASTELNUOVO BORMIDA 6054 CASTELSPINA 6061 CONZANO 6068 FELIZZANO 6071 FRASCARO 6075 FRUGAROLO 6076 FUBINE 6078 GAMALERO 6193 LU E CUCCARO MONFERRATO 6091 MASIO 6105 MONTECASTELLO 6122 OVIGLIO 6128 PECETTO DI VALENZA 6129 PIETRA MARAZZI 6141 QUARGNENTO 6142 QUATTORDIO 6145 RIVARONE 6154 SAN SALVATORE MONFERRATO 6161 SEZZADIO 6163 SOLERO 6177 VALENZA SUB AMBITO 02 – CASALESE ISTAT COMUNE 6004 ALFIANO NATTA 6011 BALZOLA 6020 BORGO SAN MARTINO 6023 BOZZOLE 6026 CAMAGNA 6027 CAMINO 6039 CASALE MONFERRATO 6050 CASTELLETTO MERLI 6056 CELLA MONTE 6057 CERESETO 6059 CERRINA MONFERRATO ISTAT COMUNE 6060 CONIOLO 6072 FRASSINELLO MONFERRATO 6073 FRASSINETO PO 6077 GABIANO 6082 GIAROLE 6094 MIRABELLO MONFERRATO 6097 MOMBELLO MONFERRATO 5069 MONCALVO 6099 MONCESTINO 6109 MORANO SUL PO 6113 MURISENGO 6115 OCCIMIANO 6116 ODALENGO GRANDE 6117 ODALENGO PICCOLO 6118 OLIVOLA 6120 OTTIGLIO 6123 OZZANO MONFERRATO 6131 POMARO MONFERRATO 6133 PONTESTURA 6135 PONZANO MONFERRATO 6149 ROSIGNANO MONFERRATO 6150 SALA MONFERRATO 6153 SAN GIORGIO MONFERRATO 6159 SERRALUNGA DI CREA 6164 SOLONGHELLO 6171 TERRUGGIA 6173 TICINETO 6175 TREVILLE 6178 VALMACCA 6179 VIGNALE MONFERRATO 6182 VILLADEATI 6184 VILLAMIROGLIO 6185 VILLANOVA MONFERRATO SUB AMBITO 03 – NOVESE TORTONESE ACQUESE E OVADESE ISTAT COMUNE 6001 ACQUI TERME 6002 ALBERA LIGURE 6005 -

Tasselli Di Cultura...Castelli, Palazzi E Dimore Storiche
AVVERTENZA Foreword Le schede dei siti e dei monumenti presenti su questa pubblicazione sono suddivise, attraverso l’utilizzo di colori diversi, per area geografica di appartenenza (zone di Acqui Terme – Ovada, Alessandria, Casale Monferrato – Valenza, Novi Ligure – Tortona); all’interno di ogni sezione gli articoli sono ordinati alfabeticamente per Comune di ubicazione dell’opera. All’interno della copertina è riportata una pratica legenda di tutti i simboli utilizzati. The pages of the sites and buildings in this publication are divided up by colour codes for each area (Acqui Terme – Ovada, Alessandria, Casale Monferrato – Valenza, Novi Ligure – Tortona); inside each section the sites are listed alphabetically according to the local town or village. On the inside cover is a key detailing all the symbols used. Recapiti Addresses Giorni e orario di apertura - Timetable; Condizioni ❼ domenica o di ingresso giorno festivo Conditions ❼ Sunday or of entrance holidays Modalità di pagamento Tickets Servizi Services COME-DOVE-QUANDO HOW-WHERE-WHEN In Piemonte, ad un’ora dedicarsi ad attività spor- In Piedmont, just an through tradition, art, di viaggio da Milano, Torino tive all’aria aperta. Autunno hour’s drive from Milan, food, wine and the spa e Genova e poco più ed inverno, invece, sono i Turin and Genoa, not far waters. Spring and distante dai confini con la mesi prediletti dai buongu- from the borders with summer Francia e la Svizzera, tra le stai che potranno assapo- France and are the Alpi ed il Mar Ligure, c’è la rare, in abbinamento ai Switzerland and best times provincia di Alessandria, pregiati vini, i prestigiosi between the Alps to che rappresenta uno dei “frutti” del territorio: tartufi, and the cuori culturali, artistici ed funghi, castagne, nocciole. -

Novembre 2015 Nei Loca- L’Inaugurazione È Prevista Li Della Biblioteca (Numero Minimo Di 10 in Occasione Della Fiera, Partecipanti)
Appuntamenti Le iniziative del primo novembre Biblioteca n occasione dei festeg- Igiamenti della ricorrenza La mostra al castello I CORSI DA SEGUIRE nazionale del 4 Novembre, Avviati i corsi di inglese e di informatica, che si terranno dome- sono ancora aperte le iscrizioni per due nica 1° novembre, sarà “Il Piave mormorò” corsi: uno di lingua spagnola e uno di foto- inaugurata nel castello grafia entrambi organizzati nell’ambito del- podestarile una mostra la programmazione della biblioteca. dedicata alla Prima Guerra Corso di spagnolo Mondiale dal titolo “Il Piave Livello base e intermedio della durata di mormorò”. Un percorso di un’ora e mezza con nozioni di gramma- conoscenza e di studio at- tica e conversazione con insegnante ma- traverso documenti (alcuni drelingua. inediti), ricordi, cartoline, Il corso si svolge nella serata di giovedì immagini e divise. con inizio il 5 novembre 2015 nei loca- L’inaugurazione è prevista li della Biblioteca (numero minimo di 10 in occasione della Fiera, partecipanti). domenica 1° novembre Corso di fotografia alle ore 17 in castello. Corso indicato per chiunque volesse af- finare le proprie capacità ma anche per i fotoamatori alle prime armi che volessero La Fiera Notizie migliorare o imparare a usare al meglio la propria fotocamera o anche il cellulare. L’AISM ringrazia Si svolge nella serata di martedì; prima le- Le mele sono scese in piazza sabato 10 e domenica 11 dar Carsént zione martedì 1° dicembre alle ore 21 nei ottobre e ben 58 persone hanno aderito alla iniziativa. itorna il 1° novembre, domenica, la Fie- locali della Biblioteca (numero minimo di 5 Filippo Rossi, Cristina Pani e Nicolò Maimone ringraziano, Rra dar Carsent. -

Comune Di SAREZZANO DOCUMENTO UNICO DI
Comune di SAREZZANO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 Allegato alla deliberazione C.C. n. 21 del 19-07-2017 Sommario PREMESSA _____________________________________________________________________ 5 INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) _____________________ 6 SEZIONE STRATEGICA (SeS) _____________________________________________________________ 9 Ses - Analisi delle condizioni esterne_______________________________________________________9 1. Obiettivi individuati dal Governo ___________________________________________________ 9 2. Valutazione della situazione socio economica del territorio _____________________________ 10 Popolazione _________________________________________________________________ 10 Territorio____________________________________________________________________ 11 Strutture operative ____________________________________________________________ 12 Economia insediata ___________________________________________________________ 13 3. Parametri economici ____________________________________________________________ 14 SeS – Analisi delle condizioni interne ____________________________________________________ 16 1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali __________________________ 16 Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate _____________ 16 2. Indirizzi generali di natura strategica _______________________________________________ 18 a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche ___________________________________ 18 b. I programmi -

Cubotank Da Lt 1.000 Comuni Ove Sono Stati Ubicati I Cubotank Da 1.000 Lt
PROGETTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DI OLI VEGETALI ESAUSTI PRODOTTI DALLE FAMIGLIE Dal 1911 CuboTank da lt 1.000 Comuni ove sono stati ubicati i cubotank da 1.000 lt. per la raccolta degli oli vegetali domestici Acqui Terme Albera Ligure Castellazzo Bormida Francavilla Bisio Fresonara Gavazzana Grondona Novi Ligure Ovada Parodi Ligure Predosa Tortona Fusti da lt 100 Comuni ove sono stati ubicati i fusti per la raccolta degli oli vegetali domestici Acqui Terme Casalnoceto Gavazzana Ovada Silvano D’Orba Albera Ligure Casasco Gavi Paderna Spigno Monferrato Alice Bel Colle Cassano Spinola Gremiasco Parodi Ligure Spineto Scrivia Alluvioni Cambiò Cassine Grognardo Pasturana Stazzano Alzano Scrivia Cassinelle Grondona Pontecurone Strevi Arquata Scrivia Castellania Guazzora Ponti Tassarolo Avolasca Castellania Isola Sant’Antonio Ponzone Terzo Basaluzzo Castellar Guidobono Melazzo Pozzolo Formigaro Tortona Belforte Monferrato Castellazzo Bormida Merana Prasco Trisobbio Berzano di Tortona Castelletto d’Erro Molare Ricaldone Vignole Borbera Bistagno Castelletto D’Orba Molino dei Torti Rivalta Bormida Viguzzolo Borghetto di Borbera Castelnuovo Scrivia Momperone Rocca Grimalda Villaromagnano Bosio Cavatore Monleale Roccaforte Ligure Villalvernia Brignano Frascata Cerreto Grue Montaldeo Rocchetta Ligure Visone Cabella Ligure Costa Vescovato Montaldo Bormida Sale Volpedo Cantalupo Ligure Cremolino Montechiaro d’Acqui San Cristoforo Volpeglino Capriata D’Orba Denice Montegioco San Sebastiano Curone Voltaggio Carbonara Scrivia Dernice Montemarzino Sant’Agata Fossili Carezzano Fabbrica Curone Morbello Sardigliano Carpeneto Fresonara Morsasco Sarezzano Cartosio Garbagna Orsara Bormida Serravalle Scrivia Contenitori ubicati presso le scuole primarie COMUNI CONTENITORI CONFERITI Bistagno 100 lt. Bosio 100 lt. Carbonara Scrivia 100 lt. Cartosio 100 lt. Garbagna 50 lt. Gavi 100 lt. Gremiasco 100 lt. -

Piano Neve 2018/2019
PROVINCIA DI ALESSANDRIA Direzione Viabilità 1 e Trasporti PIANO NEVE 2018/2019 Linee Guida Direzione Viabilità 1 e Trasporti luglio 2018 La Provincia di Alessandria, in qualità di ente proprietario, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 285/92 Nuovo Codice della Strada, provvede, con le risorse assegnate alla Direzione Viabilità, alla manutenzione, alla gestione, alla pulizia ed al controllo tecnico delle strade, nonché all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. La Provincia di Alessandria può anche, ai sensi dell’art. 6 del Dlgs 285/92 Nuovo Codice della Strada, con ordinanza, disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione per motivi d’incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti la tutela del patrimonio strade o ad esigenze di carattere tecnico. Tra le attività di cui al sopraccitato art. 14 sono da ricomprendersi anche quelle di manutenzione invernale (trattamento preventivo antighiaccio e trazione neve) delle strade di competenza. In considerazione di eventi particolarmente gravosi, può inoltre trovare applicazione quanto disposto dal sopra richiamato art. 6. La Direzione Viabilità ha quindi predisposto il presente Piano Neve, con il quale si stabiliscono le modalità operative comunicate ai Capi Reparto, ai Capi Cantonieri, ai Cantonieri ed a tutto il personale tecnico della Direzione per affrontare gli interventi di viabilità invernale. Questa attività, oltre che con mezzi e personale della Provincia, è svolta soprattutto attraverso l’impiego di Ditte esterne che, secondo opportune disposizioni contrattuali, effettuano sia i trattamenti preventivi antighiaccio, sia lo sgombero neve. Si precisa che come “personale tecnico della Provincia preposto al controllo delle attività di manutenzione invernale” sono da considerarsi: i Capi Cantonieri, i Capi Reparto, i Dirigenti di Direzione. -

Castelli Da Fiaba
Castelli da Fiaba Questo itinerario può essere percorso interamente oppure utilizzando solo alcune parti del tracciato che da Ovada arriva fino al comune di Castelnuovo Scrivia in una cornice ricca di castelli e fortezze secolari. Durata: 4 giorni e 3 notti Livello difficoltà: medio Km di percorrenza: circa 100 km Percorrenza media giornaliera: circa 30 km Tipo di bicicletta: city bike, mtb Tipo di terreno: asfaltato, sterrato; collinare (anche con alti dislivelli), a tratti pianeggiante Sistemazione: hotel, agriturismo e B&B Periodo consigliato: settembre-prima metà di ottobre; aprile-giugno PARTENZA: Ovada ARRIVO: Castelnuovo Scrivia ITINERARIO: 1° giorno: Arrivo a Ovada, punto di partenza del percorso in bicicletta, nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 2° giorno: Si attraversa il centro cittadino e si lascia Ovada in direzione di Alessandria: oltrepassato il torrente Orba, si percorre la strada che conduce a Rocca Grimalda: la prima parte del percorso è pianeggiante, ma poi la strada sale con ampi tornanti fino a raggiungere questo borgo caratteristico, raggruppato attorno al castello dei Malaspina e dei Grimaldi (foto a sinistra), con la sua torre circolare, i suoi fantasmi e il giardino all’italiana. Percorrendo il crinale delle colline ovadesi, coltivate a Dolcetto, si raggiunge un altro borgo di origine medioevale dominato da un antico castello con torre quadrata e mura di difesa: Carpeneto. Con saliscendi fra le colline, si arriva a Trisobbio (foto a destra), col suo castello in pietra, dove è possibile salire sulla torre e ammirare il paesaggio circostante. Sosta per il pranzo nelle sale del castello. Nel pomeriggio, ancora saliscendi piuttosto impegnativi conducono a Cremolino, un borgo in pietra raggruppato attorno al castello medioevale. -
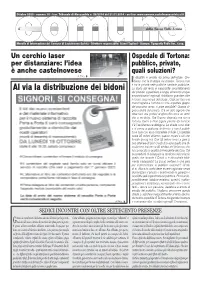
Ottobre 2020 - Numero 10 - Iscr
Ottobre 2020 - numero 10 - Iscr. Tribunale di Alessandria n. 25/2014 del 21.01.2014 - on-line: www.comune.castelnuovoscrivia.al.it il della Bassa Valle Scrivia Mensile di informazione del Comune di Castelnuovo Scrivia - Direttore responsabile: Gianni Tagliani - Stampa: Tipografia Fadia Soc. Coop. Un cerchio laser Ospedale di Tortona: per distanziare: l’idea pubblico, privato, è anche castelnovese quali soluzioni? A PAG. 3 l dibattito è avviato da prima dell’estate. Cre- Idiamo che la strategia sia precisa: Tortona non è tra le priorità nelle politiche sanitarie pubbliche. Al via la distribuzione dei bidoni La storia del lento e inesorabile smantellamento del presidio ospedaliero è lunga, attraversa cinque amministrazioni regionali, dobbiamo guardare oltre il nostro naso senza dietrologie. Oggi per fare una mammografia a Tortona occorre aspettare giugno del prossimo anno: vi pare possibile? Questa si- gnora andrà dal privato. C’è un altro signore che deve fare una protesi al ginocchio ed è un anno che ci va dietro. Ora l’hanno chiamato ma non a Tortona, bensì a Novi Ligure perché da noi non c’è l’assistenza cardiologica. Le strade sono due: o si pensa a qualcosa di diverso o con il pubbli- co e solo con esso l’ospedale chiude. L’ospedale costa 35 milioni all’anno: quattro reparti e ciò che trovate (poco) ora. Con 35 milioni messi a gara si può ottenere di più? Credo di si ed è quello che di- scuteremo insieme ai 40 sindaci del tortonese che ho convocato in qualità di Presidente del Cisa. C’è la possibilità di sviluppare la medicina sul territorio quella che durante il Covid si è dimostrata total- mente inadeguata? La si può mettere in una gara per implementarla al pubblico esistente? Credo di si. -

PIEMONTE D.Lgs
RIEPILOGO REGIONALE Regione Provincia Comune Codice Ministero Ragione Sociale Attività PIEMONTE D.Lgs. 105/2015 Soglia Inferiore Alessandria Alessandria DA016 CARBOTRADE GAS srl - DEPOSITO DI (14) Stoccaggio di GPL ALESSANDRIA Alessandria Alessandria NA289 GETOIL s.r.l. (10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.) Alessandria Alessandria NA311 Stabilimento Refrigerants ATTIVITÀ DI TRAVASO ED RIVOIRA GAS S.r.l. IMBOMBOLAMENTO SOSTANZE PERICOLOSE Alessandr ia Arquata Scrivia NA248 IPLOM SPA (10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.) Alessandria Castellazzo Bormida NA069 Restiani spa - Deposito di GPL (14) Stoccaggio di GPL Alessandria Pozzolo Formigaro NA26 3 Poliresin S.r.l. (22) Impianti chimici Alessandria Tortona NA300 Boero Bartolomeo S.p.A. (39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco). Stoccaggio di vernici Cuneo Bra DA007 Arpa Industriale S.p.a. (23) Produzione di sostanze chimiche organiche di base RIEPILOGO REGIONALE Regione Provincia Comune Codice Ministero Ragione Sociale Attività PIEMONTE D.Lgs. 105/2015 Soglia Inferiore Cuneo Bra DA014 BRAGAS s.r.l (14) Stoccaggio di GPL Cuneo Canale NA252 ITA.FER.T. snc (16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL) Cuneo Fossano NA304 Liquigas - Stabilimento Fossano (14) Stoccaggio di GPL Cuneo Garessio NA071 Huvepharma Italia s.r.l (Ex SANOFI - (19) Produzione di prodotti farmaceutici AVENTIS SPA) - Stabilimento di Garessio Cuneo San Michele Mondovì DA042 SILVACHIMICA S.r.l. (22) Impianti chimici Novara Cameri DA050 LAMPOGAS NORD - Stabilimento di (13) Produzione, imbottigliamento e Cameri distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL) Novara Landiona DA087 Mirato S.p.A. -

Podismo Campionato Prov 2012
Campionato Provinciale UISP Alessandria 2012 REGOLAMENTO Possono entrare nelle classifiche del Campionato Provinciale Individuale Assoluto e per Categorie 2012 della UISP di Alessandria tutti coloro che risulta- no essere in possesso della tessera UISP Lega Atletica Leggera valida per l’an- no in corso, iscritti ad una società podistica affiliata alla Lega Atletica Leggera del Comitato Territoriale UISP di Alessandria. Possono altresì rientrarvi anche coloro che siano individualmente in possesso della tessera UISP Lega Atletica Leggera regolarmente valida per l’anno in corso e rilasciata dal Comitato Territoriale UISP di Alessandria. Per entrare in classifica i concorrenti con i requisiti sopraindicati potranno tota- lizzare punti in ciascuna delle 66 prove previste in calendario. I punteggi-gara per formare la classifica generale saranno determinati nel modo seguente: Generale Maschile: 1 punto all’ultimo, 2 al penultimo e così via, fino al 1° degli atleti avente diritto classificato al traguardo. Generale Femminile: punti alle prime cinque (10-7-5-3-2) dalla 6a un punto a tutte. I punteggi-gara per formare le varie classifiche finali di ogni categoria saranno determinati nel modo seguente: Categorie maschili: A: 1996-1990; B: 1989-1978; C: 1977-1973; D: 1972-1968; E: 1967-1963; F: 1962-1958: G: 1957-1953; H: 1952-1948; K: 1947 e prece- denti. Punti ai primi cinque di categoria (10-7-5-3-2). Categorie femminili: L: 1996-1978; M: 1977-1962; N: 1961 e precedenti. Punti alle prime tre di categoria (10-7-5). Il punteggio conseguito da ciascun atleta nelle seguenti gare in calendario sarà raddoppiato: Ciao 2011!! - Montaldo Bormida – Strevi - Silvano d’Orba - Notturna Castellazzese - Sarezzano – Morsasco – Valenza Po - Grillano di Ovada – Pareto - Carrosio. -

ORARI AUTOLINEE PARTENZE Da CASALE MONFERRATO - Piazza VITTORIO VENETO (FS) Per Le Seguenti Località - DAL 10.09.2013
ORARI AUTOLINEE PARTENZE da CASALE MONFERRATO - Piazza VITTORIO VENETO (FS) per le seguenti località - DAL 10.09.2013 DESTINAZIONE PARTENZA STALLO FREQUENZA ARRIVO FERMATE INTERMEDIE (orario di arrivo alle fermate intermedie) VETTORE ORA NR ORA MORTARA 5:40 11 feriale dal lunedì al sabato 6:27 Terranova (5.54) Candia L. (6.02) Cozzo (6.05) AUTOTICINO S.T.A.C. VERCELLI 5:45 11 feriale dal lunedì al sabato 6:15 Diretto AUTOTICINO S.T.A.C. TRINO 5:55 55 feriale dal lunedì al sabato 6:17 Morano (6.07) AUTOTICINO S.T.A.C. MORTARA 6:05 33 feriale dal lunedì al sabato 6:52 Terranova (6.19) Candia L. (6.27) Cozzo (6.30) AUTOTICINO S.T.A.C. ALESSANDRIA 6:20 88 feriale dal lunedì al sabato 7:08 Occimiano (6.37) Mirabello (6.41) San Salvatore (6.48) Castelletto M. (6.51) Gerlotti (6.54) ARFEA ASTI 6:20 22 feriale dal lunedì al sabato 7:28 S. Giorgio C. (6.30) Ozzano (6.34) Serralunga (6.39) Moncalvo (6.48) Tonco (7.04) - Castel’Alfero (7.11) - Portacomaro (7.17) AUTOTICINO S.T.A.C. TORINO 6:35 55 feriale dal lunedì al venerdì 8:20 Morano (6.47) Trino (6.55) Palazzolo (7.01) Fontanetto (7.05) Crescentino (7.10) AUTOTICINO S.T.A.C. MILANO - FAMAGOSTA 6:42 44 feriale dal lunedì al venerdì 8:13 Valenza FS (7.04) Valenza (7.08) Grava (7.21) Sale (7.24) Castelnuovo Scrivia (7.31) AUTOTICINO S.T.A.C. VERCELLI 6:47 44 feriale dal lunedì al feriale venerdì dal nel lunedì periodo al venerdì scolastico nel periodo 7:25 scolastico Villanova (7.00) Stroppiana (7.05) AUTOTICINO S.T.A.C.