DOTTOR KORCZAK Regia Andrzej Wajda
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Andrzej Wajda'nin Kadrajindan Polonya
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI POLONYA DİLİ VE KÜLTÜRÜ BİLİM DALI ANDRZEJ WAJDA’NIN KADRAJINDAN POLONYA EDEBİYATI Doktora Tezi Aybike Kılık Ankara, 2018 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI POLONYA DİLİ VE KÜLTÜRÜ BİLİM DALI ANDRZEJ WAJDA’NIN KADRAJINDAN POLONYA EDEBİYATI Doktora Tezi Aybike Kılık Tez Danışmanı Prof. Dr. Neşe M. Yüce Ankara, 2018 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ……………………………………………………………………..i GİRİŞ ……………………………………………………………………………….1 I. BÖLÜM Sinema ve Uyarlama Üzerine…………………………………………………….11 II. BÖLÜM İkinci Dünya Savaşı Sonrası Polonya Sineması ………………………………...26 III. BÖLÜM Andrzej Wajda Kimdir?.........................................................................................61 III.1. Sinema Geçmişi ……………………………………………………...61 III.2. Tiyatro Geçmişi ………………………………………………….…..70 IV. BÖLÜM Romantizm Dönemi ………………………………………………………………72 IV.1. Bay Tadeusz …………………………………………………………74 IV.2. İntikam ……………………………………………………………….81 V. BÖLÜM Genç Polonya Dönemi ……………………………………………………………91 V.1. Genç Polonya Döneminde Drama ……………………………………93 V.2. Genç Polonya Döneminde Roman ……………………………………95 V.3. Düğün …………………………………………………...……………96 V.4. Vaat Edilmiş Toprak ……………………………..…………………122 VI. BÖLÜM İki Savaş Arası Dönem ………………………………………………………….139 VI.1. Wilkolu Kızlar ……………………...………………………………140 VI.2. Danton .………………………………………………………..……155 i VII. BÖLÜM Savaş Konulu Filmler ………………………………………………...…………164 VII.1. Muharebe -

©2017 Renata J. Pasternak-Mazur ALL RIGHTS RESERVED
©2017 Renata J. Pasternak-Mazur ALL RIGHTS RESERVED SILENCING POLO: CONTROVERSIAL MUSIC IN POST-SOCIALIST POLAND By RENATA JANINA PASTERNAK-MAZUR A dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey In partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in Music Written under the direction of Andrew Kirkman And approved by _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ New Brunswick, New Jersey January 2017 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Silencing Polo: Controversial Music in Post-Socialist Poland by RENATA JANINA PASTERNAK-MAZUR Dissertation Director: Andrew Kirkman Although, with the turn in the discipline since the 1980s, musicologists no longer assume their role to be that of arbiters of “good music”, the instruction of Boethius – “Look to the highest of the heights of heaven” – has continued to motivate musicological inquiry. By contrast, music which is popular but perceived as “bad” has generated surprisingly little interest. This dissertation looks at Polish post-socialist music through the lenses of musical phenomena that came to prominence after socialism collapsed but which are perceived as controversial, undesired, shameful, and even dangerous. They run the gamut from the perceived nadir of popular music to some works of the most renowned contemporary classical composers that are associated with the suffix -polo, an expression -

Muzyka W Filmie Tatarak Andrzeja Wajdy
BAnna Al-Araj B „W ogóle jestem niechętny dźwiękom”. Muzyka w filmie Tatarak Andrzeja Wajdy ABSTRACT. Al-Araj Anna, „W ogóle jestem niechętny dźwiękom”. Muzyka w filmie „Tatarak” Andrzeja Wajdy [“As a rule, I am reluctant towards sound”. Music in Andrzej Wajda’s film “Sweet Rush”]. „Przestrzenie Teorii” 27. Poznań 2017, Adam Mickiewicz University Press, pp. 117–137. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2017.27.10. The aim of this article is to interpret the musical layer of Andrzej Wajda’s 2009 movie Tatarak (Sweet Rush ), based on the novel by Jarosław Iwaszkiewicz. In the first part, the author attempts to depict the complex relationship between the literary and film works of these two artists and em- phasizes three main motifs used by both of them: love and death, water and women’s themes. Next, Wajda’s attitude to music is analyzed. He treats sounds as an element of everyday life and, as is typical for our times, he is aware of the “dissolution” of musical works. In the next part, the author articulates the main problems of Sweet Rush , drawing attention to both Iwaszkiewicz’s novel and Wajda’s movie. The director’s adaptation, which is full of intermedia references, re- volves around the theme of death and seems to underestimate the sexual aspect of Iwaszkiewicz’s work. Finally, Pawel Mykietyn’s soundtrack to Sweet Rush is interpreted. The composer used one of his earlier Shakespeare’s Sonnets (2000), which plays the role of a leitmotif , to illustrate the most enigmatic, inexplicable scenes from Wajda’s movie. -

A. Lewicki, Teoria I Historia Mediów Audiowizualnych
2019 TEORIA I HISTORIA MEDIÓW AUDIOWIZUALNYCH SKRYPT DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH DR HAB. ARKADIUSZ LEWICKI, PROF. UWR Teoria i historia mediów audiowizualnych dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr Kurs dla studentów niestacjonarnych Cele kursu: Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z historią radia, kina i telewizji – z podstawowymi datami i chronologią ich rozwoju; z najważniejszymi prądami filmowymi i telewizyjnymi; z najwybitniejszymi twórcami. W trakcie ćwiczeń pojawią się także zagadnienia związane z najważniejszymi teoriami medioznawczymi, historią myśli filmoznawczej i teorią mediów audiowizualnych, w szczególności radia i telewizji. Treści kursu (18 godzin): 1. Początki mediów audiowizualnych. Socjologiczne, techniczne i naukowe podstawy wynalezienia i funkcjonowania fotografii, kinematografu i radia. Początki kina w Europie. Kino popularne i awangarda (francuska). Nieme kino rosyjskie i niemieckie. 2. Nieme kino – USA. Star system. Początki radia i kina dźwiękowego. Amerykańskie kino klasyczne. 3. Filmowy modernizm. Włoski neorealizm i „nowe fale”. Kino amerykańskie od roku 1968. 4. Kino najnowsze. Postmodernizm jako system sygnifikacji w mediach audiowizualnych. 5. Przedwojenne kino polskie. Początki polskiego radia i telewizji. Polskie kino, radio i telewizja lat 1945-70. Polskie media współczesne. 6. Historia radia i telewizji. Genealogia mediów audiowizualnych. Teorie badań medioznawczych. 1 1. Początki mediów audiowizualnych. Socjologiczne, techniczne i naukowe podstawy wynalezienia i funkcjonowania fotografii, -
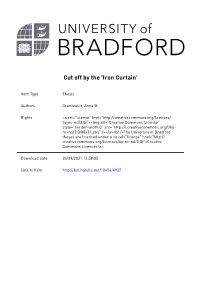
1 INTRODUCTION This Dissertation Will Discuss the Perception of Polish
Cut off by the 'Iron Curtain' Item Type Thesis Authors Draniewicz, Anna B. Rights <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/3.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by- nc-nd/3.0/88x31.png" /></a><br />The University of Bradford theses are licenced under a <a rel="license" href="http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">Creative Commons Licence</a>. Download date 24/09/2021 13:59:05 Link to Item http://hdl.handle.net/10454/4927 INTRODUCTION This dissertation will discuss the perception of Polish Cinema in English- language literature. During the collection of my secondary data, which concentrated mainly on English-language books but also includes newspapers and Internet resources, I encountered many interesting issues. These are divided here into three categories discussed in three chapters: ‘Stereotypes and Errors’ that result from the lack of knowledge thus causing misunderstandings, ‘Deficiencies’ about the absence of some films and directors in the English-speaking world and ‘Different Perspectives’ that reveal some interesting comparisons. The judgements applied to define these sections are respectively: accuracy (correctness of the facts), novelty (unknown trends) and originality of ideas (absent in Polish film criticism). During my research I have discovered the main factors distorting the perception of Polish cinema. I talked about them during my presentation entitled ‘English-Language Critical Engagements with Polish Cinema’ during the ‘Polish Cinema in an International Context’ conference held in Manchester in December 2009. Most of these issues are addressed in Chapter One, which outlines the problems that English-language authors seem to have with the Polish language, the background political issues and the lack of knowledge about some of the periods of Polish cinema. -

New Polish Films 20082 0 0 8 NPF 2008 Okladka S II:Layout 1 28/1/08 11:22 Page 1 New Polish Films 2008
NNPFPF 22008008 ookladkakladka s I.aiI.ai 28/1/0828/1/08 11:57:1811:57:18 NewPolish Films 20082008 C M Y CM MY CY CMY K 2008 Sponsor of PISF: NPF 2008 okladka s II:Layout 1 28/1/08 11:22 Page 1 New Polish Films 2008 New Polish Films 2008 1 2 New Polish Films 2008 Introduction Dear Ladies and Gentleman, We begin the third year of the Polish Film Institute's activity and the second year after the Act on Cinematography was approved by European Commission in May 2006. For last two years the situation of Polish cinema has changed favourably. In 2005 with the introducing the parliamentary act, Polish cinema received a great opportunity. The Polish Film Institute, created according to world's best standards, has become an institution supporting artists at every stage of film production. The PFI also subsidizes film festivals and retrospectives, supports the infrastructure of cinemas' renewal, promotes Polish cinema abroad, grants professional advancement of filmmakers as well as film schools. We are always trying to be where something important is happening in cinema. The new law and establishing the PFI resulted not only in multiplying the State's expenses on cinema – here I would like to remind that in the worst in this case year of 2002 Ministry of Culture assigned 4.3 million zloty for film production, while only this year the Institute assigned almost 80 million zloty for film production and development. The number of last year's feature film production increased up to 37 titles and in 2007 – 39 feature films have been made. -

Retrospektive Andrzej Wajda Andrzej Wajda
Retrospektive Andrzej Wajda DER DIRIGENT Andrzej Wajda 8 Andrzej Wajda und Krystyna – Janda bei den Dreharbeiten zu DYRYGENT Wajda Andrzej Als Martin Scorsese 2014 in den USA und in England immer als politscher Filmkünstler verstanden, dessen das auf seine Initiative hin zustande gekommene Film- künstlerisches Selbstverständnis nicht von seinem programm »Masterpieces of Polish Cinema« präsen- Selbstverständnis als polnischer Patriot zu trennen ist. tierte, befanden sich unter den 24 Filmen der Jahre In unmissverständlichen Worten hat er das 2002 in der 1957 bis 1978 allein vier Filme von Andrzej Wajda. Dankesrede bei der Verleihung des Oscar für sein Le- Scorsese verwies auf den starken Eindruck, den die benswerk zum Ausdruck gebracht: »Ich werde meine von ihm ausgesuchten Filme während seines Filmstu- Rede auf Polnisch halten, da ich das sagen möchte, diums an der New York University in den 1960er Jah- was ich denke, und ich denke immer auf Polnisch. ren hinterlassen hatten und hob Wajdas ASCHE UND Die Themen unserer Filme waren die Brutalität des DIAMANT besonders hervor: »When I first saw ASHES Faschismus und das Unglück, welches der Kommunis- AND DIAMONDS, one of the many highlights in this mus mit sich brachte ...« In Filmen wie EINE GENERA- series and arguably one of the greatest films ever made TION, DER KANAL, ASCHE UND DIAMANT, LOTNA oder – Polish or otherwise – I was overwhelmed by the film: LANDSCHAFT NACH DER SCHLACHT spürt man die the masterful direction, the powerful story, the strik- autobiografischen Erfahrungen des 1926 geborenen ing visual imagery, and the shocking performance by Wajda, der den deutschen Überfall auf Polen und die Zbigniew Cybulski, considered the Polish James Dean, Jahre der Besatzung ebenso bewusst miterlebt hatte for his electrifying presence. -

Agatambor.Pdf
TWÓRCA Nowa polska półka filmowa seria KULTURA i JĘZYK POLSKI dla CUDZOZIEMCÓW „LEKSYKON POLSKI” TWÓRCA Agnieszka Tambor Nowa polska półka filmowa 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien Uniwersytet Śląski Wydawnictwo Gnome Katowice 2018 Współpraca przy tworzeniu haseł ADAM ANTONIEWICZ (aa) AGATA RUDZIŃSKA (ar) JUSTYNA BUDZIK (jb) Recenzent WACŁAW M. OSADNIK © Copyright 2015 by Uniwersytet Śląski w Katowicach Wszelkie prawa zastrzeżone Redakcja i korekta KAROLINA POSPISZIL Projekt okładki i szaty graficznej MAREK FRANCIK Publikacja sfinansowana ze środków UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Współfinansowano ze środków Fotografia na okładce JAROSŁAW ROLAND KRUK Wydanie drugie ISBN 978-83-63268-58-9 Złożono czcionkami Myriad Pro i Minion Pro Printed in UE GNOME — Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne ul. Drzymały 18/6, 40-059 Katowice, Poland tel.: 603370713 e-mail: [email protected] Spis treści Wstęp 9 TWÓRCA trzeba obejrzeć 15 NÓŻ W WODZIE (Knife in the Water) 15 ZIEMIA OBIECANA (The Promised Land) 16 PIERWSZA MIŁOŚĆ (First Love) 18 CHINATOWN 19 BARWY OCHRONNE (Camouflage) 21 SEKSMISJA (Sexmission) 22 EUROPA, EUROPA 24 DRAKULA (Bram Stoker’s Dracula) 25 89 MM OD EUROPY (89 mm from Europe) 26 LISTA SCHINDLERA (Schindler’s List) 28 TRZY KOLORY. BIAŁY (Three Colors: White) 30 ŚMIERĆ JAK KROMKA CHLEBA (Death as a Slice of Bread) 31 HELIKOPTER W OGNIU (Black Hawk Down) 33 MARZYCIEL (Finding Neverland) 34 PLAC ZBAWICIELA (Saviour’s Square) 35 KOPIA MISTRZA (Copying Beethoven) 37 SWEENEY TODD: DEMONICZNY GOLIBRODA Z FLEET -

1. Polsko a Andrzej Wajda…………………………………………………………10 1
JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika Andrzej Wajda: hrdinství, romantismus a polská historie Diplomová práce Autor práce: BcA. Iryna Shkaruba Vedoucí práce: prof. Pavel Švanda Oponent práce: MgA. Hana Slavíková, Ph.D. Brno 2011 Bibliografický záznam SHKARUBA, Iryna. Andrzej Wajda: hrdinství, romantismus a polská historie. [Andrzej Wajda: heroism, romanticism and Polish history]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky, 2011. 89 s. Vedoucí diplomové práce: prof. Pavel Ńvanda Anotace Práce se zabývá hrdiny Andrzeje Wajdy, které vzeńli z polských tradic, kulturního romantismu, mýtických hrdinských činů předků a vědomí tíhy vlastních dějin, kdy bylo Polsko děleno, okupováno, zneuņíváno, ale: i přes veńkeré křivdy a poráņky, neztratili hluboké patriotické cítění, víru ve spásu a naději, ņe Polsko – jakkoliv zneuctěné zásahy zvenčí, bude jednou svobodné. Prostřednictvím analyticko- esejistické analýzy postav z POKOLENÍ, KANÁLŮ, POPELU A DÉMANTU, LOTNY, KATYNĚ, VESELKY, ZEMĚ ZASLÍBENÉ, POPELŮ, SAMSONA, KRAJINY PO BITVĚ, ČLOVĚKA Z MRAMORU, ČLOVĚKA ZE ŅELEZA, DANTONA, VŃE NA PRODEJ je kaleidoskopicky vyobrazen svět Wajdových hrdinů. Ve snaze o komplexní uchopení tématu je přihlíņeno k historii Polska, symbolickým a náboņenským motivům. Annotation This thesis deals with the heroes of Andrzej Wajda, who came of the Polish traditions, cultural romanticism, mythical heroic deeds of ancestors and an awareness of heaviness of their own history, when Poland was divided, occupied, exploited, but: despite all the injustices and defeats, they didn’t lose the deep patriotic feelings, beliefs of salvation and hope that Poland - though defiled interventions from outside – will be one day free. -

Andrzej Wajda Photography by / Photos De Czesław Czapliński
Andrzej Wajda Photography by / Photos de Czesław Czapliński 28 European Economic and Social Committee Comité économique et social européen The EESC’s mission Committed to the building of Europe, the EESC contributes to strengthening the democratic legitimacy and effectiveness of the European Union by enabling civil society organisations from 28 the Member States to express their views at European level. It fulfils three key missions: • Advising the European Parliament, the Council and the European Commission so as to ensure that EU policies and legislation match economic, social and civic realities • Building a more participatory EU, closer to its citizens • Promoting EU values and civil society organizations globally This publication is part of a series of catalogues published in the context of the exhibitions organized by the EESC. La présente publication fait partie d’une collection Mission du CESE de catalogues édités dans le cadre des expositions organisées par le CESE. Engagé dans la construction européenne, le CESE contribue au renforcement de la légitimité démocratique et de l’efficacité de l’Union européenne (UE) en permettant aux organisations de la société civile des États membres d’exprimer leur avis au niveau européen. Le CESE accomplit trois missions essentielles: • assiste le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne afin que les politiques et la législation européennes soient mieux adaptées aux réalités économiques, sociales et civiques; • favorise le développement d’une UE plus participative et plus proche de ses citoyens; • promeut les valeurs de l’UE et les organisations de la société civile globalement. Cover: Andrzej Wajda directs a production of Zemsta (The Revenge) for the Stary Teatr (Old Theatre) at the Nowodworski Colegium in Cracow, Andrzej Wajda June 1986. -

Ïvivilcinema 1-09 Layout 1
numero1 2009 Bimestrale d’informazione cinematografica edito dalla FICE - Federazione Italiana Cinema d’Essai Speciale Berlinale MarMar Neronero Tutti i film di Federico Bondi Riccardo Scamarcio Gus van Sant ANNO IX - NUOVA SERIE - N.1 - GENNAIO/FEBBRAIO 2009 - Euro 3,00 - SPED. ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA SERIE - N.1 GENNAIO/FEBBRAIO 2009 Euro 3,00 SPED. ABBONAMENTO POSTALE ANNO IX - NUOVA interviste anteprime Fausto Brizzi Giulia non esce la sera Aronofsky - Amenta di Giuseppe Piccioni De Biasi - Gansel Huppert - Panini Due partite Shanley - Wajda di Enzo Monteleone n.1/2009 editoriale Cover story 24 Mar Nero di Federico Bondi La cultura e il mercato (Barbara Corsi) In copertina: Ilaria Occhini e Dorotheea Petre In un 2009 di crisi e di tagli giova ricordare qualche punto fermo nel sostegno alla cultura. Con il conforto dei dati Speciale Oscar 2009 del 2008: nelle sale d’essai il cinema italiano è al 40%! 6 Le candidature (Mario Mazzetti) •••D’accordo, la crisi economica è forte e il 2009 appena iniziato, lo si sapeva, Speciale Berlino 2009 sarò un anno di calo della spesa e dell’investimento pubblico, nella cultura e nello 8 Tutti i film (Mario Mazzetti) spettacolo come e più degli altri settori. Permetteteci però di sottolineare il “più”, a 12 Riccardo Scamarcio (Federico Pontiggia) nostro avviso questo sì immotivato, come se la cultura fosse un bene effimero, un inutile 13 Gus van Sant (Marco Spagnoli) fronzolo o peggio una zavorra di cui liberarsi nei momenti difficili. La consapevolezza del momento e un senso di dignità ben radicato non debbono tuttavia impedirci di Interviste sottolineare ancora una volta il ruolo tradizionale delle sale d’essai, all’interno di un 14 John Patrick Shanley (Marco Spagnoli) sistema che va salvaguardato e valorizzato in toto: un ruolo di aggregazione, diffusione 15 Andrzej Wajda (Federico Pontiggia) della cultura cinematografica, uno sguardo sulla varietà di linguaggi, su culture e paesi 16 Fausto Brizzi (Anna Maria Pasetti) diversi dal nostro. -
Seksmisja Juliusz Machulski Przekładaniec Andrzej Wajda Opracowanie Broszury | Dr Piotr Skrzypczak
ANTYUTOPIE 53 SEKSMISJA JULIUSZ MACHULSKI PRZEKŁADANIEC ANDRZEJ WAJDA OPRACOWANIE BROSZURY | DR PIOTR SKRZYPCZAK 2 ANTYUTOPIE Tematem płyty są filmowe anty- temat fantastyczno-naukowej antyutopii, utopie – pesymistyczne lub co najmniej otwarcie manifestowało swój dystans do niepokojące wizje przyszłości. To temat, konwencji scenograficznej science fiction, po który bardzo chętnie sięgało i sięga umieszczając w filmach akcenty komiczne kino (Metropolis, reż. F. Lang, Blade lub zgoła karykaturalne. Wszystko z prze- Runner, reż. R. Scott, Matrix, reż. A., L. świadczeniem, że nic się tak szybko nie Wachowski). Podobnie jak wiele tematów starzeje, a w konsekwencji i nie bawi, jak filmowych, także antyutopie posiadają filmowa wizja przyszłości. swój rodowód literacki, choćby w postaci Antyutopie to utopie negatywne, Podróży Guliwera Swifta czyNowego wspa- utwory najczęściej będące odpowiedzią na niałego świata Huxleya. Jako wizje futury- utopijne wyobrażenia o świecie. Elementy styczne, antyutopie lokują się najczęściej składowe pozornie idealnej organi- w obrębie gatunku science fiction, ale nie zacji państwa ukazywane są najczęściej tylko (film grozy, film katastroficzny). w krzywym zwierciadle, jako przyczyny W pewnym sensie SF to gatunek pozba- zniewolenia pozbawionej cech indywi- wiony wyrazistej tożsamości i określonego dualnych jednostki.2 Dwa omawiane typu bohatera, wykorzystujący określone filmy: Seksmisja oraz Przekładaniec to struktury narracyjne i konwencje innych takie właśnie, ubrane w kostium science gatunków.1 Wyjątkowe predyspozycje kina fiction, żartobliwe wizje przyszłości. do kreowania i ożywiania futurystycz- Komediowy ton obu utworów nie powi- nych lub zupełnie fantastycznych światów, nien jednak zmylić widza; stawiają one których prekursorem był już Georges istotne i zupełnie poważne pytania o przy- Méliès, pozwoliły na swobodne łączenie szłość naszej cywilizacji. Różne są nato- filmu fantastyczno-naukowego na przy- miast konteksty realizacji i odbioru kład z motywami komedii.