Antiche Pere Dell’Emilia-Romagna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The History of Painting in Italy, Vol. V
The History Of Painting In Italy, Vol. V By Luigi Antonio Lanzi HISTORY OF PAINTING IN UPPER ITALY. BOOK III. BOLOGNESE SCHOOL. During the progress of the present work, it has been observed that the fame of the art, in common with that of letters and of arms, has been transferred from place to place; and that wherever it fixed its seat, its influence tended to the perfection of some branch of painting, which by preceding artists had been less studied, or less understood. Towards the close of the sixteenth century, indeed, there seemed not to be left in nature, any kind of beauty, in its outward forms or aspect, that had not been admired and represented by some great master; insomuch that the artist, however ambitious, was compelled, as an imitator of nature, to become, likewise, an imitator of the best masters; while the discovery of new styles depended upon a more or less skilful combination of the old. Thus the sole career that remained open for the display of human genius was that of imitation; as it appeared impossible to design figures more masterly than those of Bonarruoti or Da Vinci, to express them with more grace than Raffaello, with more animated colours than those of Titian, with more lively motions than those of Tintoretto, or to give them a richer drapery and ornaments than Paul Veronese; to present them to the eye at every degree of distance, and in perspective, with more art, more fulness, and more enchanting power than fell to the genius of Coreggio. Accordingly the path of imitation was at that time pursued by every school, though with very little method. -

Fall I960 BERLIN COLLEGE
^.^j LA \ T Fall I960 BERLIN COLLEGE PV . ALLEN MEMORIAL ART MUSEUM BULLETIN VOLUME XVIII NUMBER 1 Contents Foreword ------- 2 A Flawing by Guercino by Anne K. Horton - 5 Announcements Mrs. Hazel Barker King - 20 Oberlin Archaeology Society 20 Oberlin Friends of Art - - - - 20 Fall and Winter Exhibitions - - - 21 Attendance - - - - - 21 Summer Classes in Paris and Vienna - - 21 Staff and Faculty Notes 22 Loans to Museums and Institutions 24 Catalogue of Recent Additions - - - 25 Calendar - - 29 Friends of the Museum - - - - - 31 Printed three times a year by the Department of Fine Arts of Oberlin College, Oberlin, Ohio. $3.50 a year, or $1.25 a copy; mailed free to members of the Oberlin Friends of Art. Foreword: The Major and the Minor The publication of the eighteenth volume of the Bulletin brings to the fore a very important question: what is the role of the so-called "minor arts" in education? It is the thesis of our museum that art as an unambiguous, visual manifestation of man's tendencies of mind has no major and no minor forms, only degrees of quality and that, therefore, the collecting and dis play and the teaching from the minor arts is not only desirable, but in deed essential to education. The question is raised because most of this volume will be given over to the minor arts. In this first issue is a study of one of the im portant drawings in the Oberlin collection. The second number will deal with the art of ancient and medieval goldsmiths and constitute a catalogue of the Melvin Gutman Collection of gold objects. -

4. Montecchi Elisa.Indd
IGURE F 3 - 2017 ELISA M ONTECCHI Il vescovo di Reggio Paolo Coccapani (1584-1650) e le sue collezioni. Nuovi documenti. Una nuova ricerca sul vescovo di Reggio Emilia Paolo Coccapani bienti includeva uno spazio appositamente destinato a funzioni (1584-1650) amplia le nostre conoscenze su un episodio impor- di Galleria. tante del collezionismo artistico del XVII secolo in area emiliana, Il ritrovamento del “libro dei conti” di Isabella Molza Coccapani, a proposito del quale potevamo già disporre degli inventari pubbli- con un estratto notarile che viene qui trascritto, dà poi notizia cati nel 1870 da Giuseppe Campori. Nell’Archivio di Stato di certa del transito dei disegni della collezione da casa Coccapani ai Modena Elisa Montecchi ha reperito un inedito Inventario dei “Principi di Modena”. Se già nel 1998 Lidia Righi Guerzoni mobili ritrovati nel vescovado di Reggio doppo la mor- e Patrizia Curti avevano reso noto l’invio di disegni ai Principi, te del vescovo Coccapani , che registra opere in parte assenti registrato nelle carte di Alfonso Coccapani, soltanto il documento negli elenchi già noti e integra le notizie già in nostro possesso circa oggi ritrovato restituisce la certezza dell’avvenuto passaggio, oltre la raccolta. Il lavoro di identifi cazione, qui intrapreso con alcuni a una precisa valutazione in termini economici dei singoli disegni, risultati già degni di nota, potrà aprire nuovi spunti per defi nire sulla base della quale verrà stabilita l’entità della somma neces- il ruolo del vescovo Coccapani nel sistema del collezionismo e della saria per ripianare il debito contratto dai Coccapani in seguito circolazione delle opere d’arte in un centro colto e vivace come la all’ottenimento del titolo di marchesi e dell’acquisto del feudo di Reggio del secondo quarto del Seicento. -

Uno Scrigno Per L'arte
3 Uno scrigno per l’arte Dipinti antichi e moderni dalle raccolte BPER Banca a cura di Lucia Peruzzi Testi di Lucia Peruzzi Daniele Benati Rossana Torlontano Alberto Rodella Chiara Pulini Domenico Bodega Autori delle schede Dipinti antichi Lucia Peruzzi Scheda Saturnino Gatti Rossana Torlontano Dipinti dell’Ottocento Alberto Rodella Progetto grafico avenida.it Questo catalogo è stato pubblicato in occasione dell’avvio del progetto La Galleria Uno scrigno per l’arte Collezione e Archivio Storico Coordinamento Sebastiano Simonini Dipinti antichi e moderni Curatela della Collezione dei dipinti antichi Lucia Peruzzi dalle raccolte BPER Banca Curatela dell’Archivio Storico Chiara Pulini Progetto museografico Progettisti Associati Sassuolo Grafica del sistema visivo avenida.it Realizzazione dell’allestimento Barth Innenausbau S.a.s. Bressanone Si ringraziano per la collaborazione Giorgia Benedetti, Sabrina Bianchi, Martin Burger, Federica de Luise, Francesca Ferrari, Antonio Geminiani, Alessandro Lorenzani, Gaetano Marzani, Gabriele Pandolfi, Greta Rossi, Rocco Savino, Cristina Solmi, Daniele Tamburini, Eugenio Tangerini, Ernesto Tuliozi, Vincenzo Vandelli La Galleria BPER Banca, un progetto per la cultura “La Galleria” BPER Banca nasce dalla presa di coscienza della straordinaria importanza dei corpus collezionistici stratificatisi nel corso di questi ultimi decenni, dipinti antichi di area emiliano romagnola, abruzzese e campana con punte di rilievo molto alte. E ai dipinti si affianca il patrimonio rappresentato dall’archivio storico, che costituisce lo strumento più completo per raccontare e comprendere la storia della banca e del proprio territorio. Le dimensioni e il valore storico e culturale di questi nuclei rendono impellente la ne- cessità di ripensare l’approccio alla loro conservazione, tutela, fruibilità e alla loro stessa valorizzazione; obiettivi questi perseguibili solo mediante una gestione più organica e ordinata. -
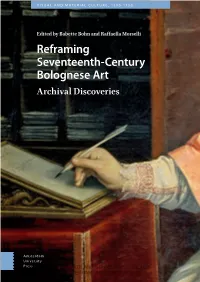
Observing Protest from a Place
VISUAL AND MATERIAL CULTURE, 1300-1700 Bohn & Morselli (eds.) Edited by Babette Bohn and Raffaella Morselli Reframing Seventeenth-CenturySeventeenth-century Bolognese Art Archival Discoveries Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art Bolognese Seventeenth-Century Reframing FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Visual and Material Culture, 1300–1700 A forum for innovative research on the role of images and objects in the late medieval and early modern periods, Visual and Material Culture, 1300–1700 publishes monographs and essay collections that combine rigorous investigation with critical inquiry to present new narratives on a wide range of topics, from traditional arts to seemingly ordinary things. Recognizing the fluidity of images, objects, and ideas, this series fosters cross-cultural as well as multi-disciplinary exploration. We consider proposals from across the spectrum of analytic approaches and methodologies. Series Editor Dr. Allison Levy, an art historian, has written and/or edited three scholarly books, and she has been the recipient of numerous grants and awards, from the National Endowment for the Humanities, the American Association of University Women, the Getty Research Institute, the Dumbarton Oaks Research Library of Harvard University, the Whiting Foundation and the Bogliasco Foundation, among others. www.allisonlevy.com. FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art Archival Discoveries Edited by Babette Bohn and Raffaella Morselli Amsterdam University Press FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Cover illustration: Guido Reni, Portrait of Cardinal Bernardino Spada, Rome, Galleria Spada, c. -

DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO 29 NOVEMBRE 2017 GE235-36 Wannenesgroup.Com Lotto 929
DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO XIX DEL E ANTICHI DIPINTI 29 NOVEMBRE 2017 DIPINTI ANTICHI GE235-36 E DEL XIX SECOLO wannenesgroup.com GENOVA, 29 NOVEMBRE 2017 lotto 929 1 2 DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO GENOVA, 29 NOVEMBRE 2017 OLD MASTERS AND 19TH CENTURY PAINTINGS GENOA, 29 NOVEMBER 2017 ASTA $ AUCTION ESPOSIZIONE $ VIEWING Genova Genova Palazzo del Melograno Palazzo del Melograno Piazza Campetto, 2 Piazza Campetto, 2 MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE Wednesday 29 November VENERDÌ 24 NOVEMBRE ore 10-13 14-18 Prima Tornata Friday 24 November ore 14 lotti 601 - 817 10am to 1pm - 2 to 6pm First Session at 2pm lots 601 - 817 SABATO 25 NOVEMBRE ore 10-13 14-18 Seconda Tornata Saturday 25 November ore 17.30 lotti 818 - 929 10am to 1pm - 2 to 6pm Second Session at 5.30pm lots 818 - 929 DOMENICA 26 NOVEMBRE ore 10-13 14-18 Terza Tornata Sunday 26 November ore 21 lotti 930 - 1059 10am to 1pm - 2 to 6pm Third Session at 9pm lots 930 - 1059 LUNEDÌ 27 NOVEMBRE ore 10-13 14-18 Monday 27 November 10am to 1pm - 2 to 6pm La partecipazione all’Asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni di Vendita riportate in questo catalogo in copertina: I lotti potranno essere ritirati a partire da Giovedì 30 Novembre esclusivamente previo appuntamento telefonico +39 010 2530097 lotti 753 e 1004 Taking part in the Auction implies the entire and uncondItional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. The lots may be collected from Thursday 30 November by telephone appointment calling +39 010 25 300 97. -

Intorno Alla Vita E Alle Opere Di Gianfresco Barbieri, Detto Il Guercino
INTORNO ALLA VITA E ALLE OPERE D 1 filANFIUNGEHCiO BARBIERI detto il mmm m cento D 1 GAETANO ATTI CENTESE ROMA TIPOGRAFIA DELLE SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE VIA LATA NUM. 211 A. 1861 PREFAZIONE Tatto che si sa del Quercino, per la perizia e diligenza dei suoi Biografi antecedenti a questa mia fatica, tutto che riguarda al numero delle sue Opere, e ai giudizi di esse proferiti da giudici competenti, tutto che si è trovato degno di correzione nei consul- tati Biografi, tutto che riguarda alla descrizione mi- nuta dei suoi Capolavori, tutto che concerne notizie edi- te ed inedite in patria e fuori, lo che si e desunto dal Calvi principe dei Biografi del Quercino, dal Baruf- faldi, dal Malvasia, dal Crespi, dal Lanzi, dal Qua- drio, dal Passeri, dal Ticozzi, dall'Orlandi, dallo Scan- nelli, da Gori Gandellini, dal Museo Fiorentino, dal dall''Erri, Cittadella, dal Borsetti , dal Trombelli , dallo Zanotti, dal Fea , dal T'iti , dal Bollavi, dal Bello/ii , dal Gualandi , dal Giordani, dal Tosi e dagli Itine rarii, e Guide di Cento e d'Italia si trova qui registrato ed unito in un sol corpo. Ondeche giu- dico inutile che altri faccia capo altrove, se gli vien talento di sapere alcun che intorno al sommo Mae- stro del Chiaroscuro, stantechè ogni cosa edita , e prima d'ora inedita si è qui raccolta a comodo de- gli ammiratori. Spero, o lettore che ti sarà grata la fatica, e vivi felice. NUOVA VITA DEL GUERCINO Poiché la gloria dell'arte pittorica pel valore degl'Italiani fu giunta al grado supremo, pareva che niuno avesse ardire di provarsi in dise- gno dopo l'esempio del Francia, di Michelangelo, e del dotto Leonardo, nella espressione dopo il divino Raffaello, nel colorito dopo il valoroso Iniziano. -

'Cene in Emmaus' Di Caravaggio Alle
L'IDOMENEO Idomeneo (2015), n. 20, 137.176 ISSN 2038-0313 DOI 10.1285/i20380313v20p137 http://siba-ese.unisalento.it, © 2016 Università del Salento . Dalle ‘Cene in Emmaus’ di Caravaggio alle ‘cose mangiative’ di Jacopo da Empoli. I nutrimenti del Mediterraneo nelle nature morte in età moderna. Maria Antonia Nocco Caravaggio, Guercino, Annibale Carracci and Bernardo Strozzi, Luca Giordano and Neapolitans naturalists, Jacopo da Empoli and Giacomo Ceruti, different painters style and training have played in their works the 'nutrients' as fruit, vegetables and food of all kinds, whether with "still life" and the interior kitchen, pantries, markets and religious parties enlivened by the presence of cooks, ortolane, scullery maids, peasants and commoners. These artists have described by images "still life" or "silent nature" by recalling through the shapes and colors, the sensory quality, visual and tactile, the nutritional model now known as “mediterranean diet”, inspired by ancient culinary traditions born around the Romans “Mare Nostrum” and practiced by the countries bordering the Mediterranean basin, especially in Italy. By two of Caravaggio's masterpieces by “Cena in Emmaus” from the National Gallery in London and the Pinacoteca di Brera in Milan, where the painter represents the liturgical banquet with Christ and the two disciples - set up with bread, meat, wine, water, bitter herbs and a- basket overflowing with juicy fruits and colorful autumn, pomegranate, grapes, figs, apples and wild medlar - to “Mangiafagioli” Annibale Carracci, the popular naturalism poster; from the “Dispensa” by Jacopo da Empoli which looks to the Spanish bodegones to the genoese Bernardo Strozzi’s alluring “Cuoca” plucked- ducks. -

Curriculum Studiorum
CURRICULUM ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA di Barbara Ghelfi Dal 02/05/2016: Professore associato di Storia dell’arte moderna, S.S.D. L-ART/02, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Beni Culturali, campus di Ravenna. Responsabile del progetto Collezionismo d’arte in Romagna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Beni Culturali. Responsabile del progetto di ricerca “La tecnica del Guercino”, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Beni Culturali. Membro del comitato scientifico Centro Studi internazionale il Guercino (Cento). Precedenti esperienze lavorative • 01/09/2005-31/08/2007: Docente di ruolo di Italiano (classe di concorso 43/A), nella scuola media inferiore (nominata sulla base della graduatoria del concorso ordinario D.D. 01/04/1999, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto); • 01/09/2007-30/09/2012: Docente di ruolo di Storia dell'arte (classe di concorso 61/A) nella scuola media superiore (nominata sulla base della graduatoria del concorso ordinario D.D. 01/04/1999, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto). • Dal 01/10/2012 al 30/04/2016: Ricercatore universitario a tempo indeterminato, S.C.10/B1- Storia dell’Arte, S.S.D. L-ART/02, Università di Bologna, Dipartimento di Beni Culturali, campus di Ravenna. Titoli di studio • Laurea in Lettere moderne (indirizzo filologico), conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna, in data 12/07/1995, con punteggio di 110 e lode. Titolo della tesi: Il Libro dei conti del Guercino (1629-1666), relatrice prof.ssa Anna Ottani Cavina. • Diploma di Specializzazione post laurea in Storia dell’Arte (indirizzo medievale e moderno) di durata triennale, conseguito presso la Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte dell’Università degli Studi di Bologna, in data 24/03/1999, con il punteggio di 70/70. -

Dipinti E Disegni Antichi Dal XV Al XIX Secolo
Dipinti e Disegni Antichi dal XV al XIX secolo Asta 31 Milano, via Olona, 2 giovedì, 23 novembre 2006 ore 15.30 disegni ore 18.00 dipinti 2 Maioliche del Rinascimento Sede dell’esposizione e dell’asta Milano via Olona, 2 Esposizione da sabato 18 a giovedì 23 novembre 2006 ore 10.00 – 18.30 domenica 15.00 – 18.30 giovedì 23 novembre 10.00 – 13.00 Asta giovedì, 23 novembre 2006 Orario dell’Asta ore 15.30 (disegni) ore 18.00 (dipinti) Per informazioni Porro & C. Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano Tel. 02 72094708 – Fax 02 862440 [email protected] www.porroartconsulting.it Maioliche del Rinascimento 3 Catalogo a cura di Alessandro Galli 4 Maioliche del Rinascimento 1 1 Scuola Fiorentina, secolo XVI Studio di teste, al verso studio di figura inchiostro e acquarello su carta, mm. 158x135 Stima: € 1.200/1.500 Disegni Antichi 5 23 2 3 Giuseppe Gioacchino Bonazzi Mauro Tesi Attivo alla fine del XVIII secolo Modena 1730 – Bologna 1766 Progetto di altare Studio di architettura inchiostro e acquarello su carta, mm. 422x260; inchiostro e acquarello su carta, mm. 312x197 firmato in basso a sinistra Ioaph. Bonazzi inv. e datato in basso a destra 1775 Stima: € 1.200/1.500 Provenienza: Collezione Vallardi Stima: € 600/800 6 Disegni Antichi 4 a) 4 b) 4 Ferdinando Galli Bibiena Provenienza: Bologna 1657 – 1743 Collezione A. Benois Parigi, Drouot, 16 novembre 1984, lotto 5 a) b) e c) Studi architettonici Collezione Lodewijk Houthakker inchiostro su carta, misure diverse Bibliografia: P. Fuhiring, Design into art, drawings for architecture and ornament. -

INCONTRO CON LA PITTURA 24 Fondantico Di Tiziana Sassoli Via De’ Pepoli, 6/E - 40125 Bologna Tel
INCONTRO CON LA PITTURA 24 Fondantico di Tiziana Sassoli Via de’ Pepoli, 6/E - 40125 Bologna Tel. e Fax 051.265.980 [email protected] www.fondantico.it Restauro e revisione dei dipinti: Liliana e Rodolfo Giangrossi, Milano; Giovanni Pigoni e Davide Tirelli, Reggio Emilia; Licia Tasini, Pieve di Cento (Bologna). Segreteria e ufficio stampa: Maria Cristina Porpora Coordinamento redazionale: Edoardo Battistini © Fondantico - ottobre 2016 Fondantico arte e antiquariato ITINERARI D’ARTE Dipinti e disegni dal XIV al XIX secolo Catalogo a cura di Daniele Benati Testi di Daniele Benati Alessandro Brogi Giacomo A. Calogero Gianluca Del Monaco Massimo Francucci Federico Giannini Irene Graziani Fabio Massaccesi Milena Naldi Anna Ottani Cavina Tommaso Pasquali Elisabetta Sambo Matteo Solferini 4 NOVEMBRE - 23 DICEMBRE 2016 er il ventiquattresimo “Incontro con la pittura” Fondantico ha raccolto una scelta insolitamente ampia di dipinti e disegni, il cui nucleo più corposo P è costituito, secondo la tradizione ormai trentennale della galleria, dagli antichi maestri emiliani. La passione per l’arte e la ricerca, svolta tra importanti collezioni private e aste di tutto il mondo, ha reso possibile una mostra che conta ben trentatré autori e quarantatré opere che spaziano dal Trecento all’Ottocento: da qui il titolo scelto di “Itinerari d’arte”. Il consueto appuntamento autunnale, atteso da collezionisti e appassionati d’arte, si apre con un prezioso trittico del bolognese Simone dei Crocifissi e una Madonna dell’umiltà di Antonio Orsini, protagonista del tardogotico a Ferrara. Ben rappresentati sono il Cinquecento e il Seicento felsinei: quest’ultimo anche grazie alla presenza di due capiscuola come Guido Reni, di cui si espone un’intensa Lucrezia, e il Guercino, al quale spetta un toccante San Giuseppe col Bambino. -
Cento… Storie
Introduzione 3 Piazza Guercino 4 Palazzo del Governatore Palazzo Comunale Ghetto Ebraico, Casa Pannini 5 La Rocca 6 Teatro Comunale e 7 Centro Polifunzionale Pandurera Biblioteche 8 Le Chiese: 10 San Biagio, San Pietro, Rosario, S. Maria Maddalena, Servi, Ss. Sebastiano e Rocco, S. Lorenzo, S. Filippo Oratorio Crocetta Pinacoteca Civica 14 Galleria d’Arte Moderna Aroldo Bonzagni Museo Sandro Parmeggiani Le Frazioni 20 Gastronomia 22 Cento Verde 24 Cento Eventi 26 Ristoranti 30 Alberghi Accessibile Legenda accessibilità Parzialmente accessibile / disabili Accessibile con accompagnatore Non accessibile Cento… storie Il nome di Cento si riferisce alla centuria- zione della Pianura Padana, l’opera di bonifica, deforestazione e suddivisone ter- riera realizzata dai Romani nel II secolo a.C., ma il suo sviluppo, da piccolo borgo di pescatori sperduto nelle paludi (testimo- nianza di tale origine rimane nello stemma cittadino dove spicca un gambero rosso) a centro civico a forte vocazio- ne agricola, è tutto collocato nei primi secoli dopo il Mille. A quest'epoca di estese bonifiche e di donazioni da parte del vescovo di Bologna e dell'abate di Nonantola, risale la nascita della Partecipanza Agraria, l’Istituzione che ridistribuisce a cadenza ventennale i terreni fra i discen- denti maschi delle famiglie che costituirono, nel XII secolo, il nucleo iniziale della comunità. Da sempre terra di confine, Cento, pur essendo proprietà della Chiesa di Bologna, ha subito nei secoli le mire degli stati limitrofi, in particolare del Ducato ferrarese. Nel 1502 il Papa Alessandro VI la sottrasse al dominio del Vescovo di Bologna e la assegnò in dote alla figlia Lucrezia Borgia, promessa sposa al duca Alfonso I d’Este.