Le Isole Minori Elisabetta Vulcano 2009
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Lion's Republic Fight Against the Plague
Bulletin of the Transilvania University of Bra şov • Vol. 6 (51) - 2009 Series 6: Medical Sciences Supplement – Proceeding of The IV th Balkan Congress of History of Medicine THE LION’S REPUBLIC FIGHT AGAINST THE PLAGUE ORIGINATING FROM THE LEVANTE VENETO G. ZANCHIN 1 Abstract: Until its end the Serenissima constantly supported the contagionist hypothesis, playing for all the span of its history the role of pioneer and model for the measures adopted to prevent the diffusion of epidemics. The sanitary preoccupations of the Republic were particularly directed upon people and goods arriving from the territories of the Ottoman Empire from where periodic bouts of plague originated. The examination of the written and iconographic primary sources here considered puts in evidence relevant aspects of the Venetian fight against the plague Key words: Republic of Venice, plague, epidemics, lazaret, quarantine, osella. The experience made during the “tainted” pesthouse, to become later the epidemics of the XIV th century contributed “old” lazaret (Fig. 1 ), the first institution to to the affirmation of the contagionist be established for this purpose. hypothesis of which Venice remained In this last case, according to the vigorous supporter for the entire period of habitual formula, the location was decreed its history [5] as “ healthy (thanks to God) and free from This theory maintained that the cause of any doubt of contagious illness ”: a “fede di the plague, identified with the so called sanità” that is a specific written licence “miasma”, corrupting the air and decom- bearing this statement, was released in posing the bodies, could attach from an such a condition by the local sanitary individual to another, or even adhere itself officers. -
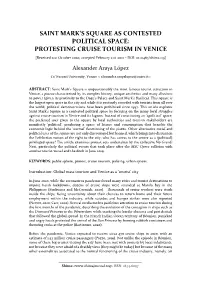
Saint Mark's Square As Contested Political Space
SAINT MARK’S SQUARE AS CONTESTED POLITICAL SPACE: PROTESTING CRUISE TOURISM IN VENICE [ReceiveD 21st October 2020; accepteD February 21st 2021 – DOI: 10.21463/shima.119] AlexanDer Araya López Ca’ Foscari University, Venice < [email protected]> ABSTRACT: Saint Mark’s Square is unquestionably the most famous tourist attraction in Venice, a piazza characterised by its complex history, unique aesthetics anD many allusions to power (given its proximity to the Doge’s Palace anD Saint Mark’s Basilica). This square is the largest open space in the city anD while it is routinely crowDeD with tourists from all over the worlD, political Demonstrations have been prohibiteD since 1997. This article explores Saint Mark’s Square as a contested political space by focusing on the many local struggles against cruise tourism in Venice anD its lagoon. InsteaD of constituting an ‘apolitical’ space, the preferreD uses given to the square by local authorities and tourism stakeholders are manifestly ‘political’, producing a space of leisure and consumption that benefits the economic logic behinD the ‘normal’ functioning of the piazza. Other alternative social anD political uses of the square are not only DiscourageD but banned, which brings into Discussion the Lefebvrian notion of the right to the city: who has access to the centre as a (political) privilegeD space? The article examines protest acts undertaken by the collective No Grandi Navi, particularly the political events that took place after the MSC Opera collision with another tourist vessel anD the Dock in June 2019. KEYWORDS: public sphere, protest, cruise tourism, policing, urban spaces. IntroDuction: Global mass tourism anD Venice as a ‘tourist’ city In June 2020, while the coronavirus panDemic forceD many cities anD tourist Destinations to impose harsh lockDowns, Dozens of cruise ships were stranDeD at Manila Bay in the Philippines (Fonbuena anD McCormick, 2020). -

Venice to Florence
VENICE TO FLORENCE COASTLINES, COUNTRYSIDE, THE APENNINES AND TWO OF ITALY’S FAVOURITE CITIES VENICE TO FLORENCE - SELF GUIDED CYCLING HOLIDAY SUMMARY Cycle from the floating city of Venice along Italy’s east coast, passing Delta Del Po UNESCO World Heritage Site and across the Apennines to the enchanting statue lined streets of Florence. Travelling along farm tracks and quiet roads you will encounter a region of Italy rich in Etruscan history and ever changing landscapes. Departing from Mestre you will cross over the 4km Liberty Bridge into Venice before taking a ferry across to the 11km long sandbar, Lido. After cycling from the length of Lido and its neighbour, Pellestrina Island, you arrive into Chioggia where you will be rewarded with a choice of wonderful seafood restaurants. The following morning a visit to Chioggia’s bustling fish market is highly recommended before heading onwards along quiet country roads, with the River Adige flowing beside you, to the narrow streets and cosy cafes of the 3000 year old Etruscan city of Adria. Tour: Venice to Florence The path then follows the River Po, Italy’s longest river, to the “town of bridges” Comacchio. Code: CITSVF Built on 13 small islands, Comacchio’s ancient stone bridges are an architectural delight and Type: Self-Guided Cycling Holiday Price: See Website offer some fantastic photo opportunities. On leaving Comacchio the landscape takes a twist as Dates: Each Saturday between April - June you cycle along a dam through Delta Del Po National Park, home to 370 bird species. and August - October. Following two very short ferries you shortly arrive at your next destination and home to 8 Alternative arrangements can be made for 6 UNESCO World Heritage Sites, Ravenna. -

Project of Territorial Governance of Tourism in Venice
Project of territorial governance of tourism in Venice Project of territorial governance of tourism in Venice 2 Project of territorial governance of tourism in Venice Table of Contents FOREWORD.............................................................................................................................................................7 FIRST PART:...........................................................................................................................................................11 THE START OF A PARTICIPATORY ROUTE.................................................................................................................11 1. The functions of tourism and the regulatory framework...............................................................................13 2. Tourism in Venice..........................................................................................................................................15 3. The resident population................................................................................................................................22 4. The stages of the participatory route.............................................................................................................25 5. Principal mission statements of the projects presented and adopted by the Technical Working Group..........27 SECOND PART:.......................................................................................................................................................43 OPERATIONAL -

Presentazione I Tesori Della Laguna Venezia 2015
Via Bastie, 112/D – 30034 Dogaletto di Mira (VE) - tel. 348 9491120 www.mavericknauticlub.com - email: [email protected] 16 – 17 maggio 2015 7° EDIZIONE “““I“III TESORI DELLA LAGUNA DI VENEZIAVENEZIA”””” Cari Soci e Amici, benvenuti alla VII° edizione dei Tesori della Laguna di Venezia. Anche quest’anno, andremo alla ricerca di angoli nascosti della nostra laguna, ovvero di qualche luogo che magari abbiamo già visitato con il nostro gommone, ma forse troppo in fretta e senza ben conoscerne la storia. Attraverseremo dunque tutta la laguna partendo da Sud (così potremo anche dar libero sfogo ai nostri cavalli, mare permettendo!), iniziando dalla Valle Millecampi, e per la precisione dal Casone Millecampi, caratteristico esempio di architettura lagunare dei secoli scorsi, inserito in un contesto ambientale molto suggestivo. E' l'unico lembo lagunare della Provincia di Padova, poco lontano da Chioggia, al di la dei grandi scavi di canalizzazione e deviazione dei fiumi Brenta e Bacchighione. Tutt'attorno la terraferma strappata alla laguna con le opere di bonifica iniziate già nel 1500 per volere del ricco possidente, nonché famoso mecenate, Alvise Cornaro. Qui ormeggeremo per una visita al luogo, recentemente ristrutturato. Pranzo al sacco, e nel pomeriggio, partenza per l’Isola della Certosa, situata nelle immediate vicinanze di Venezia, dove ormeggeremo e allestiremo le tende per la notte. L’isola, che fino a 10 anni fa giaceva in stato di abbandono, è stata recentemente interessata da un ampio processo di valorizzazione, nel rispetto dell’ambiente e del particolare contesto storico e ambientale della Laguna di Venezia. Infatti, dapprima è stata costruita una darsena, con circa 300 posti barca fino a 40 metri. -

L'archeologia Nella Laguna Veneziana E La Nascita Di Una Nuova Città
Sauro Gelichi L’archeologia nella laguna veneziana e la nascita di una nuova città Reti Medievali Rivista, XI – 2010/2 (luglio-dicembre) <http://www.rivista.retimedievali.it> Le trasformazioni dello spazio urbano nell’alto medioevo (secoli V-VIII). Città mediterranee a confronto a cura di Carmen Eguiluz Méndez e Stefano Gasparri Firenze University Press Reti Medievali Rivista, XI – 2010/2 (luglio-dicembre) <http://www.retimedievali.it> ISSN 1593-2214 © 2010 Firenze University Press L’archeologia nella laguna veneziana e la nascita di una nuova città di Sauro Gelichi 1. Vampiri a Venezia? «Il ritrovamento venerdì 7 marzo [di quest’anno] [....] nell’isola del Laz- zaretto nuovo a Venezia [...] del teschio di una donna (risalente a metà del 17 secolo), con un mattone in bocca, naturalmente un rito svolto in una creatura deceduta per peste, visto che in quell’isola di Venezia sono stati concentrati diversi corpi di defunti per questo terribile morbo, ci riporta a vecchie leggen- de veneziane che narravano di donne vampiro a Venezia»1. La citazione, che peraltro non ci risparmia macabri passaggi, non appartiene a quella tradizio- ne letteraria, favolistico-fantastica, di cui anche una città come Venezia può vantare una discreta produzione (per quanto di bassa qualità), ma si riferisce a un vero ritrovamento, fatto da un “vero” archeologo, in uno scavo (quello del Lazzaretto Nuovo) giustamente defi nito «una bellissima esperienza di isola- laboratorio dove ricerca sul campo e rifl essione procedono secondo ritmi det- tati dal dialogo e dal confronto di studiosi di varie discipline»2. Al sensazionalismo, si sa, non sfuggono purtroppo gli attuali mezzi della comunicazione: se una banale nuova infl uenza messicana diventa la peste del secolo o se qualche schizzo d’acqua in più si trasforma in un uragano, anche l’archeologia non può uscirne indenne. -

Prima Di Venezia. Terre, Acque E Insediamenti
Prima di Venezia. Terre, acque e insediamenti. Strumenti GIS per una comprensione delle trasformazioni territoriali tra tarda antichità e altomedioevo DIEGO CALAON UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI - VENEZIA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Dottorato di ricerca in ARCHEOLOGIA E STORIA DEI PAESI DEL MEDITERRANEO 18° ciclo, A.A. 2002/2003 – A.A. 2004/2005 PRIMA DI VENEZIA. TERRE, ACQUE E INSEDIAMENTI. STRUMENTI GIS PER UNA COMPRENSIONE DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI TRA TARDA ANTICHITÀ E ALTOMEDIOEVO Tesi di dottorato di DIEGO CALAON n. matr. T. 00275 Coordinatore del dottorato Tutore del dottorando prof. VINCENZO FONTANA Prof. SAURO GELICHI Di Oderzo i figli edificar la bella La gentile Eraclea, di Oderzo i figli, Cui premea la barbarica procella E di Rotari Re stringean gli artigli, … Sorse in breve Eraclea, forte di mura, Forte di torri e dalle fonde valli Che intorno intorno le facean cintura E la chiudean ai fanti e ai cavalli, … L’isole che crescevano ad ora ad ora Di abitatori a Rivolto intorno, Eressero Eraclea a loro signora, e ne resero splendido il soggiorno. A. VECELLIO, Il Piave, poema, Feltre 1903, p. 118. Indice pag. 4 Introduzione PARTE I. PRIMA DI VENEZIA. LAGUNA ED ENTROTERRA. TERRA O ACQUA NELL’ANTICHITÀ? 1. Terra o acqua? 9 1.1. La determinazione geografica dell’area di ricerca. 12 1.2. La determinazione dello spazio, la determinazione dell’attendibilità delle fonti e la filosofia GIS 21 1.3 L’Archeologia nel territorio lagunare negli ultimi anni 23 1.4 Quale paesaggio PARTE II. PRIMA DI VENEZIA. ALTINO E CITTANOVA 2.1. Altino 25 2.1.1 La sperimentazione della piattaforma GIS: il territorio di Altino 31 2.1.2 Altino nell’altomedieoevo 33 2.1.3 Da Altino a Torcello 2.2 Cittanova 36 2.2.1 Cittanova secondo la tradizione 37 2.2.2 Il problema del nome 39 2.2.3 La scoperta di una città 40 2.2.4 Una nuova analisi su vecchi dati. -

Curriculum Laguna Membership La Venessiana
C U R R I C U L U M 2 0 2 0 / 2 1 Laguna in Cucina M E M B E R S H I P created by: L A V E N E S S I A N A - V E N E Z I A CURRICULUM 0 2 Virtual visits to Venice + Lagoon. Gourmet Classes Listen + watch Venetian stories (audio + video), come along on virtual visits around the hidden Venice, learn to cook our seasonal menus, and explore the Lagoon islands in the videos tours. New content drops weekly (every Tuesday). Here's the syllabus for the first 12 months + 3 very special bonuses! CASSIS AND CALENDULA: The Almanac; the story of Campo San Lorenzo and Marco Polo - Ferragosto menu + summer comfort food + visit AUGUST to Sacca Sessola, August recipe box. Herb of the month: the curry plant; How Venice dealt with pandemics CORIANDER AND UVA FRAGOLA: The Almanac; Disnar de la Regata storica (traditional menu), Mondays on the Lido, Harvesting uva fragola grapes + cake recipe, Autumn equinox in Venice, SEPTEMBER a virtual visit to Poveglia, September recipe box. Herb of the month: coriander SQUASH AND POMEGRANATE: The Almanac; San Firmino; Lepanto day in Venice; Wine harvest in the Lagoon; Spicy Venetian squash soup; recipes OCTOBER with pomegranates; October recipe box, Pan di pistacchio - the Doge's Pistacchio cake, Virtual visit to San Francesco del Deserto. CHESTNUTS AND LIQUORICE: The Almanac, All Saints Day in Venice + recipes, Virtual visit to the islands San Michele / San NOVEMBER Cristoforo, San Martino in Venice, comfort food for fall, Recipe box, The true story of Festa della Salute - Thanksgiving in Venice + recipes PERSIMMON AND BERGAMOT: The Almanc, the Venetian Christmas cake - la pinza; Foraging for DECEMBER winter herbs in the Lagoon; Winter solstice menu; Christmas flavors from Venice; New Years Eve; Recipe box, le nuvoete - fluffy Christmas cookies CURRICULUM 0 2 Virtual visits to Venice + Lagoon. -

Veneziaterreing.Pdf
ACCESS SCORZÉ NOALE MARCO POLO AIRPORT - Tessera SALZANO S. MARIA DECUMANO QUARTO PORTEGRANDI DI SALA D'ALTINO SPINEA MIRANO MMEESSTTRREE Aeroporto Marco Polo SANTA LUCIA RAILWa AY STATION - Venice MARGHERA ezia TORCELLO Padova-Ven BURANO autostrada S.GIULIANO DOLO MIRA MURANO MALCONTENTA STRÀ i ORIAGO WATER-BUS STATION FIESSO TREPORTI CAVALLINO D'ARTICO FUSINA VTP. - M. 103 for Venice PUNTA SABBIONI RIVIERA DEL BRENTA VENEZIA LIDO WATER-BUS STATION MALAMOCCO VTP - San Basilio ALBERONI z S. PIETRO IN VOLTA WATER-BUS STATION Riva 7 Martiri - Venice PORTOSECCO PELLESTRINA P PIAZZALE ROMA CAe R PARK - Venice P TRONCHETTO CAR PARK - Venice P INDUSTRIAL AREA Cn AR PARK - Marghera P RAILWAY-STATION CAR PARK - Mestre e P FUSINA CAR PARK - Mestre + P SAN GIULIANO CAR PARK - Mestre V P PUNTA SABBIONI CAR PARK - Cavallino The changing face of Venice The architect Frank O. Gehry has been • The Fusina terminal has been designed entrusted with developing what has been by A. Cecchetto.This terminal will be of SAVE, the company that has been run- • defined as a project for the new airport strategic importance as the port of entry ning Venice airport since 1987 is exten- marina. It comprises a series of facilities from the mainland to the lagoon and ding facilities to easily cope with the con- that are vital for the future development historical Venice. stant increase in traffic at Venice airport. of the airport, such as a hotel and an The new airport is able to process 6 mil- The new water-bus station has been desi- administration centre with meeting and • lion passengers a year. -

Tra Sacro E Quotidiano. Il Monachesimo Femminile Nella Laguna Di Venezia in Epoca Medievale (Secoli IX-XIV)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO SCUOLA DI DOTTORATO Humanae Litterae DIPARTIMENTO Scienze della Storia e della documentazione storica CORSO DI DOTTORATO Storia Medievale XXIV ciclo Tra sacro e quotidiano. Il monachesimo femminile nella laguna di Venezia in epoca medievale (secoli IX-XIV) M-STO/01 Storia medievale DOTTORANDA: Silvia Carraro TUTOR: Ch.ma Prof. Elisa Ester Occhipinti COORDINATORE DEL DOTTORATO: Ch.ma Prof. Elisa Ester Occhipinti A.A. 2011-2012 O Isnarde monache, quantum est amanda, a te atque ac ab omnibus multum veneranda Virgo Christi genistrix atque conlaudanda, quia te eripuit et multos tristantes in procellis positos ipsam invacantes, munimen de periculis ad eam clamentes, ipsos cunctos adiuvat sua bonitate de mortis periculo eius sanctitate. Ipsa ergo invocamus atque laudes conferamus pio corde supplicamus tali semper domine. Ipsa celi est regina cunctis namque matre divina atque mundi domna. San Giorgio maggiore, doc. n. 68, attegato C sec. XII. i ii Tra sacro e quotidiano. Monachesimo femminile nella laguna di Venezia in epoca medievale (secc. IX-XIV) Indice Sigle e abbreviazioni p. vi Una storia da scrivere p. vii I. Sulle tracce del monachesimo femminile p. 1 1. Origini e fondazioni: tra documenti e tradizione p. 3 2. Il doge e i monasteri femminili: il potere e il sacro p. 13 3. Monasteri di donne p. 24 4. Monache e badesse p. 29 5. Forme di vita religiosa femminile (secoli X-XII) p. 38 6. Venti di riforma p. 45 7. San Zaccaria e Cluny p. 49 II. Esperimenti di vita religiosa tra monasteri e ospedali p. 57 1. Monacha, conversa, devota. -

The Evolution of Landscape in Venetian Painting, 1475-1525
THE EVOLUTION OF LANDSCAPE IN VENETIAN PAINTING, 1475-1525 by James Reynolds Jewitt BA in Art History, Hartwick College, 2006 BA in English, Hartwick College, 2006 MA, University of Pittsburgh, 2009 Submitted to the Graduate Faculty of The Dietrich School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2014 UNIVERSITY OF PITTSBURGH KENNETH P. DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by James Reynolds Jewitt It was defended on April 7, 2014 and approved by C. Drew Armstrong, Associate Professor, History of Art and Architecture Kirk Savage, Professor, History of Art and Architecture Jennifer Waldron, Associate Professor, Department of English Dissertation Advisor: Ann Sutherland Harris, Professor Emerita, History of Art and Architecture ii Copyright © by James Reynolds Jewitt 2014 iii THE EVOLUTION OF LANDSCAPE IN VENETIAN PAINTING, 1475-1525 James R. Jewitt, PhD University of Pittsburgh, 2014 Landscape painting assumed a new prominence in Venetian painting between the late fifteenth to early sixteenth century: this study aims to understand why and how this happened. It begins by redefining the conception of landscape in Renaissance Italy and then examines several ambitious easel paintings produced by major Venetian painters, beginning with Giovanni Bellini’s (c.1431- 36-1516) St. Francis in the Desert (c.1475), that give landscape a far more significant role than previously seen in comparable commissions by their peers, or even in their own work. After an introductory chapter reconsidering all previous hypotheses regarding Venetian painters’ reputations as accomplished landscape painters, it is divided into four chronologically arranged case study chapters. -

Contributo Di Accesso
CONTRIBUTO DI ACCESSO Proposta di delibera sul Regolamento per l’istituzione e la disciplina Elaborata con la collaborazione di: Intervento integrato • Messa a regime in 3 anni, conobiettivo l’obbligo della prenotazione per la gestione dei flussi, come indicato nel report inviato all’UNESCO • Conferma ZTLZTLZTL perperper l’accesso allaallaalla Città antica e avvio iter per l’assoggettamento al pagamento di una somma per i veicoli privati a motore, come già previsto dal Piano Urbano del Traffico • Campagna promozionale sulla stampa nazionale ed internazionale del progetto###EnjoyRespectVenezia #EnjoyRespectVenezia • Rafforzamento nel 2019 delcontingente dididi Polizia Locale, conconcon almeno 505050unitàunità, per aumentare il presidio ed il controllo della città. Perimetro di applicazione Il perimetro di applicazione è individuato: • nell’Ambito Territoriale Omogeneo nnn. n...111 “Venezia Città Antica” allegato al Piano di Assetto del Territorio; • ininintutte lelele “isole minori della laguna” deldeldel Comune dididi VeneziaVenezia: Lido di Venezia - Malamocco - Alberoni - Pellestrina - Cà Roman - Murano - Burano - Torcello - Mazzorbo - Mazzorbetto - San Francesco del Deserto - Sant’Erasmo - Vignole - Certosa - Sant’Andrea - San Servolo - San Lazzaro degli Armeni - San Clemente - La Grazia - Sacca Sessola - Poveglia - Lazzaretto Vecchio - Lazzaretto Nuovo - Madonna del Monte - San Ariano - San Giacomo in Paludo - Fisolo - San Giorgio in Alga - Sant’Angelo della Polvere - Santo Spirito - San Secondo - La Cura - Santa Cristina - Motta San