Lxxiii-2 Settembre 2 019 Nuova Serie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

RAPID Ceirano & C., Welleyes, F.Lli Ceirano
RAPID Ceirano & C., Welleyes, F.lli Ceirano, STAR Rapid, Matteo C. & C., Itala, Ceirano-Ansaldo, SPA, Junior, SCAT, S.A.Giovanni Ceirano: sono undici aziende, accomunate da due denominatori, sono tutte nate a Torino e sono tutte sorte per iniziativa di uno o dell'altro dei fratelli Ceirano. Addentrarsi nelle vite e nelle frenetiche attività dei quattro fratelli, distinguendo l'apporto di ciascuno, non è facile. I Ceirano sono una famiglia piemontese, originaria di Cuneo, composta da padre, madre e quattro fratelli: Giovanni Battista, nato nel 1860, Giovanni, nato nel 1865, Matteo, il viveur della famiglia, di cinque anni più giovane, ed Ernesto, nato dopo altri cinque anni. A questi si aggiunge in un secondo tempo il figlio di Giovanni che, con una certa mancanza di fantasia, è battezzato Giovanni e chiamato Ernesto. Come si vede, ci sono già i presupposti per una bella confusione, anche a prescindere dai rispettivi caratteri, che sicuramente devono essere stati piuttosto determinati, per non dire litigiosi e testardi, anche perché uno dopo l'altro si consacrano al medesimo mestiere: fondare aziende automobilistiche. Fondare, per poi andarsene, o fonderle con altre, o scioglierle, o rilevarle, in un caleidoscopio di società che vivacizzarono ed arricchirono molto il panorama industriale torinese ed italiano. Il primo a muoversi è naturalmente Giovanni Battista, il più anziano. Fonda la Ceirano & C. nel 1898 e la Welleyes nel 1899; quindi nel 1901, insieme a Matteo, la F.lli Ceirano, in corso Vittorio Emanuele 9. Liquidata questa nel 1903, nel 1904 trasforma la Ceirano & C. in STAR, Società Torinese Automobili Rapid, oggetto di questa breve indagine. -

San Salvario Il Quartiere Della Nascita Dell'auto a Torino
San Salvario Il quartiere della nascita dell'auto a Torino A cura di Enrico Miletto, Fondazione Vera Nocentini e Donatella Sasso, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini 1 Origini e topografia del quartiere Il quartiere deriva il proprio nome dalla chiesa di San Salvatore in Campagna (da qui la popolare denominazione di San Salvario), edificata da Amedeo di Castellamonte tra il 1646 e il 1653, per volontà della Madama Reale Cristina di Francia. Da un punto di vista topografico, l’area di San Salvario è delimitata dai corsi Massimo d’Azeglio, Vittorio Emanuele II, Bramante e dalla via Nizza. Il borgo vero e proprio inizia a prendere forma soltanto a partire dalla metà dell’Ottocento, quando sorgono i primi insediamenti urbani, attigui alla campagna circostante. Orti, giardini, campi e vivai definiscono la porzione di territorio che dalla strada reale di Nizza (l’attuale via Nizza) arriva fino al Valentino. 2 Porta Nuova e commercio 1848-1852 Viene inaugurato il primo tratto ferroviario che collega Torino a Moncalieri seguito, nel 1853, da quello con Genova. Lo sviluppo dello scalo ferroviario di Porta Nuova, la cui direttrice divide San Salvario dai vicini rioni della Crocetta e di San Secondo, favorisce la crescita nel quartiere di attività commerciali. Sorgono così botteghe e aziende artigianali che contribuiscono a disegnare un’immagine di un quartiere dai ritmi concitati, una piccola city, operosa e indaffarata, le cui strade, ricche di negozi e botteghe, sono percorse, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, da carri trainati da cavalli, tramways e carretti. San Salvario conta all’epoca 50 isolati, circa 200 abitazioni ed è sede di una delle 10 preture cittadine. -
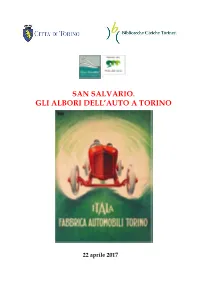
San Salvario. Gli Albori Dell'auto a Torino
SAN SALVARIO. GLI ALBORI DELL’AUTO A TORINO 22 aprile 2017 Il testo e le immagini derivano dal progetto didattico “ Torino e le fabbriche ” che si rivolge alle scuole secondarie di primo e secondo grado torinesi ed è mirato alla lettura della storia industriale del territorio e a una riflessione sull’evoluzione industriale e sociale della città. Il progetto è realizzato dall’ISMEL (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali). San Salvario: gli albori dell’auto a Torino. A cura di Enrico Miletto TORINO E L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA. DA FINE OTTOCENTO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE Le principali tappe dello sviluppo dell’industria automobilistica torinese e italiana, con un riferimento costante al contesto internazionale. Conferenze a cura di Aldo Enrietti, volontario del progetto Senior civico . SAN SALVARIO. GLI ALBORI DELL’AUTO A TORINO Sabato 22 aprile, ore 10.30 Una camminata nel quartiere avvia un percorso in più tappe sulla storia dell’industria automobilistica a Torino da fine Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, in programma presso la Biblioteca centrale a partire dal 26 aprile. A cura di Enrico Miletto ( Fondazione Nocentini – Polo del ‘900) e Aldo Enrietti , volontario del progetto Senior civico. INCONTRI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE Mercoledì 26 aprile, ore 17.30 Dalla carrozza all’automobile Storia del progressivo passaggio da un mezzo di trasporto all’altro, con particolare attenzione all’industria automobilistica torinese dalla fine dell’Ottocento alla Prima Guerra Mondiale. Mercoledì 10 maggio, ore 17.30 I protagonisti dell’automobile a Torino Le imprese storiche in città: i fratelli Ceirano, Giovanni Agnelli, Vincenzo Lancia. -

LANCIA Storie Di Innovazione Tecnologica Nelle Automobili Storie Di Innovazione Tecnologica Nelle Automobili
LORENZO MORELLO LANCIA Storie di innovazione tecnologica nelle automobili Storie di innovazione tecnologica nelle automobili LORENZO Morello LANCIA Storie di innovazione tecnologica nelle automobili Editing, progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino © 2014 Lorenzo Morello Stampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. PRESENTAZIONE volontari del progetto STAF (Storia della Tecnologia delle Automobili FIAT), istituito nel 2009 al fine di selezionare i disegni tecnici più rilevanti per documentare l’e- I voluzione tecnica delle automobili FIAT, sono venuti a contatto anche con i disegni Lancia, contenuti in una sezione dedicata dell’Archivio Storico FIAT: il materiale vi era stato trasferito quando, nel 1984, la Direzione tecnica di FIAT Auto, il settore aziendale incaricato di progettare le automobili dei marchi FIAT, Lancia e Autobianchi, era stata riunita in un unico fabbricato, all’interno del comprensorio di Mirafiori. Fu nell’oc- casione del ritrovamento di questo nucleo di disegni che i partecipanti al progetto si proposero di applicare il metodo impiegato nel predisporre il materiale raccolto nel libro FIAT, storie di innovazione tecnologica nelle automobili, anche per preparare un libro analogo dedicato alle automobili Lancia. Questo secondo libro, attraverso l’esame dei disegni tecnici, del materiale d’archivio e delle fotografie di automobili sopravvissute, illustra l’evoluzione delle vetture Lancia e i loro contenuti innovativi, spesso caratterizzati da elementi di assoluta originalità. Il reperimento del materiale si è mostrato, tuttavia, più arduo rispetto al lavoro sulle vetture FIAT, almeno per le automobili più anziane, poiché l’archivio dei disegni Lancia era organizzato senza impiegare una struttura logica di supporto, per distinguere agevolmente i diversi gruppi funzionali dai particolari di puro dettaglio. -

I Primi Veicoli in Italia
I PRIMI VEICOLI IN ITALIA 1882-1899 DAL VENETO I PRIMI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA E LE PRIME VETTURE AISA·Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile in collaborazione con HCS·Historic Club Schio Vicenza ·Aula Magna dell’Università 29 marzo 2008 II I PRIMI VEICOLI IN ITALIA 1882-1899 DAL VENETO I PRIMI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA E LE PRIME VETTURE AISA·Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile in collaborazione con HCS·Historic Club Schio Vicenza ·Aula Magna dell’Università 29 marzo 2008 3 Presentazione Lorenzo Boscarelli 4 Michele Lanza, la Fiat, l’anno 1898 Antonio Carella 0 La nascita dei veicoli a motore - Il ruolo dei precursori italiani Stefano Milani 0 La vettura a tre ruote del professor Enrico Zeno Bernardi Guido Ardizzon 0 La vetturetta di Carlo Menon Zeno Graziani 0 La prima autovettura circolante in Italia Fabrizio Taiana 0 Precursori veneti dell’automobile Nino Balestra MONOGRAFIA AISA 81 Un ignoto corridore motociclista posa accanto alla Menon 200 cc. da corsa. La foto li ritrae di fronte alle Officine Menon e risale alla metà degli anni Venti. La motocicletta montava un motore Alba, di fabbricazione tedesca, a quattro tempi e valvole laterali, il cambio era a due velocità, prodotto dalla Ideal. 2 PRESENTAZIONE Lorenzo Boscarelli ggi parleremo di uomini e di macchine dei pri- mobili nell’ultimo ventennio dell’Ottocento e nei Omordi della storia dell’automobile, la cui notorie- primi anni del Novecento non solo dovette cimentarsi tà non è sempre correlata all’importanza che hanno con un meccanismo molto complesso, ma dovette effettivamente avuto nell’evoluzione della tecnica, ma anche dare prova di grande fantasia, creando dal nulla ad eventi anche casuali, come la sopravvivenza del vei- soluzioni nuove. -

Mustang Classic & Modern the Icon Keeps Galloping
PORSCHE 928 LANCIA LAMBDA BMW E28 M5 R47.00 incl VAT December 2016 MUSTANG CLASSIC & MODERN THE ICON KEEPS GALLOPING LONE RANGER FORGET PARYS SA’S OWN GM RANGER HAILWOOD’S ILL-FATED ISO GRIFO FORD SOYA BEAN CAR | BMW 333I & M1 | DATSUN 510 SSS COUPÉ Porsche Classic_210x276.qxp_Porsche 210x275 2016/11/11 11:24 AM Page 1 www.porschecapetown.com Our goal: As good as new. Porsche Centre Cape Town. As a Porsche Classic Partner, our goal is the maintenance and care of historic Porsche vehicles. With expertise on site, Porsche Centre Cape Town is dedicated to ensuring your vehicle continues to be what it has always been: 100% Porsche. Our services include: • Classic Sales • Classic Body Repair • Genuine Classic Parts • Classic Service at special rates Porsche Centre Cape Town Corner Century Avenue and Summer Greens Drive, Century City Tel: 021 555 6800 CONTENTS — CARS BIKES PEOPLE AFRICA — DECEMBER 2016 THAT’S A WRAP KILLARNEY SPORTS CAPE’S FINEST 03 Editor’s point of View 70 Killarney Motor Show DRIVE-IN DELIGHT A MANUFACTURER GETS REAL 04 Franschhoek Motor Museum News 72 ABOUT HERITAGE Ford Heritage Day NEWS & EVENTS 12 The latest from the classic scene STUTTGART STARS IN THE CAPE 76 Mercedes-Benz Pagoda Run LETTERS 20 Have your say CRADLING HERITAGE 80 BMW SA 333i & M1 restored FULL FRONTAL ASSAULT 24 Porsche 928 THE HEALTHY OPTION 84 Henry Ford’s soya bean CARBS & COFFEE 30 German Steel Toyz OLD TIMERS BRING JOY 88 TO YOUNGSTERS HORSES FOR ALL COURSES Century Classic Car Run 32 Ford Mustang READER’S RIDE VINTAGE SPEARHEAD 90 A rare Singer rebuild 38 Lancia Lambda Tourer GEARBOX BLITZ BOKKE 94 Classified adverts 44 General Motors Ranger BACKSEAT DRIVER – FORGET PARYS 96 A FEMALE PERSPECTIVE 50 Mike Hailwood and Iso Grifo Classically trained DOUBLE O HEAVEN 56 Cars from James Bond BAHN STORMER 60 BMW E28 M5 TRANS-FORMING THE BRAND 64 Datsun 510 SSS CLOSE BUT NO CIGAR 68 WMD Mystery Car 44 www.classiccarafrica.com | December 2016 | 1 FOR BOOKINGS 0861 11 9000 proteahotels.com IF PETROL RUNS IN YOUR VEINS, THIS IS A SIREN CALL TO THE OPEN ROAD.. -

Automobili Made in Italy Più Di Un Secolo Di Storia Fra Miti E Rarità
Automobili Made in Italy Più di un Secolo di Storia Fra Miti e Rarità Tavola rotonda AISA·Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile in collaborazione con Museo dell’Automobile “L. Bonfanti - Vimar” Romano d’Ezzelino (Vicenza) 1 marzo 2008 MUSEO DELL’AUTOMOBILE BONFANTI - VIMAR 01 Automobili Made in Italy Più di un Secolo di Storia Fra Miti e Rarità Tavola rotonda AISA·Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile in collaborazione con Museo dell’Automobile “L. Bonfanti - Vimar” Romano d’Ezzelino (VI) 1 marzo 2008 2 Introduzione Lorenzo Boscarelli 3 Aurea e Marino, due marche da riscoprire Nino Balestra 10 La Cemsa Caproni Luigi Lazzaroni 13 La rinascita del marchio Bugatti Romano Artioli In Copertina: chassis Aurea modello 500, Cemsa Caproni F11, Marino 1500 corsa, Bugatti EB 110 MONOGRAFIA AISA 80 Introduzione Lorenzo Boscarelli a tavola rotonda, i cui contenuti sono pubblicati che che fortunatamente non sono mai venute meno. Lin questa Monografia, ripercorre un lungo periodo Ce le descrivono persone che ne hanno una profonda di storia della motorizzazione in Italia e ci dimostrerà conoscenza, a volte per esserne stati protagonisti di- quanto variegato sia stato il mondo dell’automobile nel retti: si parlerà di due iniziative sorte fra le due guerre nostro Paese anche al di fuori delle grandi Marche. a Torino e a Padova, di un fenomeno tecnico molto Parleremo di iniziative di straordinario interesse originale dell’ultimo dopoguerra, la Cemsa-Caproni tecnico realizzate in varie parti del nostro paese, e della rinascita della Bugatti negli anni Ottanta e basate sulla passione e sull’inventiva, caratteristi- Novanta. -

La Storia Del Logo Fiat
La storia del logo Ceirano Accomandita Ceirano & C. Nazione Italia Fondazione 1898 a Torino Fondata da Giovanni Battista Ceirano, Emanuele di Bricherasio, Attilio Calligaris, Pietro Fenoglio e Cesare Goria Gatti Chiusura 1923 Sede principale Torino Settore casa automobilistica Prodotti autovetture La accomandita Ceirano GB & C fu una storica azienda automobilistica, fondata nell'ottobre del 1898 da Giovanni Battista Ceirano, Emanuele di Bricherasio, Attilio Calligaris, Pietro Fenoglio e Cesare Goria Gatti. La storia La sede della neonata azienda fu fissata a Torino in corso Vittorio Emanuele 9, dove nel 1899 si cominciò a costruire una piccola autovettura a due posti, la Welleyes, progettata dall'ingegnere Aristide Faccioli. Quando la Welleyes fu messa in produzione ci fu un grandissimo successo commerciale per la Ceirano, però i dirigenti si ritrovarono incapaci a far fronte alle ordinazioni della vetturetta. Allora nel mese di Luglio dello stesso anno il proprietario della Casa torinese, Giovanni Battista Ceirano, decise di cedere gli impianti e brevetti della sua azienda a Giovanni Agnelli. Per questo, Ceirano dovette lavorare per un periodo in Fiat, ma nel 1901 lasciò la Casa per rimettersi a lavorare in proprio, insieme a suo fratello Matteo. La collaborazione tra i fratelli termina già nel 1903 quando Matteo lascia l'azienda e Giovanni Battista insieme all'altro fratello Giovanni fonda la G.G. Fratelli Ceirano. Anche questa avventura dura poco, infatti Giovanni lascia il fratello il quale nel 1904 trasforma la società in Ceirano & C. che in seguito sarà ribattezzata STAR o Rapid. Questa è l'ultima trasformazione in quanto Giovanni Battista muore nel 1912. La fabbrica verrà rilevata dal fratello Giovanni che proseguirà l'attività ancora per qualche anno. -

2017 02135/064 Area Partecipazioni Comunali MP 0/B
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2017 02135/064 Area Partecipazioni Comunali MP 0/B CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 6 giugno 2017 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori: Roberto FINARDI Paola PISANO Stefania GIANNUZZI Sergio ROLANDO Marco GIUSTA Alberto SACCO Francesca Paola LEON Sonia SCHELLINO Federica PATTI Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora Maria LAPIETRA. Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. OGGETTO: CIMITERO MONUMENTALE - POSA DI CIPPO FUNERARIO E TARGA COMMEMORATIVA IN MEMORIA DI GIOVANNI BATTISTA CEIRANO E DEI SUOI FRATELLI. 2017 02135/064 2 Proposta dell’Assessore Giusta. Il RACI (Registro Ancetres Club Italia), con lettera protocollata numero 799/2017 del 21 marzo 2017, esprimeva la volontà di commemorare la memoria di Giovanni Battista Ceirano e dei suoi fratelli Giovanni e Matteo e la storia della locomozione a Torino, con la posa di un cippo funerario e di una targa commemorativa presso il Cimitero Monumentale di Torino, essendo ivi sepolti. La Città di Torino, avendo valutato la richiesta meritevole di accoglimento in virtù dell’importanza rivestita dai fratelli Ceirano nello sviluppo dell’industria automobilistica della città di Torino e nell’ottica di perseguire una sempre maggiore valorizzazione del proprio patrimonio cimiteriale, ha invitato, con nota protocollo 838/2017 del 22 marzo 2017, AFC Cimiteri Spa, in qualità di soggetto gestore dei cimiteri cittadini, a farsi parte attiva nei confronti dell’Associazione, al fine di definire il luogo della posa e le caratteristiche tecniche del progetto, nonché a definire il contenuto dell’epigrafe. Successivamente, con lettera protocollata numero 1525 del 19/05/2017, l’Associazione RACI trasmetteva agli uffici della Città il progetto contenente disegni, fotografia ed epigrafe, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (all. -

Lezione 6 Industria Dell'auto File
L’evoluzione dell’industria dell’automobile in Italia: Il caso di Torino Si ringraziano Aldo Enrietti e Ken Simons per l’utilizzo dei loro lucici Aldo Geuna Indice Gli albori dell’auto: fine ottocento primi del novecento, nasce un industria. – USA, Italia, Torino I principali attori dello sviluppo dell’auto a Torino: – Ceirano, Lancia, FIAT L’evoluzione dell’industria dell’auto negli USA: Il Fordismo, il modello T L’evoluzione dell’ industria dell’auto in Italia ed a Torino L’evoluzione dell’industria dell’auto e lo Shakeout Gli albori dell’auto GLI ALBORI DELL’AUTO: fine ‘800, Inizio del ‘900 1.1 L’AUTO COME PRODOTTO 1.2 L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA NEGLI USA E IN EUROPA 1.3 L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA IN ITALIA E A TORINO 1.1 L’AUTO COME PRODOTTO Nasce per sostituire la trazione animale e si è servita, di volta in volta, di motori diversi a seconda dei sistemi di alimentazione Il primo prototipo funzionante è del 1769 ed ha un motore a vapore: il carro di CUGNOT era in grado di trainare 4 ton. di peso Gli sviluppi del motore a vapore furono tali che già nel 1828 le città di Londra e Bath erano collegate da autobus, appunto a vapore Durante il 1800 si svilupparono ricerche sia per il motore endotermico che per quello elettrico: quest’ultimo si dimostrava assai performante, al punto che nel 1899 Camille Jenatzy superava i 100 km/h con La Jamais Contente Bisogna aspettare la fine del secolo XIX per vedere le prime vetture circolanti Un salto in avanti nella motorizzazione avvenne nel 1876 grazie a Nikolaus August Otto, inventore del primo motore a combustione interna a quattro tempi. -

Med Två Engelsmän, Simon Tate Och Simon Brown I En Lancia Fulvia 1600 HF Fanalone, Gick Starten I Årets Historiska Monte Carlorally Från Grand Hotel I Stockholm
Med två engelsmän, Simon Tate och Simon Brown i en Lancia Fulvia 1600 HF Fanalone, gick starten i årets historiska Monte Carlorally från Grand Hotel i Stockholm. Innehåll i detta nummer bl.a. : Sid. 3, Klubbpresentation Sid. 4-9 Ordföranden reste till Turin med sonen. Sid. 10-11 Kallelse till Årsmöte samt verksamhetsberättelsen 2013. Sid. 12 Kommande träffar Sid. 13-14 Nordisk träff i Danmark Sid. 15-16 Inbjudan till Aktiv Träff , Gröndal Sid. 17-20 Hectors Resa Del.2 Sid. 21-25 Rallye Monte Carlo Historique 2014 Sid. 26 Ord av Lars Filipsson Sid. 27 1906 års annons från Göteborg Sid. 28 Årsavslutning i Stockholm Sid. 29-31 Salutorg och annonser I hela Europa är man mycket oroad över märket Lancias framtid. SVENSKA LANCIAKLUBBEN Syfte Klubbens syfte är att samla intresserade Lanciaägare och personer med genuint intresse av dessa bilar för att under trivsamma former: • Öka medlemmarnas insikt i allt som berör Lanciabilarnas teknik, egenskaper, skötsel och historia samt bistå vid problem. • Informera om och ventilera andra frågor som berör veteranbilshobbyn samt relaterade produkter och teknologi. • På bästa sätt bevaka reservdelsfrågan. Styrelse Lars Filipsson. suppleant Herbert Nilsson. Ordförande o Heders- Grahamsvägen 5, 174 46 Sundbyberg president / ansvarig utgivare La Lancia. Tel. 08-6282443 Mob. 070-252 10 15 Jacob Ulfssons väg 7A, 647 32 Mariefred E-mail [email protected] Tel. 0159-108 42 Mob. 070-910 94 05 E-mail [email protected] Lanciamodeller Kontaktpersoner Magnus Nilsson. v.ordf. / ledamot Lambda Herbert Nilsson Baravägen 7, 241 33 Eslöv Aprilia Owe Persson Tel. 0413-706 36 Mob.070-301 52 20 Appia Rolf Nylén E-mail [email protected] Aurelia Robert Lilja Robert Lilja. -

Vicoforte Le Prime Auto Correvano Sulle Strade Del Monregalese Vecchie Signore
L’UNIONE MONREGALESE - 31 LUGLIO 2019 - N. 30 - PAG. 29 ... I speciale a cura di RAFFAELE SASSO DEBORA SATTAMINO PAOLO ROGGERO MARCO TURCO Week end con le Comuni di Mondovì Briaglia Vicoforte Le prime auto correvano sulle strade del Monregalese Vecchie Signore Il libro sui leggendari Ceirano è in vendita nelle librerie di Mondovì. Per informazioni: uffi cio 30-31 1º de “L’Unione Monregalese”, a Breo, luglio agosto 2021 per e-mail: [email protected] II ... L’UNIONE MONREGALESE - 28 LUGLIO 2021 - N. 30 - PAG. 30 Week-end con le Vecchie signore Un omaggio LA REGINA ai fratelli Ceirano I cuneesi primi Ci sarà anche “Itala” al raduno: costruttori di auto E siamo alla vigilia… Mondovì, Vicofor- te e Briaglia, venerdì 30, sabato 31 luglio e vinse il raid Pechino-Parigi 1907 domenica 1° agosto ospitano l’appunta- mento con le “Vecchie Signore”, auto e moto, prodotte tra il 1900 ed il 1940, orga- Seguita dal curatore del Museo nazionale dell’automobile di Torino, Davide Lorenzone nizzato da Mario Garbolino – presidente di “Mondovì motori” – confluito nel “Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori” di Alben- La Regina, lei, la “Itala” che vinse il ga (il più grande d’Italia nel settore auto e raid Pechino-Parigi, nel 1907, arrivando moto d’epoca). Grazie alla squadra e alla al traguardo con venti giorni di anticipo disponibilità di Antonio Paganel, archivio sulle altre vetture in gara, dirette con- storico vivente dei Ceirano, e al suppor- correnti francesi e olandese, che fa par- to dell’imprenditore monregalese Enzo te della collezione del Museo nazionale Garelli, ecco le monografie, “La storia sia- dell’automobile di Torino, sarà esposta mo noi” col primo libro dedicato ai “Fra- al “Week end con le Vecchie Signore” di telli Ceirano - I cuneesi primi costruttori venerdì 30, sabato 31 luglio e domenica di automobili in Italia”, nel 1898, edito da 1° agosto, in programma a Mondovì, Vi- “CEM” e realizzato grazie allo sponsor, la coforte e Briaglia.