Itinerari Di Architettura Milanese
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

LEZIONE 9 – Dal Cordusio Al Castello Sforzesco (DIA 1)
LEZIONE 9 – Dal Cordusio al Castello sforzesco (DIA 1) ( DIA 2) Il nuovo itinerario di Milano che iniziamo oggi parte da piazza Cordusio, prosegue per via Dante, per raggiungere infine il castello sforzesco con le sue gallerie d’arte. Usciti poi dal castello, inizieremo la visita del Parco Sempione, il più grande giardino pubblico all’interno delle mura spagnole, con l’acquario, l’Arena, l’arco della Pace, e il palazzo dell’Arte. Ritorneremo poi in via Dante attraverso via Boccaccio, la stazione delle Ferrovie Nord Milano, il teatro e il palazzo Dal Verme. Piazza Cordusio ( DIA 3) ) è una delle più importanti piazze milanesi, anche per funzione viabilistica e strategiche. È da sempre centro storico e nevralgico della città, di elevato rilievo storico e artistico. Crocicchio già in epoca imperiale, il Cordusio divenne importante con l’avvento dei Longobardi. Infatti, trent’anni dopo la distruzione di Milano (538-539) ad opera degli Ostrogoti, scende in Italia nel 569, il re dei Longobardi, Alboino. Da allora l’area divenne Langobardia, e in seguito Lombardia. Con la scomparsa di Alboino nel 572, la Provincia venne divisa fra i tre generali (che divennero duchi). Ad Albino toccò la “desolata Milano”. Il suo palazzo, che sorgeva nell’odierna piazza, era detto “De curte ducis” (o “Curia ducis“, ossia la corte dei duchi lombardi), da cui per corruzione “Cortedoxi“, quindi “Corduce” e infine “Corduso” o “Cordusio“. La corte ducale venne subito soppiantata dal nuovo palazzo del Broletto vecchio (Palazzo Reale) e il palazzo al Cordusio venne smembrato e probabilmente attraversato dalla contrada delle Galline. -

Marzo - Aprile 2021 PROGRAMMA DELLE PROPOSTE CULTURALI Marzo - Aprile 2021 RIEPILOGO DELLE PROPOSTE CULTURALI
marzo - aprile 2021 PROGRAMMA DELLE PROPOSTE CULTURALI marzo - aprile 2021 RIEPILOGO DELLE PROPOSTE CULTURALI CONFERENZE - PRESENTAZIONI 2 marzo Artisti/collezionisti tra Cinquecento e Settecento 9 marzo Le donne nell’architettura tra XX e XXI secolo 16 marzo Dante fra arte e poesia 23 marzo La rivincita delle artiste nella pittura del ‘600 - parte II 30 marzo Il “mio”Arturo 6 aprile Arte al tempo di Dante: “Ora ha Giotto il grido!” 20 aprile La lettera di Raffaello a Leone X: nasce la moderna concezione di conservazione dei beni culturali PALAZZI, MUSEI E SITI ARTISTICO/ARCHITETTONICI 11 marzo Il Cimitero Monumentale VISITE A CHIESE 4 marzo Santa Maria Beltrade: Deco’, ma non si direbbe 15 marzo San Marco 24 marzo Chiesa e museo di San Fedele 26 aprile San Francesco al Fopponino VISITE A MOSTRE 10 marzo “Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa” alle Gallerie d’Italia 31 marzo Carla Accardi, una donna come tante, al Museo del ‘900 7 aprile Robot al Mudec: scienza, tecnica, arte, antropologia 14 aprile “Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa” alle Gallerie d’Italia 16 aprile Le Signore del Barocco a Palazzo Reale in copertina: Domenico di Michelino, affresco, 1465, cattedrale di Santa Maria del Fiore - Firenze 2 ITINERARI D’ARTE 18 marzo Dal teatro Dal Verme alla chiesa di Santa Maria alla Porta 22 marzo Una passeggiata lungo le mura spagnole 29 marzo I segreti della Via Moscova e dintorni 12 aprile Nuovi Arrivi tra Piazza Liberty/Piazza Cordusio/via Brisa: la città che cambia 13 aprile Dal Carrobbio alla Darsena, le porte “Ticinesi” e la Milano nei secoli 22 aprile Da piazza della Scala a piazza Belgioioso 27 aprile La lunga storia del Portello ed il nuovo parco Programma elaborato dal team degli Storici dell’Associazione, coordinati dal dott. -
Welcome to Milan
WELCOME TO MILAN WHAT MILAN IS ALL ABOUT MEGLIOMILANO MEGLIOMILANO The brochure WELCOME TO MILAN marks the attention paid to those who come to Milan either for business or for study. A fi rst welcome approach which helps to improve the image of the city perceived from outside and to describe the city in all its various aspects. The brochure takes the visitor to the historical, cultural and artistic heritage of the city and indicates the services and opportunities off ered in a vivid and dynamic context as is the case of Milan. MeglioMilano, which is deeply involved in the “hosting fi eld” as from its birth in 1987, off ers this brochure to the city and its visitors thanks to the attention and the contribution of important Institutions at a local level, but not only: Edison SpA, Expo CTS and Politecnico of Milan. The cooperation between the public and private sectors underlines the fact that the city is ever more aiming at off ering better and useable services in order to improve the quality of life in the city for its inhabitants and visitors. Wishing that WELCOME TO MILAN may be a good travel companion during your stay in Milan, I thank all the readers. Marco Bono Chairman This brochure has been prepared by MeglioMilano, a non-profi t- making association set up by Automobile Club Milan, Chamber of Commerce and the Union of Commerce, along with the Universities Bocconi, Cattolica, Politecnico, Statale, the scope being to improve the quality of life in the city. Milan Bicocca University, IULM University and companies of diff erent sectors have subsequently joined. -

Milano-100-Lieux-A-Visiter.Pdf
Comune di Milano Touring Club Italiano Settore Politiche del Turismo Corso Italia, 10 e Marketing territoriale 20122 Milano via Dogana, 2 Direzione Centro Studi 20121 Milano Maria-Chiara Minciaroni Direttore Matteo Montebelli Massimiliano Taveggia Massimiliano Vavassori Jacopo Zurlo Servizio Sviluppo e Monitoraggio del Turismo Sergio Daneluzzi Servizio Digital e Web Marketing Patrizia Bertocchi www.turismo.milano.it Milan Progetto grafico Crediti fotografici Alessandro Gandini, Milka Gandini Arcidiocesi di Milano; Mauro Colella; Gandini&Rendina grafica e pubblicità srl Comune di Milano (Galleria d’Arte Moderna, Biblioteca Comunale Centrale “Palazzo Impaginazione e digitalizzazione Sormani”); R. Longoni; Giorgio Majno; Gandini&Rendina grafica e pubblicità srl Franco Mascolo; Museo Poldi Pezzoli; Icone e mappe Navigli Lombardi s.c.a.r.l.; Andrea Scuratti; Gandini&Rendina grafica e pubblicità srl Václav Šedý; Veneranda Biblioteca Ambrosiana; VRWAY Communication - Giuseppe Pennisi Copertina Comune di Milano LIEUX A VISITER 100 LIEUX A VISITER THEMES Bibliothèques Parcs et jardins Monuments historiques Places Edifices religieux Portes Installations sportives Points de vue panoramiques Monuments de l’Antiquité Espaces d’expositions Musées Théâtres et auditoriums Canaux Villas Palais Sites remarquables signalés par le Touring Club Italiano www.touringclub.it 100 LIEUX A VISITER THEMES Bibliothèques Edifices religieux Palazzo dell’Ambrosiana - Biblioteca e Pinacoteca Duomo di Milano Ca’ Granda Università degli Studi di Milano Chiesa di Santa Maria Annunciata in Camposanto Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento (Palazzo della Veneranda Fabbrica) Castello Sforzesco Chiesa di Sant’Alessandro (Piazza Sant’Alessandro) Palazzo dell’Arte Chiesa di Santa Maria presso San Satiro Museo Civico di Storia Naturale Chiesa di Santa Maria dei Miracoli Conservatorio di Musica “G. -

1536242718 Palazzo Cordusio Brochure FINAL.Pdf
1 the history of business 2 STORIA HISTORY una piazza in cui 1901 PALAZZO DELLA BORSA si è scritta la storia Inaugurazione del nuovo “Palazzo della Borsa” di Milano ad opera a square where history dell’Architetto Luigi Broggi. STOCK MARKET PALACE has been made Inauguration of the new “Stock Market Palace” in Milan, a work by the architect Luigi Broggi. 1936 PALAZZO DELLE POSTE Progettato nel 1901, viene riconosciuto nel 1962 come immobile Vendita del Palazzo al “Ministero di interesse storico. Il Palazzo, concepito dall’architetto delle Comunicazioni-Amministrazione Luigi Broggi, nasce come sede della Borsa nella piazza ellittica delle Poste e Telegrafi”. di “Cordusio”, già crocevia della fervente vita milanese di fine ottocento, e viene subito apprezzato per il suo imponente stile POST OFFICE PALACE Sale of the Palace to the Ministry architettonico, teso a rappresentare l’importanza economica of Communications and Administration e commerciale della città. Nel 1936 l’edificio viene venduto of the Post Office and Telegraph dalla “Società Anonima della Borsa in Milano” al Ministero Services delle Comunicazioni-Amministrazione delle Poste e Telegrafi, trasformandosi internamente e cambiando destinazione nel 1998 per divenire sede di “Poste Italiane SPA”. Nel periodo 2015 - 2018 l’intero stabile viene restaurato nelle facciate e completamente rinnovato al suo interno. 2018 Designed in 1901 and acknowledged in 1962 as a historic landmark, PALAZZO CORDUSIO the Palace, conceived by the architect Luigi Broggi, hosted the Stock Exchange Inaugurazione del nuovo “Palazzo in the oval “Cordusio” Square, already a crossroads in the dynamic Milanese Cordusio”, nato dal restauro delle life of the late 19th century. -

Uncorrected Proof
Chapter 12 Luxury as a Driver for New Urban Identities in Milan: Geographies, Spatial Author Proof Practices, and Open Questions Mario Paris 1 Abstract In contemporary cities, the role of capital and private investors who finance AQ1 2 interventions in the field of urban regeneration has become an increasingly important 3 catalyst for the physical and social impacts of these transformations. This paper aims 4 to point out the role of urban projects developed by luxury companies or stakehold- 5 ers in consolidated urban regions. Starting by analysing the spatial distribution of 6 luxury firms in Milan and composing a tentative classification system based on a 7 variety of case studies, the author proposes a mental map of spaces shaped, occu- 8 pied, transformed and infected by the sector within the contemporary metropolis. 9 The resulting network of urban places sprawls out not only across centralized areas, 10 but also in peripheral neighbourhoods, which interact with existing contexts, spatial 11 and economic relationships as well as evident and hidden flows. From this basis, the 12 contribution reflects on a set of luxury-driven practices and their impacts on urban 13 identities. The reflection includes the role played by media technologies in these 14 transformations and in the study of their development. The conclusions then discuss 15 the role of luxury; whether it transforms the physical form of our city (its shape and 16 patterns) or rather influences processes of transformation. 17 Keywords Luxury · Identity · Global · Local · Urban 18 12.1 Introduction 19 As Amirtahmasebi et al. point out in their recent publication (2016; xxvii), ‘every AQ2 20 city has pockets of underused and underutilized land or distressed and decaying 21 urban areas. -

Hostelworld Guide for Milan the Essentials Climate
Hostelworld Guide for Milan The Essentials Climate Getting There As it is one of Italy's most northerly cities, Milan experiences cooler temperatures than most of its counterparts. Winters frequently experience By plane: Milan is served by three airports - Linate, temperatures of 0°C and sometimes even lower. Malpensa and Orio al Serio. Some budget airlines Temperatures begin to climb in mid-April and by use Orio al Serio and Malpensa, while Linate is summer Milan experiences countless trademark hot nearest to central Milan. All are connected to the days Italy is so synonymous with. September is city centre via bus. extremely mild before things start to cool down again in October. By train: Milan's Stazione Centrale has rail links with all of Europe's major cities. It is a very imressive building and not far from the historical centre. By bus: Buses arriving from and going to major European cities do so from the bus station at Piazza Sigmund Freud. Getting Around On foot: Milan's historical centre is easily explored on foot, but to get from Stazione Centrale to Il Duomo you may want to utilise the metro. By metro: Milan's metro network consists of three Useful Information Slick, sleek and uber-cool, Milan is one of the most stylish cities in the world. Lavish designer stores lines - M1 (red), M2 (green) and M3 (yellow). It is abound endless streets while just as lavish bags loaded with the latest 'must-have' items hang from easy to use and efficient. Single journeys cost €1 Language: Italian endless shoppers' arms. -

Tour 3 Rund Um Das Castello Sforzesco
52 Vom Dom zum Castello Sforzesco Eine Burg für Kunstliebhaber Tour 3 Rund um das Die Tour führt vom Domplatz über Castello die Via Dante, eine der schönsten Straßen der Stadt, zum Castello Sforzesco Sforzesco mit zahlreichen interes- santen Museen. Eingebettet in Ein Spaziergang vom Dom zum Castel- Tour den Schlosspark sind u. a. das De- lo Sforzesco gehört zu den Highlights Rund signmuseum Triennale, Aquarium, eines Mailand-Besuches. Auf der nob- um d Arena und ein Aussichtsturm – len Fußgängerzone Via Dante mit schi- Caste man könnte Tage hier verbringen. cken Läden und mehreren großen Stra- Sforz ßencafés flanieren Sie schnurgerade o auf die gigantische zinnenbekrönte Festung zu, die sich mitten in der Stadt erhebt. Obwohl es hier vor Touristen aus aller Welt und teils aufdringlichen Straßenhändlern (einfach stur weiter- gehen!) wimmelt, sollten Sie sich unbe- dingt Zeit für einen Rundgang durch das Castello Sforzesco nehmen, das an- geblich als Vorbild für den Bau des Moskauer Kremls diente. Einen Besuch wert sind die zahlreichen teils unge- wöhnlichen Museen, die sich hinter den wuchtigen Mauern verbergen. Zu den Schätzen zählen Michelangelos letzte, unvollendet gebliebene Skulp- tur, Pietà Rondanini (1564), der seit 2015 ein eigenes Museum gewidmet ist, die von Leonardo da Vinci erschaf- fenen Deckenfresken in der Sala delle Asse, dem wohl schönsten Saal im Schloss, und das gotische Grabmonu- ment von Bonino da Campione für Ber- nabò Visconti (um 1363) im Museo d’Arte Antica. Piazzaza d deeiMerci Mercantnti, Mailands mit- telalterliches Herz, S. 59 Durch die Burg hindurch betritt man Spaz den Parco Sempione, mit 40 ha der ga Piccccolo TeatTeatro,ro, erstes Stadttheater größte Park der Stadt. -
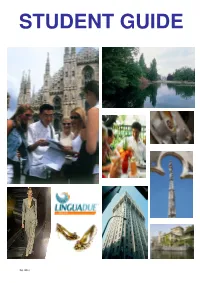
Student Guide
STUDENT GUIDE Ed. 2013 FOR LEISURE AND CULTURE ACTIVITIES IN MILAN WE COOPERATE WITH: 10% discount for LINGUADUE students – BOOK NOW !!! Zani Viaggi – Foro Bonaparte 76 (MM1 Cairoli-Castello) Tel: +39 02 867131 – www.zaniviaggi.it Libreria Internazionale Via Ozanam, 11 (MM 1 Lima) - 20129 Milano Tel: (+39) 02 2049022 – www.il-libro.it Ed. 2013 MILANO Corso Buenos Aires 43 I-20124 Tel (+39) 02-29519972 Fax (+39) 02-29519973 E-mail: [email protected] Web: www.linguaviva.it FIRENZE LIGNANO – School for Juniors Via Fiume 17 I-50123 Viale Centrale 29 I-33054 Tel. (+39) 055-280016 Tel. (+39) 0431 73481 Fax (+39) 055-283667 Fax (+39) 0431 721566 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Web: www.linguaviva.it Web: www.linguaviva.it SUMMARY Linguadue Staff & Services 1 First Day at Linguadue, Placement Test, Levels 2 Linguadue Courses 3 Useful Advise, Certificates, Exams & Textbooks 4 Arrival feedback, End of course evaluation 4 What to do if you are unhappy 5 Secretary & Accommodation office 5 How to contact you 6 Social Activities, Student Card, Internet 6 Before leaving Italy – Study Visa & Airport transfer 7 After your arrival in Milan – Permit of Stay 7 Fiscal Code, Bank Account, Health insurance, Security 7 Information about Milan – Trains, Airports 8 Getting around Milan 8 Phone, Tourist Offices, Tickets, Shops, Supermarkets 9 Banks, Post Offices, Mobile phones 9 Useful Numbers, Emergencies 10 Libraries, Bookshops, Newspapers 11 Nightclubbing & Restaurants, Sports in Milan 12 Ed. 2013 BENVENUTI A LINGUADUE ! LINGUADUE STAFF {/Ihh[ a!b!D9a9bÇ D . [ / [ / t ! Ç9!/I9w{ / . ! . ! w . t a t b D w a { t ë t 1 Ed. -

Heart of the City Let’S Start from the Castello Sforzesco and All the Famous Attractions in Milan
MILAN CITY GUIDE ® FEBRUARY 2021 WWW.WHEREMILAN.COM DISCOVER & ENJOY THE heart of the city Let’s start from the Castello Sforzesco and all the famous attractions in Milan 米兰旅行免费指南 扫码使用体验 米兰小程序 SIGHTSEEING | MUSEUMS | SHOPPING | DINING | ENTERTAINMENT | MAPS DISCOVER MORE DISCOVER DISCOVER MORE Milan February 2021 Dear friends and readers, the tourism sector is Where tips in great difficulties all over the world. We must therefore thank 20 SHOPPING you who are reading Fashion & Design us now because you In love Pineider historic are nonetheless the hope of recovery as the brand has recently world slowly overcomes opened its flagship the pandemic. store in the central We Italians have via Manzoni. experienced all manner with of crises and we have 32 TASTING always overcome Food & Wine them by trying not Discover the Mi View to lose that smile of Restaurant in the welcome that we once Portello district, ENJOY again give you today. ISSABLE Italy?NM IT offering a breathtaking A U L Whether you are our E I H A T N view and a refined guest due to work, to E X P E cuisine. pleasure or, simply, you Discover R I E N have come upon these C & Enjoy E words via the Internet, S 40 LEISURE the word is always Entertainment & Tours “benvenuto, welcome”, Where® invites you to a either today or in a few Live your dream and get your experience in a click tour discovering the months. beauties of Lake Como Andrea Jarach in an electric car. Where® Publisher 42 ITINERARIES www.welcometoitalia.com Landmarks & Museums MILAN CITY GUIDE ® Leonardo da Vinci’s Last Supper has FEBRUARY 2021 WWW.WHEREMILAN.COM become “for everyone” DISCOVER & ENJOY THE heart of the city thanks to new Let’s start from the Castello Sforzesco and all the famous attractions in Milan Contents multimedia supports. -

Press Release the Gallerie Di Piazza Scala of Intesa Sanpaolo Host the Photography Exhibition “Italian Style”. Luca Beltrami
PRESS RELEASE THE GALLERIE DI PIAZZA SCALA OF INTESA SANPAOLO HOST THE PHOTOGRAPHY EXHIBITION “ITALIAN STYLE”. LUCA BELTRAMI FOR BANCA COMMERCIALE ITALIANA. HISTORIC PHOTOGRAPHIC JOURNEY THROUGH A “CITY SET TO BECOME A METROPOLIS” Open to the public on free admission from 16 January to 13 April at the Gallerie d’Italia. A photographic journey in the transformation of Piazza Scala, unwinding through historic evidence and the interpretation of a work of architecture. Milan, 16 January 2014 − “Italian style”. Luca Beltrami for Banca Commerciale Italiana. Historic photographic journey through a “city set to become a metropolis” is the title of the photography exhibition running from 16 January to 13 April 2014 at the Gallerie di Piazza Scala of Intesa Sanpaolo. The show will enable the public to view for the first time photographs of the premises of what was then Banca Commerciale Italiana, conserved and catalogued at the Historical Archive of Intesa Sanpaolo. The display itinerary unfurls around shots by prestigious photographers who, over the course of time, have explored the work of Luca Beltrami (1854-1933), the architect who was assigned the task of planning the new premises of one of the most dynamic of the city’s emerging economic institutions. This is largely unpublished photographic documentation, enhanced by the design drawings that demonstrate Beltrami’s attention to even the tiniest details. Thus we discover the innovative use of metal in the balustrades and the lamps, as well as the architect’s constant focus on creating furnishings and objects functional to the business activity, introducing solutions that were at once new and attuned to the aesthetic demands. -

Foro Buonaparte International Design Competition Piazza Castello
InternationalConcorso Internazionale Design Competition di Progettazione Pi PiazzaCastello Castello - Foro Buonaparte- Foro Buonaparte PRELIMINARY DESIGN DOCUMENT InternationalConcorso Internazionale Design Competition di Progettazione Pi PiazzaCastello Castello - Foro Buonaparte- Foro Buonaparte PRELIMINARY DESIGN DOCUMENT Organizing Body and the technical contribution of Mayor Giuliano Pisapia Riccardo Gusti, Agricultural Engineer and Dr. Salvatore Sindoni City Department of Urban Planning, Private Building and Agriculture Dr. Roberto Munarin City Councilor Alessandro Balducci Dr. Francesco Amato Innovation and Economic and Social Development Area City Department of Public Works and Urban Furnishings – Central Division for Industry and Local Marketing – City Councilor Maria Carmela Rozza Business Sector, Help Desk for Business and Industry City Department of Traffic, Environment, Subways, Public Arch. Paolo Savio Water, Energy Ministry for Cultural Heritage and the Arts - City Councilor Pierfrancesco Maran Superintendence for Architecture and Landscape, Milan City Department of Health, Quality of Life, Sports and Engineer Annapaola De Lotto Leisure, Human Resources, Animal Protection, Parks, Territory Area – Central Division of Development of the General Services Territory – General Urban Planning Sector City Councilor Chiara Bisconti and the technical contribution of Giorgio Solimene, Surveyor City Department of Trade, Industry, Tourism, Local Marketing, Civic Services City Councilor Franco D’Alfonso Administrative Assistant Mr. Angelo