Selezione Dal Volume Alberto Beneduce (1877‐1944)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bollettino Nuove Accessioni 1
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Biblioteca Novità in Biblioteca BOLLETTINO NUOVE ACCESSIONI 1 _________________ Marzo 2012 SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Biblioteca Novità in Biblioteca BOLLETTINO NUOVE ACCESSIONI -1- _________________ Marzo 2012 A cura di: Rosetta Santomassimo e Alessia Maiuri Biblioteca Quirinale II Biblioteca Quirinale INDICE PER MATERIA DIRITTO ...................................................................................................................................... 1 QUIRINALE .............................................................................................................................. 9 LEGISLAZIONE .................................................................................................................... 11 REPERTORI ............................................................................................................................. 13 POLITICA / SAGGISTICA ................................................................................................... 15 ECONOMIA ............................................................................................................................. 21 STORIA ...................................................................................................................................... 23 SCRITTI, MEMORIE, BIOGRAFIE ..................................................................................... 33 ARTE ........................................................................................................................................ -

Kazdan Pak Dissertation
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title Italy's Primary Teachers: The Feminization of the Italian Teaching Profession, 1859-1911 Permalink https://escholarship.org/uc/item/7fh45860 Author Pak, Julie Kazdan Publication Date 2012 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Italy’s Primary Teachers: The Feminization of the Italian Teaching Profession, 1859-1911 A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Julie Kazdan Pak 2012 © Copyright by Julie Kazdan Pak 2012 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Italy’s Primary Teachers: The Feminization of the Italian Teaching Profession, 1859-1911 by Julie Kazdan Pak Doctor of Philosophy in History University of California, Los Angeles, 2012 Professor Geoffrey Symcox, Chair This dissertation concerns the feminization of the Italian teaching profession between the introduction of pre-Unification schooling in 1859 and the nationalization of that system in 1911. By feminization, this dissertation refers both to the gradual assumption of the majority of elementary teaching positions by women and to a transformation in the nature of the position itself. Through an examination of educational periodicals, school records, government inquests, and accounts by teachers and pedagogical theorists, it argues that rather than the unintended consequence of economic constraints or shifting labor patterns, feminization was fundamentally connected to larger processes of centralization and modernization in the Italian school system. Following an introductory chapter outlining the major national, religious, and gender debates of ii the Unification era, the second chapter of the dissertation argues that the figure of the female elementary teacher became embroiled in the contest between local and national interests, furthering the drive toward centralization. -
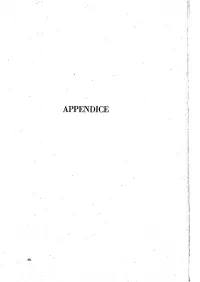
APPENDICE I - ' ' ' -Il
vi APPENDICE I - ' ' ' -il PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ENRICO DE NICOLA, Capo prov visorio dello Stato dal 28 giugno 1946 al 24 giugno 1947 dal 25 giugno al 31 dicembre 1947 ENRICO DE NICOLA, Presidente della Repubblica ; dal 1° gennaio 1948 all'11 maggio 1948 LUIGI EINAUDI, Presidente della Repubblica dall'll maggio 1948 >"..". r ?.-.' V-r^v;*-"^"^ - •«• « ***•••>*• , . :ir.'-.•.:••.• L T • ~ i : ~ . ..' -» "• »-1 -?. ' *- / >^1 • - A •; li ENRICO DE NICOLA 82. • ' ? LUIGI EINAUDI PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIOVANNI GRONCHI. dall'8 maggio 1948 PRESIDÈNTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IVANOE BONOMI dall'8 maggio 1948 GIOVANNI GRONCHI -J-Ì IVANOE BONOMI PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DALLA I ALLA XXVI LEGISLATURA VINCENZO GIOBERTI dall'8 maggio al 20 luglio 1848 e dal 16 ott. 30 die. 1848 IL . LORENZO PARETO dal 1° febbr. al 30 marzo 1849 III. LORENZO PARETO dal 30 luglio al 20* nov. 1849 IV . PIER DIONIGI PINELLI dal 20 die. 1849 al 25 aprile 1852 UHBANO RATTAZZI dall'll maggio 1852 al 27 ott. 1853 CARLO BON-COMPAGNI dal 16 al 21 nov. 1853 V ... CARLO BON-COMPAGNI. dal 19 die. 1853 al 16 giugno 1856 CARLO CADORNA.. dal 7 genn. al 16 luglio 1857 VI .. CARLO CADORNA. dal 14 die. 1857 al 14 luglio 1858 URBANO RATTAZZI. dal 10 genn. 1859 al 21 genn. 1860 VII . GIOVANNI LANZA dal 2 aprile al 28 die. 1860 VIII URBANO RATTAZZI. dal 18 febbr. 1861 al 2 marzo 1862 SEBASTIANO TECCHIO dal 22 marzo 1862 al 21 magg. 1863 GIOVANNI BATTISTA CASSINIS dal 25 maggio 1863 al 7 sett. 1865 IX. -

La Nascita Dello Stato Unitario € 12,00 FC11600 La Nascita Dello Stato Unitario Libri, Periodici E Stampe Della Biblioteca Della Camera Dei Deputati
La nascita deLLo stato unitario Libri, periodici e stampe della Biblioteca della Camera dei deputati L a nascita de LL o s tato U nitario Catalogo della mostra Biblioteca della Camera dei deputati 7 giugno - 4 luglio 2011 € 12,00 FC11600 La nascita deLLo stato unitario Libri, periodici e stampe della Biblioteca della Camera dei deputati Catalogo della mostra Biblioteca della Camera dei deputati 7 giugno - 4 luglio 2011 La nascita dello stato unitario Hanno collaborato i seguenti Servizi e Uffici della Libri, periodici e stampe Camera: della Biblioteca della Camera dei deputati Archivio storico Servizio amministrazione Servizio per la gestione amministrativa Servizio per la sicurezza Ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico Ufficio stampa Catalogo della mostra Biblioteca della Camera dei deputati Palazzo del Seminario 7 giugno - 4 luglio 2011 Ricerca iconografica, testi, progetto grafico e segreteria organizzativa: Biblioteca della Camera dei deputati tel. 06.6760/3476 – 06.6760/3805 mail: [email protected] Fotocomposizione e stampa: Copyright©Camera dei deputati Centro riproduzione e stampa della Camera dei Segreteria generale – Ufficio pubblicazioni deputati e relazioni con il pubblico Roma, giugno 2011 Indice Presentazione, Gianfranco Fini Presidente della Camera dei deputati 7 Istituzioni e legislazione degli Stati preunitari 27 L’unificazione legislativa. I primi codici del Regno d’Italia 51 L’unificazione economica 75 L’unificazione amministrativa ed il problema delle autonomie locali (1860-1865) 97 Il nuovo Stato, i cattolici e l’unità d’Italia 119 La società civile e la questione meridionale 143 Il brigantaggio Presentazione Il 17 marzo 1861, data di promulgazione della legge istitutiva del Regno d’Italia, ha segnato l’avvio di un processo pluridecennale di costruzione di una realtà giuridica ed amministrativa nuova, che si sovrappose a quelle ereditate dagli Stati preunitari e che costituì a lungo l’ossatura dello Stato nazionale. -

Forme E Metamorfosi Della Rappresentanza Politica.Pdf
po Fo rme a cu di Scritti di Manuela Albertone, Sabi- litica Forme e ra Nei percorsi del mondo moderno e no Cassese, Michel Troper, Anto- metamorfosi Pietro Adamo contemporaneo le discussioni sulla e me nio Chiavistelli, F. Bonini, Jan-Pieter 1848 1968 della rappresentanza Antonio Chiavistelli rappresentanza, sui suoi vantaggi e sui Forßmann, Fulvio Cammarano, Sil- politica Paolo Soddu suoi limiti, sono divenuti punti focali via Cavicchioli, Mauro Forno, Fran- tamorfosi 1848 1948 1968 nello sviluppo dei sistemi democrati- cesco Campobello, Samuel Hayat, ci. In questo volume si ricostruiscono i Paolo Soddu, Fiammetta Balestrac- contesti sociali, politici e culturali di tre ci, Guido Franzinetti, Giuseppe Filip- fasi storiche particolarmente emblema- petta, Fabrizio Loreto, Emma Mana, de tiche in tale itinerario: il 1848, epoca di Pietro Adamo, Kristina Schulz, Paolo lla discussioni sulla rappresentanza, che Cozzo, Isabelle Sommier, Michele modellano ipotesi di nuove statualità; ra Battini, Marco Scavino, Andrea Sac- ppresentanza il 1948, quando nei paesi europei e in coman. Italia si ricercano nuove soluzioni istitu- zionali che fanno balzare in primo pia- no le differenze tra le culture politiche; il 1968, nel momento in cui contesta- zione e controcultura mettono radical- mente in discussione rappresentanza, democrazia e la politica stessa. aA aAaAaAaAaAaAaAaA aA ccademia aA university Accademia University Press press P. Ad P. a cu ra amo, di A. Ch ISBN: 978-88-31978-842 iavistelli, P. So P. € 24,00 9 7 8 8 8 3 1 9 7 8 8 4 2 ddu rappresentanza_politica_copertina.indd -

Informazioni Essenziali Da Indicare Sul Frontespizio Della Tesi
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE “CESARE BECCARIA” CURRICULUM DI DIRITTO CANONICO ED ECCLESIASTICO XXVII CICLO IL DIBATTITO SULLA NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO CANONICO E LE ORIGINI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO (1865-1895) S. S. D. IUS/11 Candidato Dott. Alessandro Tira Relatore Chiar.mo prof. Silvio Ferrari Coordinatore Chiar.mo prof. Silvio Ferrari A.A. 2013-2014 0 SOMMARIO INTRODUZIONE 3 1. Presupposti dell’indagine 3 2. Struttura del lavoro 9 3. Questioni circa le caratteristiche e i criteri di selezione del materiale di indagine 12 4. Nota bibliografica generale 15 CAPITOLO PRIMO LA CORNICE NORMATIVA DEL DIBATTITO 22 1. Considerazioni introduttive 22 2. Dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia 29 3. I provvedimenti legislativi dei Governi della Destra storica 39 4. Dalla legge sulle guarentigie alla caduta della Destra 46 5. Continuità e discontinuità nell’azione dei Governi della Sinistra storica 52 6. Fin de siècle: la politica ecclesiastica di Francesco Crispi 54 CAPITOLO SECONDO LA QUESTIONE ECCLESIASTICA DALLA POLITICA AL DIRITTO 57 1. Osservazioni introduttive attorno ad un concetto sfuggente: libera Chiesa in libero Stato 57 2. Il pensiero di Ruggiero Bonghi e la legge delle Guarentigie 64 3. Dalla formula di Cavour al dibattito sulla piena separazione giuridica: il ruolo di Marco Minghetti 87 4. Reazioni all’opera di Minghetti 106 5. Dalla Destra storica al conservatorismo nazionale: il giurisdizionalismo moderato di Giuseppe Piola 124 CAPITOLO TERZO DAL «DIRITTO COMUNE» AL DIRITTO ECCLESIASTICO 138 1. Introduzione 138 2. Pasquale Stanislao Mancini e il canone del giurisdizionalismo postunitario 141 3. Augusto Pierantoni: la Chiesa e il diritto internazionale nell’età degli Stati – nazione 156 4. -

SCUOLA DOTTORALE SEZIONE GOVERNO E ISTITUZIONI FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO XXIV CICLO Il Consigli
SCUOLA DOTTORALE SEZIONE GOVERNO E ISTITUZIONI FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO XXIV CICLO Titolo della tesi Il Consiglio di Stato durante la fase Costituente Nome e Cognome del dottorando Corrado Cavallo Docente Tutor: Prof. Paolo Alvazzi del Frate 1 Il Consiglio di Stato durante la fase Costituente 2 IL CONSIGLIO DI STATO DURANTE LA FASE COSTITUENTE INDICE Premessa introduttiva Pag. 5 I) Il Consiglio di Stato 8 1.1. Premessa 8 1.2. Le origini 12 1.3. Il consolidamento del Consiglio di Stato 19 1.4. Le leggi del 1865 25 1.5. La creazione della IV Sezione 30 1.6. Il Consiglio di Stato e il periodo liberale 36 1.7. Il Consiglio di Stato e il fascismo 45 II) Il Consiglio di Stato alla fine della seconda guerra mondiale 61 2.1 Premessa 61 2.2 Il Consiglio di Stato a Cremona 64 2.3 Le sentenze 66 2.4 L’organizzazione 72 2.5 I magistrati coinvolti 77 2.6 Il Consiglio di Stato alla fine del 1945 82 2.7 La figura di Meuccio Ruini 87 2.8 L’insediamento di Ruini in qualità di Presidente del Consiglio di Stato 101 2.9 Il Consiglio di Stato e l’epurazione 105 3 Pag. III) Il Consiglio di Stato nella fase Costituente 117 3.1. La Commissione per la riorganizzazione dello Stato 117 3.2. I verbali della Commissione Forti 126 3.3. La relazione della Commissione Forti all’Assemblea Costituente 139 3.4. La Commissione per la Costituzione e Ruini 145 3.5. -

Lo Spunto Per La Nota Di Fondo Ci Viene Offer
SOMMARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o Per chiarezza pag o spunto per la nota di fondo ci viene offer- del resto, tanti Soci che ci scrivono; lo attestano lusin- to, questa volta, da alcune osservazioni avan- ghieri giudizi di eminenti personalità del mondo o Carlo Azeglio Ciampi Presidente della zate da un Presidente di Sezione. delle Istituzioni, del Giornalismo, della Cultura e Repubblica L La prima batte sul ritardato recapito di "Fiamme perfino di privati. Un fatto, in ogni caso, è certo e ci o La Festa della Polizia di Stato nelle altre città d'Oro". A tal proposito, ripetuto che quanto accade è si consenta di dirlo senza falsa modestia: ferma indipendente dalla nostra volontà, rimandiamo il restando l'ovvia perfettibilità di ogni cosa, oggi o II Reparto Speciale Aviotrasportato della nostro corrispondente - e coloro che gli fossero soli- "Fiamme d'Oro" non è seconda a nessuna delle simi- Polizia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdi Viscardo Castelli dali nella rimostranza - alla precisazione che appare lari riviste. a pag. 11 del N. 5/ 6. In merito ad una terza osservazione, rispondiamo o Le donne nell'Esercito, di Antonia M arzario Organo d'Informazione mensile dell'ANPS La seconda sottolinea un certo disappunto dei let- che non è "illogico" né tampoco "dispersivo" il rice- o Convegno Associazione Arma di Cavalleria, tori di fronte a notizie sezionali pubblicate con mesi vere nell'ambito della stessa famiglia - ove i Soci eANPS di ritardo rispetto all'uscita del numero che le ospita; siano più d'uno — più copie dello stesso numero. Direttore Responsabile zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA il che - si afferma - contrasterebbe con il "decanta- Non saranno quei pochi fascicoli apparentemente Umberto E. -

Archivio Jacini
Archivio di Stato di Cremona Archivio Jacini Titolo I Famiglia Jacini Revisione 2019 a cura di Silvia Rigato con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale anno 2017-2018 II L’archivio Jacini è stato depositato in Archivio di Stato nel 2016. Si presentava sostanzialmente già ordinato e corredato da inventari manoscritti redatti a metà Novecento da Francesco Forte, archivista presso l’Archivio di Stato Milano, su incarico di Stefano Jacini. Le carte sono state suddivise da Forte in cinque titoli: Famiglia, Fondi e case, Amministrazione, Ditta Jacini, Miscellanea. In questa sede si propone la trascrizione del primo titolo, diviso a sua volta in gruppi, ciascuno dei quali corrispondente a un membro della famiglia. Nel lavoro di trascrizione e revisione degli inventari, si è cercato il più possibile di rispettare l’ordinamento di Francesco Forte, salvo che per i gruppi 28 e 33, in cui erano state aggiunte a posteriori delle buste in coda a quelle già riordinate ed erano stati scambiati o modificati (aggiunti o sottratti) i contenuti di numerosi fascicoli. In questi casi si è optato per il riordino complessivo del gruppo: rimandiamo pertanto alle note introduttive di queste sezioni per i dettagli. Ove possibile, inoltre, è stata riunita in un unico fascicolo la corrispondenza di uno stesso mittente al fine di alleggerire la descrizione che, pur essendo ancora molto analitica, è ora meno ripetitiva. A fronte dei cambiamenti apportati, il presente inventario riporta sia la nuova fascicolazione, sia le precedenti segnature assegnate da Francesco Forte; in tal modo rimane la possibilità di operare un riscontro con gli inventari manoscritti e al contempo non si perde traccia della loro posizione originaria. -

Guida Dei Fondi Archivistici
CIVICHE RACCOLTE STORICHE DI MILANO GUIDA DEI FONDI ARCHIVISTICI SAVERIO ALMINI 2017 Sindaco Area Soprintendenza Castello, Musei Giuseppe Sala Archeologici e Musei Storici Direzione Musei Storici Assessore alla Cultura Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento Filippo Del Corno Responsabile Uffi cio Amministrativo, Direttore Cultura Organizzazione Eventi e Comunicazione Giulia Amato Simonetta Andolfo Uffi cio Stampa Conservatore Elena Conenna Ilaria De Palma Direttore Area Soprintendenza Castello, Disegni e Stampe Musei Archeologici e Musei Storici Patrizia Foglia Claudio A.M. Salsi Biblioteca e Archivio Paola Mazza Fabrizio Raffa Pasquale Arrigo Francesco Basile Alessio Foresta Uffi cio Amministrativo e Organizzazione Eventi Valeria Giannelli Rita Menghini Andrea Manti Claudio Terni Visite e percorsi didattici a cura della Sezione Didattica Raccolte Storiche Direzione Educazione e Istruzione Laura Bagarella Stefania Bolzoni Elisa Fontana Vera Magnani Thea Rossi Angela Sironi L’archivio delle Civiche Raccolte Storiche di Milano è sempre stato frequentato principal- mente da studiosi, da cultori di storia e da studenti universitari. Negli ultimi anni, tuttavia, è in continuo aumento il numero di utenti italiani e stranieri che contattano l’Istituto tra- mite la posta elettronica per avere informazioni di ogni tipo, generali o circostanziate. Non mancano nemmeno coloro che, pur non avendo particolare dimestichezza con le diffi coltà che di norma comporta una ricerca d’archivio, si presentano in sala di consultazione con- vinti di poter ottenere in tempi brevi risposte esaurienti alle loro aspettative. Questo stato di cose ha fatto nascere l’esigenza di realizzare uno strumento aggiornato che, attraverso diversi livelli di lettura, potesse prestarsi a orientare sia un pubblico così diversifi cato, sia il personale interno nel suo lavoro di supporto e consulenza. -

Relazione Di Attivita' 2004
RELAZIONE DI ATTIVITA’ 2004 PREMESSA L’anno trascorso ha visto volgere alla conclusione la maggior parte delle iniziative progettate e preannunciate nell’anno precedente. Il complesso progetto dedicato alla storia sociale delle donne in Piemonte, esamina- ta sotto il profilo delle donne imprenditrici, delle professioniste e di quelle impegnate politicamente all’interno dei partiti è ormai al termine e ha già editato, nella collana dell’Istituto presso le edizioni Franco Angeli, l’importante volume consacrato a Donne e politica. La presenza femminile nei partiti politici dell’Italia repubblicana, Torino 1945-2000, a cura di Maria Teresa Silvestrini, Caterina Simiand, Simona Urso. Tra pochi mesi usciranno anche i volumi dedicati agli altri due segmenti della ricerca, che si distinguono per l’originalità dell’individuazione e dell’approccio all’oggetto di una ricerca che si è arricchita di documentazioni particolarmente significative. Anche i settori riservati agli studi internazionali sono ormai prossimi a pubblicare i lo- ro risultati, dai testi che esaminano la storia e la cultura polacca del Novecento a quello consacrato alle avanguardie artistiche in Polonia e in particolare al costruttivi- smo fra le due guerre mondiali. Entro l’anno vedrà la luce il testo che raccoglie le ricerche di ispanistica e così pure la raccolta di saggi politico-sociali sulla Germania dopo la riunificazione. D’altra parte, si vanno da anni intensificando i rapporti di collaborazione con istitu- zioni italiane e straniere operanti sul territorio della ricerca storica e culturale. In al- cuni casi, come per la Spagna, essi sono particolarmente promettenti e tali da far sperare in un loro sviluppo idoneo ad assicurare crescenti possibilità di intervento e di presenza da parte dell’Istituto Salvemini. -

• Antonio Casu, Introduzione Ai Lavori • Sandro Guerrieri, La Biblioteca Della Camera Dei Deputati Dall'età Liberale Alla
LE BIBLIOTECHE PARLAMENTARI E L’INFORMAZIONE DEL E SUL PARLAMENTO* • Antonio Casu, Introduzione ai lavori • Sandro Guerrieri, La Biblioteca della Camera dei Deputati dall’età liberale alla Repubblica. A proposito del libro di Fernando Venturini • Alberto Petrucciani, Un’istituzione nell’istituzione: vita e prospettive della Biblioteca della Camera • Fulco Lanchester, Osservazioni su una istituzione in trasformazione • Fernando Venturini, Alcune riflessioni sui lettori utenti e i lettori committenti * A proposito del volume di Fernando Venturini Libri lettori e bibliotecari a Montecitorio, promosso nell’ambito del master in Istituzioni Parlamentari “Mario Galizia” per consulenti di assemblea, Biblioteca della Camera, Sala del refettorio, 28 ottobre 2019. Seminari Nomos 3-2019 ISSN 2279-7238 2 INTRODUZIONE AI LAVORI di Antonio Casu * uonasera a tutti. Erano le dodici e trenta dell'8 maggio 1848. Il primo resoconto parlamentare ricorda che a quell'ora “il cannone della Cittadella annunzia B l'inaugurazione del Parlamento nazionale e il vessillo tricolore italiano con lo scudo di Savoia è inalberato sul verone del palazzo Madama, destinato a sede del Senato del regno”. Subito dopo, nella massima formalità si svolge, oggi diremmo a Camere riunite, il Discorso della Corona e tutta la cerimonia, rigidamente regolamentata dal protocollo reale. Finito il Discorso della Corona, che la fisionomia dei resoconti parlamentari ci ricorda essersi svolto tra reiterati applausi, il ministro dell'interno dichiara aperta la prima sessione del Parlamento. Già questo dato, e cioè che ad inaugurare i lavori del primo Parlamento sia stato un importante esponente del potere esecutivo, appare interessante e sintomatico, perché siamo in una fase instaurativa dell'esperienza costituzionale, in cui il ruolo del Parlamento e quello del Governo sono ancora da definire nei loro contorni.