La Storia Di Peccioli (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus 430 430 Pontedera-peccioli-ghizzano Visualizza In Una Pagina Web La linea bus 430 (Pontedera-peccioli-ghizzano) ha 5 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Peccioli: 22:05 (2) Pontedera Arrivo: 05:10 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus 430 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus 430 Direzione: Peccioli Orari della linea bus 430 26 fermate Orari di partenza verso Peccioli: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 22:05 martedì 22:05 Pontedera Corsia 5 44 Via Sacco E Vanzetti, Pontedera mercoledì 22:05 Piaggio 3m giovedì 22:05 Fr Bar Mauro venerdì 22:05 Viale Rinaldo Piaggio, Pontedera sabato Non in servizio Pontedera V.R.Piaggio Fr 24 domenica 13:50 Piazz Corradino D'Ascanio, Pontedera Ospedale V.Roma 244 Informazioni sulla linea bus 430 Direzione: Peccioli Pontedera V.Roma Fermate: 26 Via Roma, Pontedera Durata del tragitto: 35 min La linea in sintesi: Pontedera Corsia 5, Piaggio 3m, Romito Fr Bar Mauro, Pontedera V.R.Piaggio Fr 24, Ospedale, V.Roma 244, Pontedera V.Roma, Romito, Romito V.Delle Colline 55 Romito V.Delle Colline 55, Val Di Cava, Loc.La Valletta, Treggiaia, Treggiaia V.D.Colline Val Di Cava Inc.V.Vecchia, S.Andrea V.S.Francesco 13, Forcoli V.S.Francesco 7, Forcoli, Forcoli V.D.Alighieri 24/26, Loc.La Valletta Baccanella Via Puccini, Baccanella V.Puccini 17, Montanelli V.Puccini Fr 2, V.Delle Colline (Poggio), Tabaccaia Di Peccioli, V.Prov.Di Peccioli Fr Km 4,200, Treggiaia Peccioli S.Sebastiano, Peccioli V.S.Sebastiano (Carabinieri), -

Val Di Cecina
piano paesaggistico scheda d’ambito logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito ambito 13 val di cecina Comuni di: Bibbona (LI), Casale Marittimo (PI), Castagneto Carducci (LI), Castellina Marittima (PI), Castelnuovo di Val di Cecina (PI), Cecina (LI), Guardistallo (PI), Montecatini Val di Cecina (PI), Montescudaio (PI), Monteverdi Marittimo (PI), Pomarance (PI), Radicondoli (SI), Ripabella (PI), Volterra (PI) profilo dell’ambito 1. descrizione interpretativa 2. invarianti strutturali 3. interpretazione di sintesi 4. disciplina d’uso 5. informazioni relative al piano piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito val di cecina Montecatini Val di Cecina Bibbona Saline Volterra Cecina Pomarance Donoratico Castelnuovo Val di Cecina Bolgheri Monteverdi marittimo Castagnateto Carducci Profilo dell’ambito 1 p. 3 val di cecina Profilo dell’ambito p. 4 piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito val di cecina Il paesaggio costiero dell’ambito Val di Cecina è caratterizzato dall’incedere regolare delle forme, dal mare alle colline. La profonda fascia di “Costa a dune e cordoni” so- stiene una testimonianza, ben conservata, delle pinete litoranee. Immediatamente alle spalle, la fascia di Depressioni retrodunali, storiche ‘Maremme’, oggi in gran parte bonificate, ma ancora ospitanti l’eccellenza del Padule di Bolgheri. L’ambiente costiero è tuttavia caratterizzato dalla considerevole espansione edilizia legata al turismo balneare che, concen- trandosi dapprima nei centri sub-costieri di Cecina e Donoratico e nelle Marine, è poi diventato un fenomeno esteso nella forma di villaggi turistici e di campeggi. I centri urbani situati in posizione collinare a ridosso della pianura costiera hanno subito crescite contenute mantenendo il loro carattere di borghi, ma hanno perso importanza rispetto ai nuovi centri sviluppatisi sulla costa. -

S.P. 20 Del Lodano Intero Tratto Monteverdi M.Mo
STRADA N° DENOMINAZIONE DAL KM AL KM COMUNI ATTRAVERSATI S.P. 61 MOLINA DI QUOSA INTERO TRATTO SAN GIULIANO TERME S.P. 56 DEL MONTE SERRA INTERO TRATTO CALCI - BUTI S.P. 38 DI BUTI 1+400 7+700 BUTI - VICOPISANO S.P. 36 PALAIESE INTERO TRATTO MONTOPOLI V.A. - PALAIA S.P. 39 S.MINIATO - S.LORENZO INTERO TRATTO S.MINIATO - MONTOPOLI V.A. - PALAIA S.P. 40 ISOLA S.MINIATO 2+700 5+700 S.MINIATO S.P. 11 DELLE COLLINE PER LEGOLI 11+960 25+320 PALAIA - PECCIOLI S.P. 41 DI PECCIOLI 1+200 5+200 PALAIA - PECCIOLI S.P. 26 DI S.PIETRO BELVEDERE 0+000 6+300 CAPANNOLI - TERRICCIOLA - LARI S.P. 35 DELLE COLLINE DI LARI INTERO TRATTO LARI - CRESPINA - FAUGLIA S.P.46 PERIGNANO - LARI - CASCIANA A. 2+700 9+000 LARI S.P. 31 CUCIGLIANA - LORENZANA 13+600 20+530 FAUGLIA - LORENZANA PONSACCO - LARI - CASCIANA T. - S.P. 13 DEL COMMERCIO INTERO TRATTO S.LUCE -CASTELLINA M.MA - RIPARBELLA S.P. 42 DI TERRICCIOLA INTERO TRATTO TERRICCIOLA - CHIANNI S.P. 21 DEL PIANO DELLA TORA INTERO TRATTO FAUGLIA - LORENZANA - CASCIANA T. S.P. 63 COLLEMONTANINO INTERO TRATTO CASCIANA T. S.P. 37 DELLE COLLINE PER S.LUCE INTERO TRATTO ORCIANO PISANO - S.LUCE S. LUCE - ORCIANO PISANO - S.P. 43 DI ORCIANO INTERO TRATTO LORENZANA S.P. 51 ROSIGNANINA INTERO TRATTO S. LUCE CASCIANA T. - CHIANNI - CASTELLINA S.P. 48 DEL MONTE VASO INTERO TRATTO M.MA S.P. 55 DEL PIAN DEL PRUNO INTERO TRATTO S.LUCE - CHIANNI S.P. -

Anagrafe Delle Societa' Della Delegazione Provinciale Di
ANAGRAFE DELLE SOCIETA’ DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 TEL.:050/26021-050/40938 FAX.:050/7912129 1 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- *** POL. A.BELLANI A.S.D. Matr.750137 2 Categoria - Girone:E Indirizzo - VIA S.JACOPO, 121 56123 PISA Tel.Sede-050/560093 Fax-050/560093 E-Mail:[email protected] Invio corrispond. c/o - SEDE Campo di giuoco - *V. BRONZINI* Tel.-050/560093 Indirizzo - VIA S.JACOPO, 121 PISA Colori sociali - ROSSOBLU Riserva - NERO Presidente - GUIDI FLAVIO Tel.abit-050/552814 Tel.Cell-335/7631576 Dirig.ch.urg. – POSSENTI MAURIZIO Tel.abit-050/28041 Tel.Cell-339/6672019 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- *** A.S.D. ACCIAIOLO CALCIO Matr.920748 3 cat. D.P. Livorno - Girone:A Indirizzo - VIA MARCONI, 4/A 56043 ACCIAIOLO FAUGLIA PI Tel.Sede-050/650831 Fax-050/650305 E-Mail:[email protected] Invio corrispond. c/o - SEDE Campo di giuoco - COMUNALE VAL DI TORA Tel.- Indirizzo campo - VIA PROVINCIALE VAL DI TORA ACCIAIOLO FAUGLIA PI Colori sociali - GIALLOBLU Riserva - VARI Presidente - DI GIAMBATTISTA TONINO Tel.abit-050/650831 Tel.Cell-348/2652259 Dirig.ch.urg.– MARTINUCCI DANIELE - BIASCI VALERIO - BETTI BRUNO Tel.Cell-349/4981938 – Tel.Cell-329/4151240 – Tel.Cell-347/5949884 ------------------------------------------------------------------------- -

Piana Livorno-Pisa-Pontedera
piano paesaggistico scheda d’ambito logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito ambito 08 piana livorno-pisa-pontedera Comuni di: Bientina (PI), Buti (PI), Calci (PI), Calcinaia (PI), Capannoli (PI), Capraia Isola (LI), Casciana Terme (PI), Cascina (PI), Chianni (PI), Collesalvetti (LI), Crespina (PI), Fauglia (PI), Lajatico (PI), Lari (PI), Livorno (LI), Lorenzana (PI), Orciano Pisano (PI), Palaia (PI), Peccioli (PI), Pisa (PI), Ponsacco (PI), Pontedera (PI), Rosignano Marittimo (LI), San Giuliano Terme (PI), Santa Luce (PI), Terricciola (PI), Vecchiano (PI), Vicopisano (PI) profilo dell’ambito 1. descrizione interpretativa 2. invarianti strutturali 3. interpretazione di sintesi 4. disciplina d’uso 5. informazioni relative al piano piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito piana livorno-pisa-pontedera Pisa Pontedera Casciana Terme Peccioli Livorno Castiglioncello Profilo dell’ambito 1 p. 3 piana livorno-pisa-pontedera Profilo dell’ambito p. 4 piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito piana livorno-pisa-pontedera L’ambito Piana Livorno-Pisa-Pontedera - i cui confini non si discostano molto da quelli della sezione pisana del bacino idrografico dell’Arno - presenta una strut- tura territoriale ben riconoscibile disegnata dal sistema insediativo storico e dal sistema idrografico. A caratterizzare la porzione settentrionale, la pianura alluvionale del basso Valdarno, con un’agricoltura intensiva, un’elevata urbanizzazione concentrata e diffusa, la presenza di aree umide relittuali e un ricco reticolo idrografico principale (Arno e Ser- chio) e secondario. La pianura si completa verso ovest con l’importante sistema costiero sabbioso del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. La fascia costiera comprende sia le coste sabbiose - tra Livorno e Marina di Torre del Lago e tra Castiglioncello e Cecina, che la costa rocciosa - tra Livorno e Castiglioncello, a cui si aggiungono gli ambienti insulari delle Isole di Capraia e Gorgona. -

Prospetto Procedure Al 13 Luglio 2011
PERMESSI DI RICERCA GEOTERMIA schema aggiornato al 13 LUGLIO 2011 Avvio Pubblicazione Procedura Verifica Estensione procedimento BUIG/BURT Assoggettabilità VIA Comuni interessati Provincia (Kmq) Concorrente con Fase procedimentale attuale 1 Baccinello 07/10/2009 Buig Anno LIII n.11 Conclusa Campagnatico, Roccalbegna, Arcidosso, PROC. CONCLUSO : concorrenza risolta a GeSto Italia Srl 30/11/2009 Decreto n. 6771/2009 Scansano, Cinigiano GR 108,60 Murci favore di Murci 2 Murci 25/11/2009 Buig Anno LIV n.1 Conclusa Arcidosso, Campagnatico, Castell’Azzara, Enel Green Power SpA 31/01/2010 Decreto n.799/2010 Cinigiano, Magliano in Toscana, Manciano, Baccinello Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Triana Semproniano, Sorano GR 262.70 Catabbio RILASCIATO con decreto n. 1516/2011 3 Serraiola 10/12/2009 Buig Anno LIV n.2 Conclusa Fattoria Perseto del Pozzo Srl 28/02/2010 Decreto n.1321/2010 Monteverdi Marittimo, Pomarance, Monterotondo Montebamboli PROC. CONCLUSO : concorrenza risolta a Sorgenia Geothermal Srl Marittimo, Massa Marittima, Suvereto, Sassetta PI, GR, LI 78,21 Acquaferrata favore di Montebamboli 4 Mazzolla 16/12/2009 Buig Anno LIV n.2 Conclusa Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Montegemoli GeSto Italia Srl 28/02/2010 Decreto n.1015/2010 Radicondoli 72,60 Micciano RILASCIATO con decreto n. 1266/2011 5 Boccheggiano 08/02/2010 Buig Anno LIV n.3 Conclusa Chiusdino, Monticiano, Gavorrano, Massa Alto Farma Enel Green Power SpA 31/03/2010 Decreto n.2209/2010 Marittima, Montieri, Roccastrada SI, GR 233,80 Boccheggiano (Magma) RILASCIATO con decreto n. 2333/2011 6 Montegemoli 08/02/2010 Buig Anno LIV n.3 Conclusa Mazzolla Enel Green Power SpA 31/03/2010 Decreto n.2212/2010 Casale Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Micciano Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Cortolla Pomarance, Volterra, Bibbona PI, LI 267.82 Sterza RILASCIATO con decreto n. -

Dott. Geol. Carlo Meoni
Dott. Geol. Carlo Meoni Via Pascoli, 53/A - 56038 Ponsacco (PI) - Tel./FAX 0587-732249 - Cell. 348.4135608 e-mail : [email protected] - P.E.C. [email protected] carlo meoni, geologo Carlo Meoni geologo ================================================================== CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM STUDI Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l'Università degli Studi di Pisa il 29 giugno 1982, con la votazione di 110/110 e lode. TESI DI LAUREA Vulcanismo neogenico-quaternario del Perù meridionale e della Bolivia sud-occidentale. SOTTOTESI DI LAUREA Rilevamento della parte settentrionale dei Monti di Campiglia Marittima. Ricostruzione della MOHO (nel Perù meridionale, nella Bolivia sud-occidentale e nel Cile settentrionale) sulla base di dati gravimetrici. ESAME DI ABILITAZIONE Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Geologo conseguito presso L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il 6 giugno 1985. ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI Iscritto all'Ordine Nazionale dei Geologi dal 20 giugno 1985 con il n° 5578. Iscritto all'Ordine dei Geologi della Toscana dal 15 luglio 1992 con il n° 363. ESPERIENZA PROFESSIONALE Libero professionista dal 1985. Esperienze professionali nei settori della Geologia ambientale e della Bonifica dell'ambiente e Smaltimento dei rifiuti, nella Progettazione, Direzione dei Lavori di Approntamento e Gestione di Discariche Controllate, nella Geotecnica delle costruzioni, nella Difesa e conservazione del suolo, nell’Uso e assetto del territorio, nella progettazione -

CORSE DI ANDATA (Arrivo a Pisa/Cascina)
22/1/2021 RILEVAZIONE TPL - L. ARTISTICO "RUSSOLI" - Pisa - CORSE DI ANDATA (Arrivo a Pisa/Cascina) RILEVAZIONE TPL - L. ARTISTICO "RUSSOLI" - Pisa - CORSE DI ANDATA (Arrivo a Pisa/Cascina) ll presente modulo è stato creato, in accordo con l'Azienda del Trasporto Pubblico Locale e il Prefetto, per rilevare eventuali problematiche sulle linee dei BUS scolastici. Si prega di rispondere in maniera il più precisa possibile alle domande e di prestare attenzione a selezionare correttamente la corsa a cui si riferisce la segnalazione. Il tuo indirizzo email ([email protected]) verrà registrato quando invii questo modulo. Non sei tu? Cambia account *Campo obbligatorio DATA * Data gg/mm/aaaa COGNOME La tua risposta NOME La tua risposta e-mail Nel caso in cui si voglia essere eventualmente contattati La tua risposta https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoDl1wAHA9ExQZYkk9xFtOoxST3BXzfsh80OSPfPn9cWQvAA/viewform 1/5 22/1/2021 RILEVAZIONE TPL - L. ARTISTICO "RUSSOLI" - Pisa - CORSE DI ANDATA (Arrivo a Pisa/Cascina) CLASSE * 1 2 3 4 5 SEZIONE La tua risposta PRENDI L'AUTOBUS SEMPRE LA MATTINA - A VOLTE O MAI PER IL RITORNO A VOLTE O MAI LA MATTINA - SEMPRE PER TORNARE A CASA SIA ANDATA CHE RITORNO Altro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoDl1wAHA9ExQZYkk9xFtOoxST3BXzfsh80OSPfPn9cWQvAA/viewform 2/5 22/1/2021 RILEVAZIONE TPL - L. ARTISTICO "RUSSOLI" - Pisa - CORSE DI ANDATA (Arrivo a Pisa/Cascina) LINEA ARRIVO A PISA/CASCINA * Attenzione a selezionare correttamente la LINEA a cui si riferisce il monitoraggio 80 Vecchiano -

Shaping the Bible in the Reformation Library of the Written Word
Shaping the Bible in the Reformation Library of the Written Word VOLUME 20 The Handpress World Editor-in-Chief Andrew Pettegree University of St Andrews Editorial Board Ann Blair Harvard University Falk Eisermann Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz Angela Nuovo University of Udine Michael F. Suarez, S.J. University of Virginia VOLUME 14 The titles published in this series are listed at brill.nl/lww Shaping the Bible in the Reformation Books, Scholars and Their Readers in the Sixteenth Century Edited by Bruce Gordon Matthew McLean LEIDEN • BOSTON 2012 Cover illustration: Detail from the title page of the 1543 Biblia Sacrosancta, courtesy of the Department of Special Collections, University of St Andrews Library. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Shaping the Bible in the Reformation : books, scholars, and their readers in the sixteenth century / edited by Bruce Gordon, Matthew McLean. p. cm. -- (Library of the written word ; v. 20) (The handpress world ; v. 14) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-22947-1 (hardback : alk. paper) 1. Bible--History--16th century. 2. Bible--Criticism, interpretation, etc.--History--16th century. 3. Bible--History--17th century. 4. Bible--Criticism, interpretation, etc.--History--17th century. I. Gordon, Bruce, 1962- II. McLean, Matthew (Matthew Adam), 1975- BS445.S37 2012 220.09’031--dc23 2012009441 This publication has been typeset in the multilingual "Brill" typeface. With over 5,100 characters covering Latin, IPA, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.nl/brill-typeface. ISSN 1874-4834 ISBN 978 90 04 22947 1 (hardback) ISBN 978 90 04 22950 1 (e-book) Copyright 2012 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. -

Val Di Cecina.FH10
24 129 44 S. Lucia Agliati Nebbiano 5 Il Pero 5 PONSACCO M. RUGLIOLI Casastrada Lavoria 3 Dogana 108 5 4 Il Trivio Barbialla 3 2 La Turchia 186 S. Martino 4 a 4 1 Cenaia Quattro 4 Montacchita Gello Collelungo CASTELFIORENTINO 50 Vecchia Strade in 6. Forcoli Bagni Voltigiano 6 2 Perignano 3 Camugliano Partino Collegalli S. Stefano S. Chiara 3 4 sc 2 27. Alica Renacchi 2 a PALAIA 5 Cenaia 2 2. PROV. 5.5 C 439 2 -Le Casine 6 Villa 1 148 31. Lucagnano Medicea C. Profeti Volpaia Baccanella 6 193 4 F. Villa Saletta Orceto Solaia Srada 3 L' Olmo Toiano Le Cascine Petrazzi 5 5 3 4 Case 4. -Spinelli 6 62 La Capannina CAPANNOLI 1 Nuove Ceppaiano Convento Tinti dei Mori 5 3.5 4 Montefoscoli M. LA COLLINA Alberi Siberia Catelani SS. Annunziata 207 5. 7. Ripoli 2 Le Selve 5 Piazza 2 182 Sughera Tripalle 4 Mura 7 Colle Capavoli 3 193 C. Ferri 5 6 3. Cevoli S. Pietro Legoli 217 Varna 5 236 T. Egola DI Pillo 1. 147 Belvedere 3 4. 91 3 Sala Ripalta 5 Botteghino 2. S. Caterina Catignano 108 2 S. Ruffino 3. Sorgente 5 3. 5 Salsa CERTALDO FAUGLIA CRESPINA Tonda 5 LARI Chientina Selvatelle 5 Pratello 3 3. 194 MONTAIONE S. Pancrazio Soianella T. T Pieve . -Castelluccio Vicchio Libbiano 372 di S. Maria 5 272 Soiana 6 C 3. Gramugnana PECCIOLI R a 2. Usigliano 5 1. o r f 2. La Rosa g 4.5 alo 332 1 5 7 3 li 2.5 5 Badia a 5 1.5 o Ghizzano Castelfalfi Croce Badia di Casanova 3 Cerreto Tremoleto Casciana Morrone 144 6 GAMBASSI S. -

Elenco Degli Edifici Monumentali
MISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ELENCO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI X X X III Provincia di Pisa ROMA TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE Via Federico Cesi, 45 1921 AVVERTENZA L'idea di formare un catalogo di tutto il patri monio artistico dello Stato risale assai addietro nel tempo. Già l'imperatore Costantino aveva ordmata una statistica degli edifici e delle opere pubbliche che erano allora nelle quattordici re gioni delle città di Roma, donde risultarono, tra le altre opere, 22 statue equestri, 423 templi con 80 statue d’oro e 77 d’avorio e 1352 fontane. Quattordici secoli più tardi, il 20 aprile 1773, il Consiglio dei Dieci di Venezia comandava che fosse compilato il catalogo generale dei più insigni dipinti esistenti nei confini della Serenissima ; ma questo elenco aveva natura di semplice in ventario, di accertamento della consistenza patri moniale della Repubblica, senza effetti giuridici determinati. Questi invece cominciano ad appa rire connessi col catalogo delle opere d’arte nel l'editto Pacca del 7 aprile 1820, il quale, ordi nando la formazione di un elenco degli oggetti artistici più preziosi dello Stato Pontificio, im poneva alle commissioni preposte alla loro conser vazione di esaminarli « presso qualunque proprie tario e possessore ». Unificate le varie provincie in un solo regno, il concetto di porre il catalogo dei monumenti e delle opere d’arte a fondamento di ogni sanzione — fi legislativa appare in quasi tutti i disegni di legge presentati all’esame del Parlamento. Non com preso nel progetto Coppino del 31 maggio 1887, vi fu introdotto dalla Commissione parlamentare che volle la formazione di un unico catalogo degli immobili. -
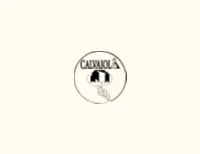
Podere-Calvaiola.Pdf
About our farm Above a windy hill, in the Tuscan countryside near the sea, Podere Calvaiola enjoys the breath taking views of the Tuscan landscape. The farmhouse was build in the 1700s’ for 3 families that had the task of managing the cultivations and farms of the surrounding land. After World War II, the house remained uninhabited until its repurchasing in 2008, by the Giardini family and then restructured with the “Conservative” method, preserving the original structure and materials used. This charming farm offers its guests a variety of six apartments, complemented with a relaxing pool and views of Tuscany. Surrounded by 100 acres of farmland creating a private and calm environment. Podere Calvaiola is the perfect place to relax and make memories among the beauty all around. location Podere Calvaiola is located in the region of Tuscany, province of Pisa. It is a 15km drive to the sea and 1 hour away from Pisa its closest city. weddings and ceremonies Podere Calvaiola offers an excellent location for ceremonies such as: weddings, baptisms, confirmations, communions, cooking classes, etc. For the night, the property has 6 apartments for a total of 20 beds. The nearby church of Casaglia is only 1,5 km distance for religious ceremonies. The large internal living room with exposed walls and old terracotta vaults gives a typical depiction of Tuscany. Podere Calvaiola can accommodate 50 guests (indoor seats) and 50 guests outdoor as well. The large outdoor garden faces a scenic view of the valley. It gives an unforgettable effect to your ceremony and pictures. The catering is entrusted to a catering service that is reliable and guaranteed, in addition, to meals being cooked directly from our kitchen.