14.09 Parco Taburno
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Scarica Il Documento
PROPRIETARIO PROGETTISTA COMMESSA SAIPEM COD. TEC. 023087-210 COMMESSA SNAM 9112956 9112957 NR/19189/R-L01 9112958 LOCALITA’ Comuni di Melizzano (BN), Sant’Agata de’ Goti (BN), SPC-LA-E-83001 Maddaloni (CE), San Felice a Cancello (CE) PROGETTO Rev. Varianti per ispezionabilità Met. Castelcampagnano- Caserta Foglio 1 di 71 DN 550 (22”) e DN 500 (20”) - DP 64 bar nei comuni di 0 Melizzano (BN), Sant’Agata de’ Goti (BN), Maddaloni (CE) e San Felice a Cancello (CE) VARIANTE PER ISPEZIONABILITA’ MET. CASTELCAMPAGNANO-CASERTA DN 550 (22”) e DN 500 (20”) – DP 64 bar nei comuni di Melizzano (BN), Sant’Agata de’ Goti (BN), Maddaloni (CE) e San Felice a Cancello (CE) RELAZIONE PRELIMINARE VERIFICA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO (D. Lgs 50/2016, Art. 25) NN 0 Emissione per Permessi Cesarini Santi Sabbatini 30/06/20 Rev. Descrizione Elaborato Verificato Approvato Data Documento di proprietà Snam Rete Gas S.p.A. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. PROPRIETARIO PROGETTISTA COMMESSA SAIPEM COD. TEC. 023087-210 COMMESSA SNAM 9112956 9112957 NR/19189/R-L01 9112958 LOCALITA’ Comuni di Melizzano (BN), Sant’Agata de’ Goti (BN), SPC-LA-E-83001 Maddaloni (CE), San Felice a Cancello (CE) PROGETTO Rev. Varianti per ispezionabilità Met. Castelcampagnano- Caserta Foglio 2 di 71 DN 550 (22”) e DN 500 (20”) - DP 64 bar nei comuni di 0 Melizzano (BN), Sant’Agata de’ Goti (BN), Maddaloni (CE) e San Felice a Cancello (CE) SOMMARIO: 1. PREMESSA .......................................................................................................................................................... 3 2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO ............................................................................................................................. 3 3. METODOLOGIA APPLICATA ................................................................................................................................19 4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO .............................................................................................................20 5. -

2015.10.18 Cresta Sud Est Monte Taburno.Pdf
Club Alpino Italiano Sezione di Benevento Via Nicola Ciletti 32 82100, Benevento Email: [email protected] Sito web: www.caibenevento.it Fb: www.facebook.com/groups/caibenevento/ Domenica 18 ottobre 2015 Parco Regionale Taburno-Camposauro: Cresta sud est Monte Taburno (1394 m) da San Pietro (Bonea). Intersezionale con il CAI di Salerno Programma Percorso: Loc. San Pietro (Bonea) (570 m), Cresta sud est Taburno (560 m), vetta Monte Taburno (1394 m), Quattro Vie (1220 m), Parcheggio SP117 c/o ex albergo Taburno (1016 m). Dislivello: 840 m in salita, 380 m in discesa Difficoltà : EE (escursionisti esperti) Durata: 5 ore (escluse le soste) N.B. Previsto un percorso alternativo di difficoltà E che, con partenza da ex Albergo Taburno conduce alla Cima del M.Taburno lungo un sentiero a tornanti in abetaia e faggeta per Costa Scamardello e Quattrovie. Ricongiungimento di tutti gli escursionisti alla croce per la colazione al sacco. Appuntamenti ore 08.30 Appuntamento a Piazza Risorgimento in Benevento e partenza per San Pietro (Bonea) con auto ed organizzazione ponte auto. ore 10.00 Raduno loc. San Pietro (Bonea) ed inizio escursione. ore 16.30 Fine escursione. ore 17.30 Orario presunto di ritorno a Benevento NOTA BENE – Possibilità di cenare presso gli amici della “Valle dei Ciliegi” in località Piana di Prata. In tal caso è obbligatoria la prenotazione. Equipaggiamento: abbigliamento a strati da montagna, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, giacca impermeabile o mantellina antipioggia, copricapo, guanti, colazione a sacco, borraccia con acqua, utili i bastoncini da trekking e binocolo. N.B. Al fine della buona riuscita dell’escursione per motivi organizzativi è necessario comunicare in tempo debito eventuali adesioni. -

REGIONE CAMPANIA Settore Staff - Adempimenti Articolo 47 L.R
REGIONE CAMPANIA Settore Staff - Adempimenti articolo 47 L.r. n016/2004. Centro Direzionale, Isola A/6 80143 Napoli fax 081 7967148 SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO-VOLTURNO Viale Lincoln (ex area Saint Gobain) 81100 Caserta fax 0823 300235 AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI TRIGNO-BIFERNO E MINORI-SACCIONE-FORTORE Traversa Via Crispi 70/A 86100 Campobasso fax 0874 424809 AUTORITA' DI BACINO NORD-OCCIDENTALE Centro Direzionale, Isola E/3 80143 Napoli fax 081 7504925 ENTE PARCO REGIONALE DEL TABURNO-CAMPOSAURO Piazza Mercato, 2 82030 Frasso Telesino (BN) fax 0824 973979 ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO Via Borgonuovo, 25/27 83010 Summonte (AV) fax 0825 691166 ENTE PARCO REGIONALE DEL MATESE Piazza Vittoria 81013 San Potito Sannitico (CE) fax 0823 543304 DIREZIONE GENERALE PER IBENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA Via Eldorado 1 - Caste1 delllOvo, 80132 Napoli fax 081 7645305 ALTRI ENTI TERRITORIALI REGIONE CAMPANIA Assessorato Urbanistica, Politiche del Territorio, Edilizia Pubblica Abitativa, Accordi di Programma Centro Direzionale, Isola A/6 80143 Napoli fax 081 7967110 REGIONE CAMPANIA Assessorato Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Difesa del Suolo, Parchi e Riserve Naturali, Protezione Civile Via De Gasperi, 28 80134 Napoli fax 081 7963207 REGIONE CAMPANIA A.G.C. 05 - Tutela dell'ambiente Via De Gasperi, 28 80134 Napoli fax 081 7963048 REGIONE CAMPANIA A.G.C. 16 - Governo del Territorio Centro Direzionale, Isola A/6 80143 Napoli fax 081 7967122 REGIONE CAMPANIA Assessorato -

(Southern Apennines, Italy): Coralline Assemblage Characterization and Related Trace Fossils
Sedimentary Geology 225 (2010) 50–66 Contents lists available at ScienceDirect Sedimentary Geology journal homepage: www.elsevier.com/locate/sedgeo Re-deposited rhodoliths in the Middle Miocene hemipelagic deposits of Vitulano (Southern Apennines, Italy): Coralline assemblage characterization and related trace fossils Alessio Checconi a,⁎, Davide Bassi b, Gabriele Carannante c, Paolo Monaco a a Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Perugia, Piazza dell'Università 1, I-06100 Perugia, Italy b Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Ferrara, via Saragat 1, I-44122 Ferrara, Italy c Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Largo S. Marcellino 10, I-80138 Napoli, Italy article info abstract Article history: An integrated analysis of rhodolith assemblages and associated trace fossils (borings) found in hemipelagic Received 16 April 2009 Middle Miocene Orbulina marls (Vitulano area, Taburno–Camposauro area, Southern Apennines, Italy) has Received in revised form 31 December 2009 revealed that both the biodiversity of the constituent components and taphonomic signatures represent Accepted 8 January 2010 important aspects which allow a detailed palaeoecological and palaeoenvironmental interpretation. Available online 21 January 2010 On the basis of shape, inner arrangement, growth forms and taxonomic coralline algal composition, two Communicated by rhodolith growth stages were distinguished: (1) nucleation and growth of the rhodoliths, and (2) a final M.R. Bennett growth stage before burial. Nucleation is characterized by melobesioids and subordinately mastophoroids, B. Jones with rare sporolithaceans and lithophylloids. The rhodolith growth (main increase in size) is represented by G.J. Weltje abundant melobesioids and rare to common mastophoroids; very rare sporolithaceans are also present. -

Valutazione Impatto Ambientale
INDICE INDICE 1 PREMESSE ........................................................................................................................................ 6 2 SCOPO E CRITERI DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE ........................................ 7 3 INFORMAZIONI UTILI SULLA PROPRIETÀ/SOCIETÀ ............................................................................. 9 3.1 RISORSE UMANE ..................................................................................................................................... 9 3.2 ATTREZZATURE ....................................................................................................................................... 9 4 DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE FISICO, BIOLOGICO E ANTROPICO ..................................................... 10 4.1 CLIMA ................................................................................................................................................ 10 4.1.1 Precipitazioni .............................................................................................................................. 10 4.1.2 Temperatura .............................................................................................................................. 11 4.1.3 Ventosità .................................................................................................................................... 12 4.1.4 Indici climatici ............................................................................................................................ -

Late Quaternary Environmental Evolution of the Intermontane Valle Caudina Basin, Southern Italy
Late Quaternary environmental evolution of the intermontane Valle Caudina basin, southern Italy Micla Pennetta, Filippo Russo & Carlo Donadio Rendiconti Lincei SCIENZE FISICHE E NATURALI ISSN 2037-4631 Volume 25 Supplement 2 Rend. Fis. Acc. Lincei (2014) 25:231-240 DOI 10.1007/s12210-014-0334-9 1 23 Your article is protected by copyright and all rights are held exclusively by Accademia Nazionale dei Lincei. This e-offprint is for personal use only and shall not be self- archived in electronic repositories. If you wish to self-archive your article, please use the accepted manuscript version for posting on your own website. You may further deposit the accepted manuscript version in any repository, provided it is only made publicly available 12 months after official publication or later and provided acknowledgement is given to the original source of publication and a link is inserted to the published article on Springer's website. The link must be accompanied by the following text: "The final publication is available at link.springer.com”. 1 23 Author's personal copy Rend. Fis. Acc. Lincei (2014) 25 (Suppl 2):S231–S240 DOI 10.1007/s12210-014-0334-9 INTERMONTANE BASINS IN CENTRAL-SOUTHERN ITALY Late Quaternary environmental evolution of the intermontane Valle Caudina basin, southern Italy Micla Pennetta • Filippo Russo • Carlo Donadio Received: 20 December 2013 / Accepted: 5 September 2014 / Published online: 25 September 2014 Ó Accademia Nazionale dei Lincei 2014 Abstract The Valle Caudina intermontane basin in the suffered a substantial downsizing or has disappeared southern Apennines (Italy) lies between the Mt. Taburno on between 5 kyr BP and the Roman Age. -

Ethnobotanical Study of the Sannio Area, Campania, Southern Italy
Ethnobotanical Study of the Sannio Area, Campania, Southern Italy Carmine Guarino, Luciana De Simone and Simona Santoro Research Abstract Ethnobotanical study of the Sannio area, in the province In the past medicinal plants were the first defence against of Benevento (SE-Italy) has been carried out on the basis diseases and they represented the only available thera- of both bibliographic sources and interviews in the field. In peutic means until chemistry started using nature as a total 365 species in 59 families were identified. Of these model for the synthesis of therapeutically active mole- species, 361 are medicinal plants, 82 for anthropic use cules. Nowadays, medicinal plants are still, in part, reso- lutive remedies, but, above all, they represent the first and 35 for veterinary use. source of active principles for medicaments as well as an essential source of molecular material for hemi-synthe- Riassunto sis processes (Calixto 2000, Cragg et al. 1997, De Smet 1997, Shu 1998). Uno studio etnobotanico del Sannio, in provincia di Be- nevento (SE-Italy), è stato effettuato sia sulla base di fon- Therefore, the interest in medicinal plants has remark- ti bibliografiche che di interviste in campo. In totale, 365 ably increased lately. In fact, a lot of works about vege- specie di 59 famiglie sono state censite. Di queste specie, table chemical structures and pharmaceutical properties 265 sono piante medicinali, 82 per uso antropico e 35 per have appeared. These works not only aim at discover- uso veterinario. ing new usable essences, but also at testing – by means of modern techniques - the properties and the effects of many plants now fallen into disuse or employed by popu- Introduction lar medicine in the past. -

PROVINCIA Di BENEVENTO
La presente deliberazione viene affissa il 17.02.2021 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni PROVINCIA di BENEVENTO COPIA Deliberazione del Presidente della Provincia n. 34 del 16.02.2021 OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI CONGIUNTE ED ISTITUZIONALI TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO, LA COMUNITA’ MONTANA DEL TABURNO-CAMPOSAURO (CAPOFILA) ED I COMUNI DI TOCCO CAUDIO, CAUTANO, BONEA, FRASSO TELESINO E VITULANO PER LA PER LA REDAZIONE DELLE DIVERSE FASI DI PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELLA STRADA PROVINCIALE S.P. N° 140 e S.P. N° 156, TURISTICO RICETTIVA DEL PARCO REGIONALE TABURNO CAMPOSAURO”. APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 15,40 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto. IL PRESIDENTE VISTA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE TECNICO- SERVIZIO VIABILITA’ 1 e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti; RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto; RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del Tuel; ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex art. 108 del D.L.gs n. 267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza; VISTI Il D.Lgs. 267/2000; La Legge 127/1997 e s.m.i.; Il Regolamento D.P.R. -
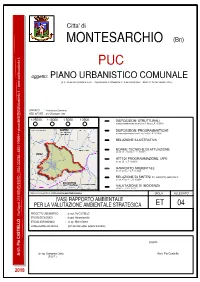
VAS in Data 02/10/2009 Con Prot
CITTÀ DI MONTESARCHIO – PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) - 2018 PREMESSA L’Amministrazione Comunale di Montesarchio con atto di G.C. n.41 del 31.03.2015 ha deliberato il riavvio della procedura per la formazione del Piano Urbanistico Comunale e del relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, coerentemente alle disposizioni della L.R. n.16/04, del Regolamento Attuativo n.5/2011, nonché del Piano Territoriale di Coordinamento vigente, nel contempo pervenuto all’approvazione con delibera di C.P. n.27 del 26.07.2012 e verifica di compatibilità col PTR (delibera G.R. n.596 del 19.10.2012), nonché successiva integrazione con delibera del Commissario Straordinario n.49 del 09.04.2014. La precedente elaborazione della Proposta di PUC, predisposta con delibera di G.C. n.266 del 16.07.2009, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n.16 del 22.12.2004, in uno con il Rapporto Ambientale aveva conseguito tutti i pareri degli organi tutori, di seguito elencati • Regione Campania - Assessorato Ambiente- Settore Tutela dell’a Ambiente – Area 05 Ecologia e Tutela del territorio- Settore VIA-VAS in data 02/10/2009 con prot. 20923; • Genio Civile di Benevento in data 02/10/2009 con prot .n. 20924; • Autorità di Bacino Liri - Garigliano e Volturno in data 02/10/2009 con prot .n. 20925; • ASL BN1 in data 02/10/2009 con prot .n. 20926; • Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento in data 02/10/2009 con prot .n. 20927; • Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Salerno,Avellino, Benevento e Caserta in data 02/10/2009 con prot .n. -

PROGETTO INTEGRATO Parco Regionale Del Taburno Camposauro
Parco Regionale del Taburno Camposauro Infrastrutture Numero Denominazione Beneficiario Altre risorse Identificativo intervento Misura Risorse POR pubbliche Risorse private Costo totale I01 RINATURALIZZAZIONE PROVINCIA DI 1.9 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 800.000,00 DELL'ASSE OVEST-EST DI BENEVENTO PENETRAZIONE AL PARCO TABURNO CAMPOSAURO SUL TRACCIATO DELLA S.P. N.120 E DELLA 117 I03 Porta d'ingresso al Parco dalal PROVINCIA DI 1.9 € 850.000,00 € 0,00 € 0,00 € 850.000,00 Valle Caudina - Isclero BENEVENTO all'interno dell'ex Torre Carceraria del Castello Ducale di S. Agata dei Goti I04 Realizzazione del S.I.A. del PROVINCIA DI 1.9 € 315.000,00 € 0,00 € 0,00 € 315.000,00 Parco del Taburno Camposauro BENEVENTO I05 Sentiero multifunzionale PROVINCIA DI 1.9 € 655.153,00 € 0,00 € 0,00 € 655.153,00 naturalistico di penetrazione BENEVENTO della Porta sud- occidentale di S. Agata dei Goti I06 Completamento del BAAS SA-BN-AV 1.9 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 800.000,00 comnplesso monumentale del Castello di Montesarchio e allestimento del Museo Archeologico nazionale del Sannio Caudino I07 Recupero degli insediamenti BAAPSAD CE-BN 1.9 € 1.335.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.335.000,00 rupestri e dei percorsi pedemontani I09 Recupero, riqualificazione e BUCCIANO 1.9 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00 valorizzazione degli invasi spaziali del centro storico I10 Centro di informazione turistica CAUTANO 1.9 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00 dislocato all'interno di un edificio comunale da risanare e all'interno di un sito rupestre e riqualificazione -

Per Informazioni Parco Regionale Del Taburno-Camposauro Progetto
Parco Regionale del Taburno-Camposauro I Comuni del Parco: Bonea, Bucciano, Cautano, Foglianise, Per informazioni Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Parco Regionale del Taburno- Montesarchio, Paupisi, S.Agata dei Goti, Camposauro Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano. Telefono/fax:0824/973061 Via Tuoro - Frasso Telesino (BN) 82 E-mail: [email protected] Sito internet: www.parcotaburno.it Progetto Integrato Parco Regionale del Taburno-Camposauro Funzioni dell’Ente Parco: Territorio in cifre: Progetti in corso nel P.I. - Tutela i valori naturali ed Numero comuni: 14 Infrastrutture e Misura 1.9 - Recupero, 2 servizi: valorizzazione e promozione del ambientali Superficie: 329,61 km patrimonio storico culturale, Popolazione PI: 56.483 archeologico, naturale, € 14.094.153,00 etnografico e dei centri storici -conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità Il Progetto Integrato: Regimi di aiuto Misura 1.10 - Sostegno allo geologiche, di formazioni paleontologiche, di alle imprese: sviluppo di micro- comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici Il POR Campania 2000-20006 individua imprenditorialità- Ristorazione, Artigianato e Piccolo e panoramici, di processi naturali, di equilibri quale ambito di realizzazione della € 4.698.051,00 idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; Commercio, Servizi turistici - progettazione integrata i Parchi regionali. Piccola ricettività turistica L’Ente Parco è il soggetto capofila del P. I. -applicazione di metodi di gestione o di restauro e svolge una funzione di coordinamento e Formazione: MISURA 1.11 - Promozione di ambientale idonei a realizzare una integrazione € 649.556,69 una forza lavoro competente e di presidio del Tavolo di concertazione nuova imprenditorialità tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la Istituzionale. -

Montagne E Non Solo (Pdf)
Si trova esattamente ad ovest di Benevento da cui dista pochi chilometri e nella cui provincia ricade interamente. A nord il massiccio è separato dalle montagne del Matese per mezzo dalla Valle Telesina solcata dal fiume Calore, mentre a sud la Valle Caudina lo separa dai monti del Partenio Le vette più alte sono il monte Taburno (1393 m s.l.m.), il Camposauro (1390 m s.l.m.), il monte Alto Rotondi (1305 m s.l.m.), il monte Sant'Angelo (1189 m s.l.m.) , monte Gaudello (1226 m s.l.m. )ed il monte Pentime (1168 m s.l.m.), disposti a semicerchio dando forma nel mezzo alla " valle Vitulanese". Il monte Taburno, importante monte che abbraccia Vitulano è protetto con l'istituzione del Parco Naturale Regionale Taburno‐Camposauro (Dal 14 settembre 1994) dalla comunità montana del Taburno ed è tutelato anche dal Piano Paesistico del Taburno, entrato in vigore nel 1996. Dalla sua vetta si gode di un vasto panaroma su tutta la valle Caudina densamente antropizzata e chiusa dalla parte opposta dal massiccio del Partenio. Ad ovest dove la valle diventa più stretta, si nota una macchia bianca sul fianco di un monte: è la cava del monte Tairano nei cui pressi si svolse l'episodio del 321 a.C. tra Romani e Sanniti ( Battaglia delle Forche Caudine ) Oltre il Partenio nelle giornate più limpide si possono vedere il Vesuvio ed i monti Lattari. Dalla città di Benevento il profilo del massiccio assume le sembianze di una donna supina, con i piedi verso la valle Caudina, e la testa (Monte Pentime) verso la valle telesina, viene quindi chiamato " la Dormiente del Sannio".