La Storia Del Calcio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Giovedì 25 Marzo
GIOVEDÌ 25 MARZO - ORE 20:45 ITALIA - IRLANDA DEL NORD STADIO ENNIO T ARDINI, PARMA DOMENICA 28 MARZO - ORE 20:45 BULGARIA - ITALIA STADIO VASIL LEVSKI , SOFIA MERCOLEDÌ 31 MARZO - ORE 20:45 LITUANIA - ITALIA L FF STADIUM , VIL NIUS CARTELLA STAMPA INIZIANO LE QUALIFICAZIONI AL MONDIALE 2022: AZZURRI CON IRLANDA DEL NORD, BULGARIA E LITUANIA Il nuovo anno, che sarà cara tterizzato dall’Europeo in estate e dalla Final Four di Nations League a ottobre, si apre con le prime sfide per conquistare l’accesso al torneo in Qatar. In campo a Parma con i nord irlandesi, poi doppia trasferta a Sofia, dove l’Italia non ha mai vinto, e Vilnius. Firenze, 22 Marzo 2021 – Dopo la pausa invernale, torna in campo la Nazionale: conquistata la Fase Finale della Nations League 2021 e in attesa di Euro 2020 posticipato a causa della pandemia, per l’Italia inizia una nuova competizione, le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Gli Azzurri, inseriti nel girone C, avranno subito un intenso calendario con tre sfide in questa finestra internazionale: il 25 marzo Italia – Irlanda del Nord (Stadio “Tardini” di Parma), il 28 marzo Bulgaria – Italia (Stadio “Vasil Levski” di Sofia), il 31 marzo Lituania – Italia (Stadio LFF di Vilnius), tutte alle ore 20.45 con diretta su Rai 1. Il CT Roberto Mancini ha convocato un gruppo di 38 calciatori: prima chiamata per il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi e per il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci. La risposta alla convocazione di Ricci e dei calciatori dell’Inter Bastoni, Barella e Sensi, attualmente sottoposti a misure sanitarie restrittive, è subordinata alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti. -

50 Anni Di Friuli a Roma
Prima di copertina (dal basso in alto): Carnelutti, Desio, Moselli, Rubbia, Afro, Mirko, Angeli, Pasolini, Turoldo, Astaldi. Retro di copertina (dall’alto in basso): Tondo, Tessitori, Valerio, Toros, Leicht, Sartogo, Galanti, Zucchet, Girolami, Degano. Mostra Cinquant’anni di Friuli a Roma Una presenza dal 1945 Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed il Patrocinio di: Senato della Repubblica Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Regione Lazio Comune di Roma Galleria “L’Agostiniana” Roma, piazza del Popolo, 12 11 aprile - 5 maggio 2002 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Fogolâr Furlàn di Roma Friuli nel Mondo Realizzazione e stampa Arti Grafiche Friulane SpA Tavagnacco, Udine Regione Friuli Venezia Giulia Regione Lazio Comune di Roma Astaldi S.p.A. - Roma Generali - Assicurazioni Generali Banca Intesa - Milano Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Udine Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone (CRUP) Faber S.p.A. - Cividale del Friuli Dal Fari - azienda agricola - Cividale del Friuli Telit Mobile Terminals S.p.A. - Trieste Consorzio Latterie Friulane Prosciutto di San Daniele Mostra “Cinquant’anni di Friuli a Roma” Comitato scientifico: Giovan Battista Altan, storico; Ugo Bari, generale; Giuseppe Bergamini, dir. Civici Musei Udine; Ferruccio Clavora, dir. Friuli nel Mondo; Antonio Clemente, giornalista; Fausto Corrubolo, maestro; Damiano Damiani, regista; Licio Damiani, critico; Ermes Disint, giornalista; Piero Fortuna, giornalista; Rodolfo Grasso, architetto; Luciano Pettoello Mantovani, docente; Bruno Martinis, Accademico dei Lincei; Carlo Mattiussi, ingegnere; Franco Mistretta, ministro; Carlo Mittoni, generale; Giuliana Morandini, scrittrice; Stanislao Nievo, scrittore; Piero Nigris, magistrato; Mario Padovan, critico; Leonardo Pascoletti, architetto; Gian Luigi Pezza, avvocato; Alberto Picotti, scrittore; Gianfranco Plenizio, maestro; Claudio Pighin, docente; Francesco Pittoni, ingegnere; Mario Quargnolo, critico; Isabella Reale, dir. -

Jalkapalloelämän Alkeismuodot
JALKAPALLOELÄMÄN ALKEISMUODOT Pyhä milanolaisten ultrakannattajien yhteisöllisyyttä uusintavana kategoriana Ville Niemelä Uskontotieteen pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2019 HELSINGIN YLIOPISTO − HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto − Fakultet/Sektion Laitos − Institution Teologinen tiedekunta Tekijä − Författare Ville Valtteri Niemelä Työn nimi − Arbetets titel Jalkapalloelämän alkeismuodot: Pyhä milanolaisten ultrakannattajien yhteisöllisyyttä uusinta- vana kategoriana Oppiaine − Läroämne Uskontotiede Työn laji − Arbetets art Aika − Datum Sivumäärä − Sidoantal Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2019 100 Tiivistelmä − Referat Tutkimus sijoittuu uskontososiologian, urheilusosiologian ja pyhän tutkimuksen leikkauspis- teeseen. Kahden suuren milanolaisen jalkapalloseuran – punamustan Milanin ja sinimustan Interin – ultrakannattajien yhteisöllisyyttä tarkastellaan jälkidurkheimilaisen teorianmuodos- tuksen valossa. Teoreettisen viitekehyksen keskiössä on Gordon Lynchin pyhän kulttuuri- sosiologia. Pyhä on kollektiivinen representaatio – näennäisessä järkkymättömyydessään ja pakottavuudessaan voimantäyteinen sekä tahrattomuudessaan kielletty. Sen vastapoolina on kielloilla eristetty saastuttava profaani. Tekstiaineistona hyödynnetään ultraryhmittymien kannatuslauluja, banderolleja ja katsomokoreografioita. Tutkimuksen keskeiset kysymykset liittyvät ultrien pyhän symbolikoodiston ja sen ympärille rakentuvan sosiaalisen todellisuuden selvittämiseen. Menetelminä käytetään laadullista si- sällönanalyysia ja diskurssianalyysia. Metodeista jälkimmäinen -

Barmes News 48
Alla scoperta del nostro villaggio Luglio 2017 numero 48 Stambecchi all’ingresso del paese • Gio’ Giacomo Castagneri, medico di Sua Altezza Serenissima Carlo Emanuele I, Duca di Savoia • La pietra del sindaco, del vallone del Ru - Alcune considerazioni sulla ‘ollare’ di Balme. • La consegna dell’attestato di benemerenza ad Antonio Castagneri, in occasione dell’inaugurazione del ponte sulla Gorgia di Mondrone • Balmesi a Roma per il matrimonio dei Principi di Piemonte • La storia del rifugio Gastaldi • Eliski, il turismo che cade • Tre segnali per una vetta - A.Tonini, M.Baretti, G.Rey e la Bessanese (Prima parte) • L’aria della Val d’Ala per gli invincibili del Grande Torino • Il Labirinto verticale • La mòla dal Mòles Realizzato a cura del Comune di Balme (TO), scaricabile dal sito web: www.comune.balme.to.it Inviare gli articoli all’indirizzo mail: [email protected] BARMES NEWS n.48 Gio’ Giacomo Castagneri, medico di Sua Altezza Serenissima Carlo Emanuele I, Duca di Savoia Gianni Castagneri Nell’accurato manoscritto conservato da alcune l’iscrizione: “ 1591 ali 5 magio / me Jouane Castagnero famiglie, dove è riportata tutta la genealogia dei / ho fato la pte casa / laus deo ”. Castagneri balmesi, la nota su Giò Giacomo risulta Nei primi anni del Seicento intanto, si era ormai incompleta, mancando del tutto le date di nascita, di affermato tra le personalità più ragguardevoli della morte e relative discendenze. Soltanto, accanto al nome valle, risultava proprietario di vasti appezzamenti e di battesimo, è riportato l’appunto “ Medico di S.A.S. al affittava l’estesa e produttiva alpe di Ciamarella dagli Duca di Savoia ”. -

Hernán Jorge Crespo Relatore: Renzo Ulivieri
Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio Corso Master Uefa Pro Hernán Jorge Crespo “IL CALCIATORE MODERNO: IDENTITA’, NAZIONALISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE ” Relatore: Renzo Ulivieri Stagione Sportiva 2012 – 2013 1 INTRODUZIONE PAG. 2 2 LA NASCITA DEL CALCIO PAG. 4 3 ARGENTINA 3.1 IL “FÙTBOL DE POTRERO” PAG. 6 3.2 CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE PAG. 8 3.3 ANALISI DEL CALCIO ARGENTINO PAG. 11 4 ITALIA 4.1 LA PATRIA DELLA TATTICA PAG. 12 4.2 PARMA FOOTBALL CLUB PAG. 14 4.3 ANALISI DEL CALCIO ITALIANO PAG. 16 5 INGHILTERRA 5.1 DALLA “PIRAMIDE DI CAMBRIDGE” AL “PASS AND MOVE” PAG. 18 5.2 CHELSEA FOOTBALL CLUB PAG. 21 5.3 ANALISI DEL CALCIO INGLESE PAG. 22 6 CONCLUSIONI PAG. 24 1 1. INTRODUZIONE Secondo uno studio svolto dalla FIFA1, nel Mondo ci sono 270 milioni di persone che praticano il calcio, ovvero circa il 4% della popolazione mondiale. Mappa 1: Sport più popolari per Nazione 2. In verde il calcio. La maggior diffusione si ha in Europa, Nord e Sud America, dove le persone coinvolte rappresentano il 7% della rispettiva popolazione totale. In queste nazioni il calcio rappresenta un punto di riferimento che oltrepassa il semplice gioco arrivando a unire un quartiere, una città, una regione addirittura una nazione. Mappa 2: diffusione del calcio nel mondo. I paesi in verde sono quelli dove il calcio è lo sport numero uno per popolarità, viceversa gli stati rossi. Il rapporto giocatori/popolazione è espresso dall'intensità della colorazione3. 1 FIFA Big Count 2006: 270 million people active in football, p. -

Da Giovedì Raduno a Coverciano Poi Tre Test Con Arabia Saudita, Francia E Olanda
CARTELLA STAMPA NASCE L’ITALIA DI MANCINI: DA GIOVEDì RADUNO A COVERCIANO POI TRE TEST CON ARABIA SAUDITA, FRANCIA E OLANDA PER IL NEO CT SUBITO TRE SFIDE UTILI PER PREPARARE L’ESORDIO IN NATIONS LEAGUE. IN CAMPO A SAN GALLO, NIZZA E TORINO. AZZURRI AL LAVORO DA OGGI A COVERCIANO. Roma, 24 Maggio 2018 – Torna in campo la Nazionale, con il neo Commissario Tecnico Roberto Mancini all’esordio, per affrontare in amichevole Arabia Saudita (San Gallo, Stadio ‘Kybunpark’ - 28 maggio, ore 20.45), Francia (Nizza, Stadio Allianz Riviera - 1 giugno, ore 21.00) e Olanda (Torino, Juventus Stadium - 4 giugno, ore 20.45). In ritiro a Coverciano dal 24 maggio, per l’Italia le tre sfide amichevoli rappresentano un ponte verso la nuova stagione, che inizierà a settembre nel segno della Nations League e proseguirà poi da marzo con le Qualificazioni per l’Europeo 2020 che si aprirà proprio in Italia, a Roma, sede della gara inaugurale, di tre partite del girone e di un Quarto di finale. Primo allenamento oggi per il neo CT Mancini e per il suo staff composto, tra gli altri, dagli assistenti allenatore Alberico Evani, Angelo Adamo Gregucci, Giulio Nuciari e Fausto Salsano. Nel gruppo, 28 convocati: alla prima chiamata Daniele Baselli, Rolando Mandragora e Mattia Caldara; ritornano Domenico Berardi e Mario Balotelli, dopo aver preso parte ai raduni rispettivamente di ottobre e novembre 2016 nei quali accusarono un infortunio che impedì loro di scendere in campo. Indisponibili dopo la convocazione Claudio Marchisio, Emerson Palmieri Dos Santos e Federico Bernardeschi. ARABIA SAUDITA – ITALIA. Sarà una prima per gli Azzurri contro l’Arabia Saudita e sarà anche la prima uscita a San Gallo, 7a sede in Svizzera per la Nazionale dopo Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Zurigo. -

Jesse Fioranelli – Perché Investire Nel Calcio Italiano
Perché investire nel calcio Italiano. Jesse Fioranelli Relatore: Paolo Piani, Federazione Italiana Giuoco Calcio Corso Direttore Sportivo 2016/17 Jesse Fioranelli, Perché investire nel calcio Italiano, Corso Direttore Sportivo 2016/17 1 Indice Prefazione …………………………………………………………………………………. 3 1. Perché partire dal ´PERCHÉ´? …………………………………………..……… 5 2. Come mai il calcio Italiano dovrebbe partire dal ´PERCHÉ´? ….…………… 7 3. Perché investire nel calcio Italiano. .……………………………………….…… 13 4. Perché giochiamo a calcio? .…………………………………………..………. 17 5. Perché formiamo giocatori? Perché abbiamo bisogno di seconde squadre? …………………….……… 21 5b Cosa hanno i Tedeschi, gli Inglesi e i Giapponesi in comune? ….……….. 26 6. Perché compriamo giocatori? ………………………………………….…….. 29 7. Perché investire in un metodo? ………………………………………..…….. 37 8. Perché assumere quelli che credono nel tuo ´PERCHÉ è cosi importante 40 9. Perché vogliamo trasferire il nostro know-how ……………………............ 43 9b. Sviluppo focalizzato sul giocatore ……………………………………………. 46 10. Perché abbiamo bisogno dei “big data”? .………………………………….. 49 11. Perché l´Italia può capitalizzare da un suo proprio metodo. ..……………. 52 Bibliografia Jesse Fioranelli, Perché investire nel calcio Italiano, Corso Direttore Sportivo 2016/17 2 Prefazione Può una tesi iniziare con un “PERCHÉ” e non formulare una domanda? Certo! “Perché investire nel calcio Italiano” ha un significato più rilevante affinché le diverse parti interessate riescano ad identificarsi. Nonostante le difficoltà che il calcio Italiano ha vissuto negli ultimi 10 anni, ci sono diverse motivazioni perché gli “stakeholders”, ovvero le persone interessate al benessere del club identificabile in questa tesi, come il Presidente, il Direttore Sportivo, l´allenatore e il giocatore, possono investire nel calcio Italiano. Così come quel “PERCHÉ” ha la funzione ad aumentare l´attenzione del lettore, così lo dovrebbe catalizzare il messaggio al quale è indirizzato il suo scopo. -

Language Barriers in Sports: the Case of Italian Professional Football
Language Barriers in Sports: the case of Italian Professional Football RAYMOND SIEBETCHEU This chapter aims at illustrating the dynamics of language barriers in sports and specifically in football. Considering the high percentage of international mobility of football players, the research focuses on the effects of the multilingualism generated by this type of international migration. It also analyses language barriers by focusing on banners in the Italian stadia. These banners, which should be re-coded to be comprehensible, were mainly collected from the digital database of the Striscia la Notizia broadcast archives. Through a demo-linguistic overview, the research reveals that 482 foreign players, recorded in the Serie A and Serie B (season 2015-2016) on the basis of the teams official websites, come from more than 69 countries and speak at least 44 languages. The inevitable language barriers which arise are ana- lysed, considering that teams need to efficiently manage multilingual- ism to overcome these barriers for the ultimate purpose of sports com- petition. The study therefore proposes two models as first steps in managing language interaction in football, respectively on the basis of collective multilingualism and individual multilingualism. It further highlights that language diversity in football should be considered as an asset and suggests that future research should be conducted on lin- guistic and cultural mediation in football in the attempt to resolve lan- guage barriers in this field of social practice. Key words: multilingualism, football, immigration, language barriers, mediation 145 146 Raymond Siebetcheu 1. Introduction Multilingualism is not only the preserve of academics and bookish linguists, but it is also currently gaining ground in the social practice of sports. -

REGULAMENTO Taça Da Liga De Futsal Masculino
REGULAMENTO Taça da Liga de Futsal Masculino d 0 TAÇA DA LIGA DE FUTSAL MASCULINO CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 1.º Norma Habilitante O presente Regulamento é adotado ao abrigo do disposto no artigo 10.º e nas alíneas a) e c) do número 2 do artigo 41.º do Regime Jurídico das Federações Desportivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 93/2014, de 23 de junho. Artigo 2.º Objeto 1. O presente Regulamento rege a organização da Taça da Liga de Futsal. 2. Qualquer referência no presente Regulamento a Taça, Prova ou Competição, será tida como feita à Taça da Liga de Futsal. Artigo 3.º Disposições prévias 1. Todas as referências a Clubes constantes do presente Regulamento abrangem igualmente as Sociedades Desportivas. 2. As referências à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) constantes do presente Regulamento e que não indiquem o órgão competente para o respetivo efeito serão consideradas como referentes ao órgão materialmente competente em função dos Estatutos e da legislação aplicável. Artigo 4.º Princípios Gerais 1. A Taça da Liga de Futsal é realizada em observância dos princípios da ética, da defesa do espírito desportivo e da verdade desportiva. Taça da Liga de Futsal Masculino 1 2. Todos os intervenientes devem colaborar de forma a prevenir comportamentos antidesportivos, designadamente violência, dopagem, corrupção, racismo, xenofobia, ou qualquer outra forma de discriminação. Artigo 5º Integração de lacunas 1. A Taça da Liga de Futsal rege-se exclusivamente pelas disposições deste Regulamento, sem prejuízo das normas imperativas emanadas pela Féderation Internationale de Football Association (FIFA), pela Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e pela legislação aplicável. -
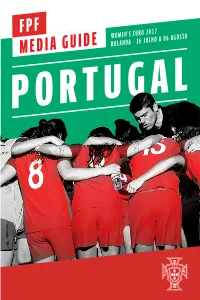
Fpf Media Guide
FPF WOMEN'S EURO 2017 MEDIA GUIDE HOLANDA · 16 JULHO A 06 AGOSTO PORTUGAL EUROPEU DE FUTEBOL HOLANDA 2017 FUTEBOL 1 PRESIDENTE FPF · FPF PRESIDENT FERNANDO GOMES HONRAR PORTUGAL A QUESTION OF DEVOTION Portugal chega à Holanda com a consciência do cenário ideal para escrever mais uma página Portugal arrives in the Netherlands aware of the The increase in the number of girls and women caminho já trilhado; a confiança de quem conta memorável do futebol português. path already travelled; the trust of those who playing football, the growth in the number of com a dedicação, talento, espírito de sacrifício O aumento do número de meninas e senhoras count on the devotion, talent, spirit of sacrifice women’s competitions, clubs and national teams is e amor à camisola das nossas jogadoras e o a jogar futebol, o crescimento do número de and commitment of our players and the purpose for us a sign of the development of the Country we propósito de construir um futuro ainda mais competições, clubes e seleções nacionais na to build an even brighter future. are so proud to represent. brilhante. vertente feminina representa para nós um sinal do próprio desenvolvimento do País que tão After the Women’s National Team has ensured, The participation in the European Championship was Depois da Seleção Nacional feminina ter orgulhosamente representamos. for the first time in the centenary history of the thus a gift we were for a long time trying to offer to assegurado, pela primeira vez na história FPF, the participation in the final round of the our fans. -

Empresarios Fútbol Club. El Fútbol Como Instrumento De Afirmación Empresarial
Massimo Mazzoni Empresarios Fútbol Club. El fútbol como instrumento de afirmación empresarial. • MASSIMO MAZZONI Università di Firenze Lo hechos, como escribió Werner Sombart, son como las perlas: precisan de un hilo que los enlace. La reconstrucción histórica de los hechos del pasado nece- sita una idea unificadora, un modelo. Tradicionalmente en Europa, y sobre todo en el continente, si se exceptúa a la escuela histórica de los economistas alema- nes del ochocientos, los historiadores económicos se han demostrado menos equipados a nivel teórico que sus colegas anglosajones. El método europeo-con- tinental de hacer historia económica sin prestar la debida atención a las exigen- cias de un subyacente modelo y sin explicitar la teoría utilizada, ha estimulado Inglaterra, Escocia y, sobre todo, Estados Unidos, a tratar el problema de la reconstrucción histórica de manera diametralmente opuesta: a partir de los años sesenta, los estudiosos anglosajones han empezado a abordar los temas de histo- ria económica a partir de un nuevo planteamiento, en el que la premisa de cada estudio es la formulación inicial, en forma algebraico-geométrica, del modelo teórico explicativo adoptado. Objetivo de la reconstrucción de los hechos es el de averiguar la validez de este modelo a partir de documentos principalmente de tipo estadístico. Este planteamiento ha puesto de manifiesto las deficiencias teó- rico-económicas de la historiografía económica tradicional del continente euro- peo, pero, al mismo tiempo, ha acabado por ir demasiado lejos. Los modelos económicos, con su esprit de géométrie, amenazan con deformar la experiencia 1. Cipolla (2005), pp. 85-110. Fecha de recepción: junio de 2006 Versión definitiva: febrero de 2007 Revista de Historia Industrial N.º 34. -
La Torretta», Giunto Alla Sua Trentaseiesima Edizione
PATROCINATO DA: Comitato Olimpico Nazionale Italiano PREMIO-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TARGA-PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Consiglio Regionale della Lombardia PREMIO NAZIONALE SPORT-CULTURA-PROFESSIONI-SOLIDARIETA’ IN COLLABORAZIONE ANTENNA3 Comune di Milano Trofeo “ATLETA DELL’Anno” G.L.G.S. Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi INVITO (valido per due persone) 30 novembre 2009 - ore 18 Centro Eventi Campari viale Gramsci 141 - Sesto San Giovanni PREMIO NAZIONALE SPORT-CULTURA-PROFESSIONI-SOLIDARIETA’ Lunedì 30 novembre 2009 alle ore 18 presso il Centro Eventi Campari, viale Gramsci 141 a Sesto San Giovanni, saranno consegnati gli annuali riconoscimenti del Premio Nazionale «La Torretta», giunto alla sua trentaseiesima edizione. Il Premio, presieduto da Bruno Pizzul, si avvale del contributo dell’Amministrazione Comunale e dell’appassionato impegno dei componenti il Comitato Promotore, i quali comprendono prestigiosi nomi di aziende, imprenditori, commercianti e professionisti. Obiettivo del premio non è solo quello di offrire un riconoscimento ai campioni dello sport, ma anche quello di evidenziare il troppo spesso oscuro lavoro di quegli atleti che, pur non praticando una disciplina sportiva popolare, hanno dedicato la loro vita e il loro entusiasmo agli sport minori, nobilitandone il ruolo e favorendone la diffusione. Il «Torretta» non si ferma allo sport perché premia, inoltre, persone che si sono distinte nella cultura, nelle professioni, nella solidarietà, per la qualità, la creatività, la capacità innovativa, l’umanità e il senso civico della loro opera. Anche per questo la manifestazione ha avuto ampi riconoscimenti a tutti i livelli istituzionali, a partire dalla Presidenza della Repubblica. Nell’ambito della manifestazione verrà assegnato il Trofeo «Atleta dell’Anno», in collaborazione con Telelombardia, Antenna 3.