Nobildonne, Monache E Cavaliere Dell'ordine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Geothermal Energy Use, Country Update for Italy
European Geothermal Congress 2019 Den Haag, The Netherlands, 11-14 June 2019 Geothermal Energy Use, Country Update for Italy Adele Manzella1, Davide Serra2, Gabriele Cesari3, Eleonora Bargiacchi1, Maurizio Cei2, Paolo Cerutti3, Paolo Conti1, Geoffrey Giudetti2, Mirco Lupi2, Maurizio Vaccaro1, 1 UGI – Italian Geothermal Union, c/o University of Pisa-DESTEC, Largo Lazzarino 2, 56122 Pisa, Italy 2 Enel Green Power, via Andrea Pisano, 120, 56122 Pisa, Italy 3ANIGHP – National Association of Geothermal Heat Pump, via Quintino Sella 23, 00187, Roma, Italy [email protected] Keywords: Electricity generation, Thermal uses, temperature systems tend to be in tectonically active District heating, Geothermal heat pumps, Thermal regions either in volcanic and intrusive or fault- balneology, Agricultural applications, Fish farming, controlled systems (Santilano et al., 2015 and ref. Industrial processes, Development, Market, Support therein). measures. Electricity from geothermal resources nowadays is ABSTRACT produced in the Tuscany region, central Italy. Many direct applications of geothermal heat are also located This paper presents an overview on the development of in Tuscany, however thermal uses are widespread in the geothermal energy applications in Italy for the year national territory, with district heating systems (DHs) 2018 for both electricity generation and thermal uses. mostly localised in the north and other direct uses and Geothermal power plants are located in Tuscany, in the ground source heat pumps (GSHPs) distributing on a two “historical” areas of Larderello-Travale and Mount much larger territory. Amiata. Thermal energy applications are widespread over the whole Italian territory. To date, Enel Green The first part of this paper (sections 2-5) deals with geo- Power is the only geo-electricity producer in Italy. -

Piano Di Recupero Dei Centri Storici Di: Soianella Soiana La Chientina Casanova
COMUNE DI TERRICCIOLA Provincia di Pisa PIANO DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI DI: SOIANELLA SOIANA LA CHIENTINA CASANOVA (L.R.T. N.1/05-L.N.457/78) DOCUMENTO PRELIMINARE PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. Art. 22, L.R. n. 10/2010 e s.m.i. Novembre 2012 IL Tecnico Il proponente Dott. Geol. Roberta Giorgi Funzionario Responsabile Settore Tecnico Geom. Adriano Bassi INDICE 1. PREMESSA ......................................................................................................................................................1 1.1. Il Documento Preliminare procedura di verifica di assoggettabilità nell’ambito del processo di VAS............................. 1 1.2. Il Piano di Recupero dei Centri Storici.............................................................................................................................. 3 1.3. Obiettivi e contenuti del Piano di Recupero...................................................................................................................... 6 2. INQUADRAMENTO URBANISTICO INFLUENZA SU ALTRI PIANI E PROGRAMMI .........................8 2.1. Il sistema normativo sovraordinato ................................................................................................................................... 9 2.2. Il sistema dei vincoli ....................................................................................................................................................... 12 3. LE INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE DI SUPPORTO AL PIANO ATTUATIVO .............................12 -

Tuscany Hidden Gems: 5 Villages You Must Visit in the Valdera Region by Laura | Updated February 20, 2020
V I S I T V A L Novembre 2019 D E R A Ass. Sete Sóis Sete Luas BLOGGER ALLA SCOPERTA DELLA VALDERA Novembre 2019 TRAVELERS UNIVERSE CON( Italia UN) VIAGGIO NELLA TESTA Laura e Ciprian (Valencia, Spagna) Chiara Carolei (Milano) Originari della Romania, vivono in Spagna da anni, a Con un viaggio nella testa è il blog dedicata ai viaggi Valencia. L’apparente atmosfera fredda che traspare curato da Chiara Carolei, giornalista, fotografa, dal quasi anonimato dei bloggers è in realtà la viaggiare e scrivere sono sempre stati gli ingredienti giusta condizione neutrale per meravigliarsi ogni fondamentali della sua vita. Dopo una carriera da volta. Attraverso foto talvolta dal sapore vintage, giornalista di cronaca e di fotografa di matrimoni, altre domestico e altre ancora classico o fiabesco, l’amore per la scoperta del mondo e la scrittura la entriamo nel mondo ‘’di’’ Laura e Ciprian che, con un inglese impeccabile, danno portano, in modo “naturale” (come lo definisce lei) a creare nel 2014 il suo blog suggerimenti di ordine pratico, inserendo nei loro articoli links utili per l’acquisto personale. Si è specializzata in “destination wedding”, ovvero matrimoni di di biglietti, tours a piedi, giornalieri e notturni, trasporti pubblici, prenotazioni e persone che vengono a sposarsi in Italia dall’estero e questo gli ha permesso di quant’altro si abbia necessità di sapere prima e durante il viaggio. Insomma, un viaggiare in tutta Italia, senza abbandonare i viaggi in Europa e le collaborazioni mix equilibrato e sommessamente elegante di praticità ed incanto.I mercatini di con enti del turismo, alberghi, tour operator, ristoranti e brand importanti. -

Colle Salvetti, Collesalvetti - Tora - Valletta
Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana (E. Repetti) http://193.205.4.99/repetti/ Colle Salvetti, Collesalvetti - Tora - Valletta ID: 1557 N. scheda: 17570 Volume: 1; 5; 6S Pagina: 770 - 774; 537, 673; 79 ______________________________________Riferimenti: 46290, 47310 Toponimo IGM: Colle Salvetti - Torrente Tora (a O) Comune: COLLESALVETTI Provincia: LI Quadrante IGM: 112-4 Coordinate (long., lat.) Gauss Boaga: 1619220, 4827418 WGS 1984: 10.47771, 43.59176 ______________________________________ UTM (32N): 619284, 4827592 Denominazione: Colle Salvetti, Collesalvetti - Tora - Valletta Popolo: SS. Quirico e Giulitta a Colle Salvetti Piviere: (S. Jacopo a Vicarello) SS. Quirico e Giulitta a Colle Salvetti Comunità: (Fauglia) Collesalvetti Giurisdizione: Livorno Diocesi: Pisa Compartimento: Pisa Stato: Granducato di Toscana ______________________________________ COLLE SALVETTI ( Collis Salvecti ) in Val di Tora. VilIaggio capoluogo di una moderna Comunità e pieve (SS. Quirico e Giulitta) anticamente nel pievanato di S. Jacopo a Vicarello, e nella Comunità di Fauglia, ora nella Giurisdizione e Governo di Livorno, Diocesi e Compartimento di Pisa. Risiede presso l'antica via Emilia, o R. maremmana, alla destra del fiume Tora e alla sinistra di un altro piccolo fiumicello denominato lsola , sopra un basso e agevolissimo colle che costituisce l'ultima pro-pagine occidentale delle Colline inferio-ri Pisane prossime a quelle di Nugola e delle Parrane, le quali stendonsi verso settentrione dai Monti livornesi. Cosicchè Colle Salvetti trovasi allo sbocco della gran pianura del Delta pisano, da dove si gode di uno spazioso orizzonte che dal lato di ponente gli presenta la vista del mare, nel quale l'occhio si spazia fino al di là del promontorio di Luni, mentre verso terraferma servono di cornice alla visuale i monti dell'alpe Apuana, I'Appennino di Lucca, di Pescia e di Pistoja Trovasi ncl gr. -

Stagione Sportiva 2015 2016 BU N° 38 Del 28/04
UISP – Lega Calcio Valdera tel 0587-55594 – Fax=058755347 Stagione Sportiva 2015_2016 B.U. N° 38 del 28/04/2016 Sommario: . CALCIO A 11 Eccellenza – Promozione A – Promozione B – 1° Livello A – 1° Livello B STATUTO NAZIONALE UISP TITOLO I IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI Articolo 1 SCOPI E FINALITA' L'UISP è l'Associazione di tutte lre persone che vogliono essere protagoniste del fenomeno sportivo attra- verso la pratica diretta, competitiva e non ,la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'orga- nizzazione di eventi. L'UISP è un Associazione Nazionale che realizza scopi e finalità attraverso le proprie sedi territoriali. L'UISP sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione,contro la pratica del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana di non violenza e solidarietà, tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi. Riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza, come risorsa per l'integrazione la UISP s'impegna alla promozione e alla diffusione- nello sport e attraverso lo sport, nella vita sociale-di una cultura dei diritti, dell'ambiente e della solidarietà. L'UISP non persegue fini di lucro in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti ECCELLENZA Risultati ECCELLENZA - GIRONE Giorn Squadre Ris Rit 12 ROMITO - ARCI PERIGNANO 0 - 0 Rit 12 G.S. SAN DONATO - ASD VICOPISANO 1 - 0 Rit 12 AC MISERICORDIA BUTI - CASTELFRANCO 2 - 2 Rit 12 POL. GATTO VERDE - FC MONTOPOLESE 1 - 3 Rit 12 ASD MONTEFOSCOLI CALCIO - BELLAVISTA 2 - 1 Rit 12 RINASCITA PONSACCO - 4 STRADE BIENTINA 1 - 2 Rit 12 ASD CASTELFRANCO DI SOTTO - AMT TERRICCIOLA 3 - 1 Rit 12 ASD BAR BALDINI - EUROCOLLE 0 - 0 Squadra P.Ti G V N P RF RS DR CD Pen ROMITO 40 27 16 8 3 52 25 27 79 0 POL. -

Anagrafe Delle Societa' Della Delegazione Provinciale Di
ANAGRAFE DELLE SOCIETA’ DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 TEL.:050/26021-050/40938 FAX.:050/7912129 1 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- *** POL. A.BELLANI A.S.D. Matr.750137 2 Categoria - Girone:E Indirizzo - VIA S.JACOPO, 121 56123 PISA Tel.Sede-050/560093 Fax-050/560093 E-Mail:[email protected] Invio corrispond. c/o - SEDE Campo di giuoco - *V. BRONZINI* Tel.-050/560093 Indirizzo - VIA S.JACOPO, 121 PISA Colori sociali - ROSSOBLU Riserva - NERO Presidente - GUIDI FLAVIO Tel.abit-050/552814 Tel.Cell-335/7631576 Dirig.ch.urg. – POSSENTI MAURIZIO Tel.abit-050/28041 Tel.Cell-339/6672019 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- *** A.S.D. ACCIAIOLO CALCIO Matr.920748 3 cat. D.P. Livorno - Girone:A Indirizzo - VIA MARCONI, 4/A 56043 ACCIAIOLO FAUGLIA PI Tel.Sede-050/650831 Fax-050/650305 E-Mail:[email protected] Invio corrispond. c/o - SEDE Campo di giuoco - COMUNALE VAL DI TORA Tel.- Indirizzo campo - VIA PROVINCIALE VAL DI TORA ACCIAIOLO FAUGLIA PI Colori sociali - GIALLOBLU Riserva - VARI Presidente - DI GIAMBATTISTA TONINO Tel.abit-050/650831 Tel.Cell-348/2652259 Dirig.ch.urg.– MARTINUCCI DANIELE - BIASCI VALERIO - BETTI BRUNO Tel.Cell-349/4981938 – Tel.Cell-329/4151240 – Tel.Cell-347/5949884 ------------------------------------------------------------------------- -

Piana Livorno-Pisa-Pontedera
piano paesaggistico scheda d’ambito logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito ambito 08 piana livorno-pisa-pontedera Comuni di: Bientina (PI), Buti (PI), Calci (PI), Calcinaia (PI), Capannoli (PI), Capraia Isola (LI), Casciana Terme (PI), Cascina (PI), Chianni (PI), Collesalvetti (LI), Crespina (PI), Fauglia (PI), Lajatico (PI), Lari (PI), Livorno (LI), Lorenzana (PI), Orciano Pisano (PI), Palaia (PI), Peccioli (PI), Pisa (PI), Ponsacco (PI), Pontedera (PI), Rosignano Marittimo (LI), San Giuliano Terme (PI), Santa Luce (PI), Terricciola (PI), Vecchiano (PI), Vicopisano (PI) profilo dell’ambito 1. descrizione interpretativa 2. invarianti strutturali 3. interpretazione di sintesi 4. disciplina d’uso 5. informazioni relative al piano piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito piana livorno-pisa-pontedera Pisa Pontedera Casciana Terme Peccioli Livorno Castiglioncello Profilo dell’ambito 1 p. 3 piana livorno-pisa-pontedera Profilo dell’ambito p. 4 piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito piana livorno-pisa-pontedera L’ambito Piana Livorno-Pisa-Pontedera - i cui confini non si discostano molto da quelli della sezione pisana del bacino idrografico dell’Arno - presenta una strut- tura territoriale ben riconoscibile disegnata dal sistema insediativo storico e dal sistema idrografico. A caratterizzare la porzione settentrionale, la pianura alluvionale del basso Valdarno, con un’agricoltura intensiva, un’elevata urbanizzazione concentrata e diffusa, la presenza di aree umide relittuali e un ricco reticolo idrografico principale (Arno e Ser- chio) e secondario. La pianura si completa verso ovest con l’importante sistema costiero sabbioso del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. La fascia costiera comprende sia le coste sabbiose - tra Livorno e Marina di Torre del Lago e tra Castiglioncello e Cecina, che la costa rocciosa - tra Livorno e Castiglioncello, a cui si aggiungono gli ambienti insulari delle Isole di Capraia e Gorgona. -

Terza Categoria� �
stagione 2014/2015 Terza Categoria Data di inizio: 30-09-2014 Data di fine: 30-09-2014 Gironi Girone B Girone B Data di inizio: 30-09-2014 Data di fine: 30-09-2014 calendario giornata 1 Atletico Santacroce Pisa Sporting Club 1-0 La Cantera II Bellaria Cappuccini 1-2 12-10-2014 Migliarino Futura FC 1-1 15:30 Migliarino Carli Salviano Villamagna 1-3 S. Miniato Latignano 4-2 Sasso Pisano Orlando Calcio 1-1 Vecchiano Garzella Marinese 2-0 giornata 2 Bellaria Cappuccini Carli Salviano 1-2 Futura FC Atletico Santacroce 2-1 Garzella Marinese Sasso Pisano 5-0 Latignano Vecchiano 0-0 Orlando Calcio La Cantera II 2-1 Pisa Sporting Club S. Miniato 1-1 19-10-2014 Villamagna Migliarino 1-2 15:30 Volterra, "Le Ripaie" giornata 3 Atletico Santacroce Villamagna 1-1 La Cantera II Garzella Marinese 1-1 26-10-2014 Migliarino Bellaria Cappuccini 1-2 15:00 Migliarino Carli Salviano Orlando Calcio 2-0 Pisa Sporting Club Futura FC 2-3 Sasso Pisano Latignano 1-4 Vecchiano S. Miniato 5-1 giornata 4 Bellaria Cappuccini Atletico Santacroce 1-2 Garzella Marinese Carli Salviano 2-0 Latignano La Cantera II 3-0 02-11-2014 Orlando Calcio Migliarino 0-1 S. Miniato Sasso Pisano 8-0 Vecchiano Pisa Sporting Club 3-0 Villamagna Futura FC 2-2 giornata 5 Atletico Santacroce Orlando Calcio 3-2 Futura FC Bellaria Cappuccini 1-0 La Cantera II S. Miniato 0-3 09-11-2014 Migliarino Garzella Marinese 2-2 15:00 Migliarino Carli Salviano Latignano 0-1 Pisa Sporting Club Villamagna 0-3 Sasso Pisano Vecchiano 0-6 giornata 6 Bellaria Cappuccini Villamagna 1-3 Garzella Marinese Atletico Santacroce 1-1 16-11-2014 Latignano Migliarino 3-1 14:30 Latignano Orlando Calcio Futura FC 1-2 S. -

CORSE DI ANDATA (Arrivo a Pisa/Cascina)
22/1/2021 RILEVAZIONE TPL - L. ARTISTICO "RUSSOLI" - Pisa - CORSE DI ANDATA (Arrivo a Pisa/Cascina) RILEVAZIONE TPL - L. ARTISTICO "RUSSOLI" - Pisa - CORSE DI ANDATA (Arrivo a Pisa/Cascina) ll presente modulo è stato creato, in accordo con l'Azienda del Trasporto Pubblico Locale e il Prefetto, per rilevare eventuali problematiche sulle linee dei BUS scolastici. Si prega di rispondere in maniera il più precisa possibile alle domande e di prestare attenzione a selezionare correttamente la corsa a cui si riferisce la segnalazione. Il tuo indirizzo email ([email protected]) verrà registrato quando invii questo modulo. Non sei tu? Cambia account *Campo obbligatorio DATA * Data gg/mm/aaaa COGNOME La tua risposta NOME La tua risposta e-mail Nel caso in cui si voglia essere eventualmente contattati La tua risposta https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoDl1wAHA9ExQZYkk9xFtOoxST3BXzfsh80OSPfPn9cWQvAA/viewform 1/5 22/1/2021 RILEVAZIONE TPL - L. ARTISTICO "RUSSOLI" - Pisa - CORSE DI ANDATA (Arrivo a Pisa/Cascina) CLASSE * 1 2 3 4 5 SEZIONE La tua risposta PRENDI L'AUTOBUS SEMPRE LA MATTINA - A VOLTE O MAI PER IL RITORNO A VOLTE O MAI LA MATTINA - SEMPRE PER TORNARE A CASA SIA ANDATA CHE RITORNO Altro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoDl1wAHA9ExQZYkk9xFtOoxST3BXzfsh80OSPfPn9cWQvAA/viewform 2/5 22/1/2021 RILEVAZIONE TPL - L. ARTISTICO "RUSSOLI" - Pisa - CORSE DI ANDATA (Arrivo a Pisa/Cascina) LINEA ARRIVO A PISA/CASCINA * Attenzione a selezionare correttamente la LINEA a cui si riferisce il monitoraggio 80 Vecchiano -

Shaping the Bible in the Reformation Library of the Written Word
Shaping the Bible in the Reformation Library of the Written Word VOLUME 20 The Handpress World Editor-in-Chief Andrew Pettegree University of St Andrews Editorial Board Ann Blair Harvard University Falk Eisermann Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz Angela Nuovo University of Udine Michael F. Suarez, S.J. University of Virginia VOLUME 14 The titles published in this series are listed at brill.nl/lww Shaping the Bible in the Reformation Books, Scholars and Their Readers in the Sixteenth Century Edited by Bruce Gordon Matthew McLean LEIDEN • BOSTON 2012 Cover illustration: Detail from the title page of the 1543 Biblia Sacrosancta, courtesy of the Department of Special Collections, University of St Andrews Library. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Shaping the Bible in the Reformation : books, scholars, and their readers in the sixteenth century / edited by Bruce Gordon, Matthew McLean. p. cm. -- (Library of the written word ; v. 20) (The handpress world ; v. 14) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-22947-1 (hardback : alk. paper) 1. Bible--History--16th century. 2. Bible--Criticism, interpretation, etc.--History--16th century. 3. Bible--History--17th century. 4. Bible--Criticism, interpretation, etc.--History--17th century. I. Gordon, Bruce, 1962- II. McLean, Matthew (Matthew Adam), 1975- BS445.S37 2012 220.09’031--dc23 2012009441 This publication has been typeset in the multilingual "Brill" typeface. With over 5,100 characters covering Latin, IPA, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.nl/brill-typeface. ISSN 1874-4834 ISBN 978 90 04 22947 1 (hardback) ISBN 978 90 04 22950 1 (e-book) Copyright 2012 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. -

Elenco Degli Edifici Monumentali
MISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ELENCO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI X X X III Provincia di Pisa ROMA TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE Via Federico Cesi, 45 1921 AVVERTENZA L'idea di formare un catalogo di tutto il patri monio artistico dello Stato risale assai addietro nel tempo. Già l'imperatore Costantino aveva ordmata una statistica degli edifici e delle opere pubbliche che erano allora nelle quattordici re gioni delle città di Roma, donde risultarono, tra le altre opere, 22 statue equestri, 423 templi con 80 statue d’oro e 77 d’avorio e 1352 fontane. Quattordici secoli più tardi, il 20 aprile 1773, il Consiglio dei Dieci di Venezia comandava che fosse compilato il catalogo generale dei più insigni dipinti esistenti nei confini della Serenissima ; ma questo elenco aveva natura di semplice in ventario, di accertamento della consistenza patri moniale della Repubblica, senza effetti giuridici determinati. Questi invece cominciano ad appa rire connessi col catalogo delle opere d’arte nel l'editto Pacca del 7 aprile 1820, il quale, ordi nando la formazione di un elenco degli oggetti artistici più preziosi dello Stato Pontificio, im poneva alle commissioni preposte alla loro conser vazione di esaminarli « presso qualunque proprie tario e possessore ». Unificate le varie provincie in un solo regno, il concetto di porre il catalogo dei monumenti e delle opere d’arte a fondamento di ogni sanzione — fi legislativa appare in quasi tutti i disegni di legge presentati all’esame del Parlamento. Non com preso nel progetto Coppino del 31 maggio 1887, vi fu introdotto dalla Commissione parlamentare che volle la formazione di un unico catalogo degli immobili. -
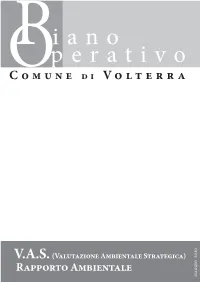
C Omune D I Volterra
iano Pperativo OC omune di Volterra V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) Rapporto Ambientale maggio 2020 maggio luglio 2017 luglio iano perativo Pperativo OC omune di Volterra Il Sindaco: Giacomo Santi L'assessore al Governo del Territorio: Roberto Castiglia Il Responsabile del Procedimento: arch. Alessandro Bonsignori Il Garante della Comunicazione: geom. Vinicio Ceccarelli Progettazione urbanistica: responsabile incaricato: arch. Antonio Mugnai arch. Roberta Ciccarelli Aspetti geologici : geol. Emilio Pistilli Aspetti idraulici: ing. Jacopo Taccini Studio sulle barriere architettoniche: arch. Laura Tavanti collaboratori: ing. Silvia Bertocci GEOPROGETTI Studio Associato V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) Rapporto Ambientale Rapporto Ambientale maggio 2020 maggio luglio 2017 luglio 2017 luglio Indice PREMESSA .................................................................................................................................. 5 1. IL PROCEDIMENTO DI VAS .................................................................................................... 7 1.1. Le fasi del processo di VAS 7 1.2. Individuazione delle competenze amministrative 8 1.3. Soggetti con Competenze Ambientali 9 2. OBIETTIVI E CONTENUTI PRINCIPALI DEL PIANO OPERATIVO .............................................. 11 2.1. Obiettivi generali del Piano Operativo 11 3. RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI ....................................................................... 20 3.1. La verifica di