OBLIO V, 17 112 Simone Rebora AA.VV. Non Dimenticarsi Di Proust
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
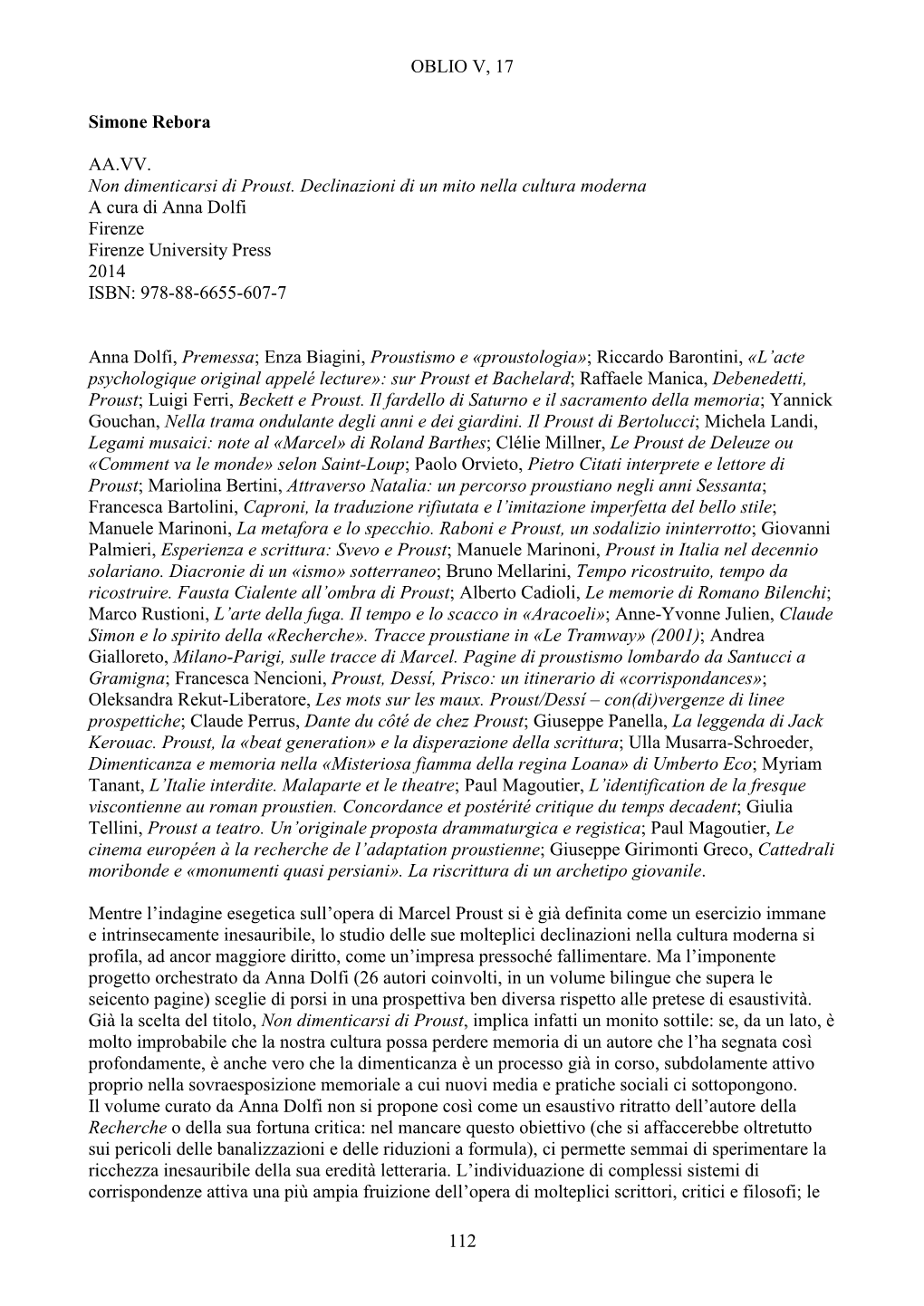
Load more
Recommended publications
-

Narrare Il Novecento Il Romanzo Di Fausta Cialente
Francesca Rubini Narrare il Novecento Il romanzo di Fausta Cialente Dottorato di Ricerca in Scienze Documentarie, Linguistiche e Letterarie XXIX ciclo Dottorato di ricerca in Scienze Documentarie, Linguistiche e Letterarie COORDINATORE Prof. Alberto Petrucciani Curriculum in Studi di genere XXIX ciclo NARRARE IL NOVECENTO. IL ROMANZO DI FAUSTA CIALENTE DOTTORANDA TUTOR Dott.ssa Francesca Rubini Prof.ssa Laura Di Nicola Prof.ssa Marina Zancan Narrare il Novecento. Il romanzo di Fausta Cialente INTRODUZIONE Parte prima. Una biografia intellettuale I Gli esordi difficili. Anni Venti e Trenta 10 I.1 Nel segno di Bontempelli. Natalia (1930) e il Premio dei Dieci 16 I.2 Cortile a Cleopatra (1936). Le vicende del manoscritto e la prima edizione 27 II La Resistenza e il lungo dopoguerra. Anni Quaranta-Sessanta 35 II.1 Scritture di guerra (1941-1947) 46 II.2 Il secondo tempo di Cortile a Cleopatra (1953) 58 II.3 Il ritorno del romanzo. Da Ballata levantina (1961) a Un inverno freddissimo (1966) 64 III Il riconoscimento. Anni Settanta e Ottanta 90 III.1 Una scrittrice mondadoriana. Il vento sulla sabbia (1972) e le riedizioni di Mondadori 97 III.2 «Non sono mai stata tanto celebre». Il 1976, l'anno stregato 107 III.2.1 Camilla (1976). Storia di uno sceneggiato 108 III.2.2 Le quattro ragazze Wieselberger (1976) e il Premio Strega 129 III.3 Scritture, riscritture, traduzioni. Gli anni Ottanta 139 Parte seconda. Le forme del romanzo I Il romanzo di formazione 154 I.1 Natalia. Scrittura e invenzione dell'io 155 I.1.1 Struttura 157 I.1.2 Tematiche e contenuti. -

Facoltà Di Lettere E Filosofia Dipartimento Di Studi Greco-Latini, Italiani, Scenico-Musicali
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DIPARTIMENTO DI STUDI GRECO-LATINI, ITALIANI, SCENICO-MUSICALI DOTTORATO DI RICERCA IN ITALIANISTICA TESI DI DOTTORATO CICLO XXII IL REALISMO NELL’OPERA DI DOMENICO REA: SPACCANAPOLI, RITRATTO DI MAGGIO, QUEL CHE VIDE CUMMEO E UNA VAMPATA DI ROSSORE RELATORE CANDIDATO Prof. Francesco Muzzioli Sayyid Kotb Amin Kotb CORRELATORE Prof. Marcello Carlino ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ANNO ACCADEMICO 2011/2012 - 1 - Il realismo nell’opera di Domenico Rea: Spaccanapoli, Ritratto di maggio, Quel che vide Cummeo e Una vampata di rossore INDICE INTRODUZIONE: REA TRA IL NEOREALISMO E IL MERIDIONALISMO …………… 3 CAPITOLO PRIMO: LA REALTÀ NAPOLETANA E LA SUA SOFFERENZA 1.1- Il mondo plebeo napoletano e il dramma della miseria ………………………... 37 1.1.1- La miseria e la povertà …………………………………………………… 55 1.1.2- Il fatalismo e il riscatto ………………………………………………… 116 1.1.3- Napoli prima e dopo la guerra …………………………………………… 161 1.2- L’emigrazione 1.2.1- Accenni storici …………………………………………………………… 180 1.2.2- Il grande esodo nella letteratura italiana …………………………………. 191 1.2.3- L’emigrazione nei libri di Rea ………………………………………….. 213 1.3- Le strutture sociali ……………………………………………………………….. 230 CAPITOLO SECONDO:TECNICA NARRATIVA 2.1- Uso linguistico particolare Rea dal «notevolissimo» dono verbale alla maturità linguistica ………… 271 2.2- Il personaggio di Rea, «dalla mimesi alla coscienza» ………………………. 370 2.3- L’autobiografismo …………………………………………………………… 422 CONCLUSIONE …………………………………………………………… 458 BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………………… 471 - 2 - - 3 - INTRODUZIONE REA TRA MERIDIONALISMO E NEOREALISMO - 4 - Ho sempre pensato di non essere stato destinato a scrivere cose grandi; e scontento di tutto quanto ho scritto da non avere la forza di rileggerlo; ho creduto nell’ispirazione, che esiste, ma che viene raramente. -

Quarta Edizione Cosenza, Palazzo Arnone 19, 20, 21 Novembre 2015
!"#$%#&'()*)+,-& .+/-,*#0&1#2#**+&3$,+,-&450&670&64&,+8-9:$-&674;& !"##$%&"'()"*+"'' "',-."'/0' <#8)/&=&>$#,?-/?@),)& !"#$%#&'()*)+,-& .+/-,*#&0&1#2#**+&3$,+,-&0&456&786&74&,+9-:;$-&784<& & =#//->,#&?%#:@#& Cronache del Garantista 17 febbraio 2015 Il Manifesto 27 maggio 2015 Cronache del Garantista 7 luglio 2015 Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza 7 luglio 2015 Gazzetta del Sud – ed. Cosenza 10 luglio 2015 Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza 10 luglio 2015 Cronache del Garantista 11 luglio 2015 Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza 18 agosto 2015 Il Crotonese 1 settembre 2015 Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza 2 settembre 2015 Corriere Adriatico – ed. Ascoli 7 settembre 2015 Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza 7 settembre 2015 Il Resto del Carlino – ed. Ascoli 8 settembre 2015 Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza 9 settembre 2015 Libertà di Piacenza 14 settembre 2015 Cronache del Garantista 15 settembre 2015 Cronache del Garantista 22 settembre 2015 Il Crotonese 29 settembre 2015 Cronache del Garantista 20 ottobre 2015 Cronache del Garantista 20 ottobre 2015 Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza 20 ottobre 2015 Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza 24 ottobre 2015 Ansa 24 ottobre 2015 Libero 25 ottobre 2015 Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza 26 ottobre 2015 Gazzetta di Parma 1 novembre 2015 Il Crotonese 5 novembre 2015 Ansa 10 novembre 2015 Cronache del Garantista 11 novembre 2015 Cronache del Garantista – ed. Reggio 11 novembre 2015 Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza 11 novembre 2015 Il Crotonese 12 novembre 2015 Il Quotidiano del Sud – ed. Cosenza 15 novembre 2015 Il Sole 24 Ore – Domenica 15 novembre 2015 La Stampa 16 novembre 2015 Alto Adige 16 novembre 2015 Trentino 16 novembre 2015 Il Quotidiano del Sud – ed. -

Libri Disponibili Con Foto
Books Hunters – Cacciatori di Libri – Libri Disponibili con Foto Per Ordinare scrivete un messaggio sulla pagina Facebook Arcanum Libreria ( https://www.facebook.com/arcanum.shop ) o tramite e-mail: [email protected] Spese di spedizione: https://www.arcanumshop.it/condizioni.html Domande Frequenti (FAQ) : https://www.arcanumshop.it/faq.html Lista: 1.-Sette anni. Autore: Peter Stamm. Edizione: Neri Pozza. Pag: 216. Caratteristiche: Ottime Condizioni.Pagamento: Postepay o Bonifico Bancario.Prezzo: 10,00 € (scontato su prezzo di copertina 16,50) 2.- Quando le stagioni erano verdi per un raggio di sole. Autore: Anna Maria Appicciafuoco. Edizione: iconafx-2009. Pag: 165. Caratteristiche: Dedica dell'autrice nell'anteporta di pagina, ottime condizioni. Pagamento: Postepay o Bonifico Bancario.Prezzo: 10,00 € 3.-Marcellino Gayard. Autore: Leone Frapié. Edizione: Chiolini Editore-Piacenza 1920. Pagine: 316. Caratteristiche: Edizione rara. Condizioni molto buone, copertina rigida su cui è stata applicata la copertina originale. Pagamento:Postepay o Bonifico Bancario.Prezzo:20,00 € 4.-La Rondine Fuggita dal Paradiso. Autore: Hyok Kang. Edizione: Piemme 2007. Pag: 204. Caratteristiche: Prima edizione, ottime condizioni. Pagamento: Postepay o Bonifico Bancario.Prezzo: 8,00 € (scontato su prezzo copertina 12,90) 5.-La Psicologia Degli Animali. Autore: N-Checchia. Edizione: Bocca 1922. Pag: 240. Caratteristiche: Strappo nell'angolo in copertina e piccole mancanze sul dorso, fioriture sparse, all'interno intonso.Pagamento: Postepay o Bonifico Bancario.Prezzo: 15,00 € 6.- Il pesce a mezz'acqua - E' gradito l'abito scuro. Autore: Luca Goldoni. Edizione: Club degli editori 1978. Pagine: 395. Caratteristiche: Buone Condizioni. Pagamento: Postepay o Bonifico Bancario.Prezzo:3,00 € 7.-La Bambina con i sandali bianchi. -

Anna Maria Ortese: a Testimony of Time
ANNA MARIA ORTESE: A TESTIMONY OF TIME Luisa Cordaro A thesis subrnitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of Itaîian Studies University of Toronto O Copyright by Luisa Cordaro 1999 National tibrary BiMÏtheque nationale du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliogmphic Services services bibliographiques 395 Wellington Street 395, rue Weilington OüawaON K1AW OltawaûN K1AON4 Canada Canada The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive licence allowing the exclusive permettant à la National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de reproduce, loan, distriiute or seU reproduire, prêter, distri'buer ou copies of this thesis in rnicroform, vendre des copies de cette thèse sous paper or electronic formats. la forme de microfiche/nlm, de reproduction sur papier ou sur format électronique. The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. thesis nor substantial extracts fiom it Ni la thèse ni des extraits substantiels may be printed or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son permission. autorisation. ABSTRACT OF THE THESIS Anna Maria Ortese: A Testimony of Tirne Doctor of Philosophy 1999 Luisa Cordaro Department of Italian Studies University of Toronto Thesis Director: Professor Rocco Capoui This dissertation is an analysis of Anna Maria Ortese's themes and styliaic evolution. The purpose of this thematic study is to give a stnicture to Ortese's works and to provide unifying categories that reflect three distinct phases in her Iiterary career. -

Naples Crucible of the World
International Conference Naples crucible of the world Italian Cultural Institute, London, 29 October, 2010. Conference Centre, British Library, 30 October, 2010. Organised by Dr. Mariano d’Amora 29 October Italian Cultural Institute 10.00-10.30 Welcome: relazione d’apertura: Mariano d’Amora. 10.30-13.00. Seicento, Settecento. Prof. Michele Rak, Università degli studi di Siena, ‘A dismisura d'uomo. Feste e spettacolo del Barocco a Napoli’. Ordinario dell'Università di Siena Esperto di storia e funzione dell’immagine e di management culturale. Ha realizzato per l’Unione Europea il Virtual Museum of Photography (2003). Per la comunicazione dei beni culturali ha progettato e dirige la rete museale del Museo della Lana di Scanno dedicato all’identità locale (Regione Abruzzo, 1991). Ha realizzato audiovisivi nel settore dei beni culturali e della . Coordinatore del progetto sulla comunicazione radiotelevisiva Rai- Treccani (1989-1990) sul modello dell’accordo tra l’Enciclopedia Britannica e la BBC. Ha progettato e diretto i gruppi di ricerca intitolati (i) Mediateca del Barocco. Ha fondato e dirige l’Osservatorio permanente europeo della lettura (dal 2000), la Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze del testo (S.Chiara. Scuola Superiore dell’Università di Siena) e coordina la Sezione Letteratura, cultura visuale e comunicazione. La relazione segnala le linee di ricerca necessarie per ricostruire la favolosa struttura e la funzione di comunicazione e d’arte della festa barocca a Napoli. Le famiglie, le comunità religiose, i gruppi confezionavano e comunicavano attraverso le feste l'immagine della propria identità. Un’imponente serie di abiti, di armi, di oggetti, di percorsi, di musiche venivano preparati per le parate, gli ingressi trionfali, i compleanni. -

Donazione Prof. Carabello'
Nuovi arrivi - SETTEMBRE 2017 DONAZIONE PROF. CARABELLO’ I maestri del colore collana edita, dalla casa editrice Fratelli Fabbri nel 1963-1967 Giornali, quotidiani, originali, degli anni della seconda guerra mondiale. NARRATIVA, ROMANZI, RACCONTI, POESIE E LETTERATURA L’idiota / Fedor Dostoevskij, Ed. Di Giorgio, 1998 Una difficile eredità / Charlotte Link, TEA, 2009 Profumi perduti / Charlotte Link, TEA, 2011 Teatro completo / Ugo Betti, Cappelli, 1971 Ultima luna / Luce D’Eramo, Mondadori, I fiori blu / Raymond Queneau, La biblioteca di Repubblica, 2003 La bella estate / Cesare Pavese, Mondadori, 1965 Il manoscritto di Brodie / Jorge Luis Borges, La biblioteca di Repubblica, 2002 Una spirale di nebbia / Michele Prisco, Club degli editori, 1970 La spiaggia d’oro / Michele Brignetti, Club degli editori, 1973 Le stelle fredde / Guido Piovene, Club degli editori, 1993 A caso / Tommaso Landolfi, Club degli editori, 1976 La morte del fiume / Guglielmo Petrone, Club degli editori, 1974 Allegri, gioventù / Manlio Cancogni, Club degli editori, 1976 Amicizia / Hermann Hesse, Tascabili Economici Newton, 1992 Vagabondaggio / Hermann Hesse , Tascabili Economici Newton, 1993 L’inquisito / Giorgio Saviane, Tascabili Economici Newton, 1994 La metamorfosi: e nella colonia penale / Franz Kafka, Tascabili Economici Newton, 1992 Ultime lettere di Jacopo Ortis / Ugo Foscolo, Tascabili Economici Newton, 1993 Le ali spezzate / Kahlil Gibran , Tascabili Economici Newton, 1993 La voce del maestro / Kahlil Gibran, Tascabili Economici Newton,1997 Sonetti dell’amore oscuro / Federico Garcia Lorca, Tascabili Economici, Newton, 1992 Molto rumore per nulla / William Shakespeare, Tascabili Economici Newton, 1990 Gli indifferenti / Alberto Moravia , Tascabili Bompiani, 1976 La ciociara / Alberto Moravia, Bompiani, 1976 La crociera / Virginia Woolf, Biblioteca Universale Rizzoli, 1994 Gli anni / Virginia Woolf, Tascabili Economici Newton, 1974 Veronika decide di morire / Paulo Coelho, Bompiani, 1999 La prigioniera / Marcel Proust, Mondadori, 1973 Dietro il velo / Jean P. -

Premio Strega
Anno Vincitore Opera Editore La nave di 2020 Sandro Veronesi Colibrì Teseo 2019 Antonio Scurati M. Il figlio del secolo Bompiani 2018 Helena Janeczek La ragazza con la Leica Guanda 2017 Paolo Cognetti Le otto montagne Einaudi 2016 Edoardo Albinati La scuola cattolica Rizzoli 2015 Nicola Lagioia La ferocia Einaudi 2014 Francesco Piccolo Il desiderio di essere come tutti Einaudi 2013 Walter Siti Resistere non serve a niente Rizzoli 2012 Alessandro Piperno Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi Mondadori 2011 Edoardo Nesi Storia della mia gente Bompiani 2010 Antonio Pennacchi Canale Mussolini Mondadori 2009 Tiziano Scarpa Stabat Mater Einaudi 2008 Paolo Giordano La solitudine dei numeri primi Mondadori 2007 Niccolò Ammaniti Come Dio comanda Mondadori 2006 Sandro Veronesi Caos Calmo Bompiani 2005 Maurizio Maggiani Il viaggiatore notturno Feltrinelli 2004 Ugo Riccarelli Il dolore perfetto Mondadori 2003 Melania Gaia Mazzucco Vita Rizzoli 2002 Margaret Mazzantini Non ti muovere Mondadori 2001 Domenico Starnone Via Gemito Feltrinelli 2000 Ernesto Ferrero N. Einaudi 1999 Dacia Maraini Buio Rizzoli 1998 Enzo Siciliano I bei momenti Mondadori 1997 Claudio Magris Microcosmi Garzanti Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, 1996 Alessandro Barbero Mondadori gentiluomo 1995 Mariateresa Di Lascia Passaggio in ombra Feltrinelli 1994 Giorgio Montefoschi La casa del padre Bompiani 1993 Domenico Rea Ninfa plebea Leonardo 1992 Vincenzo Consolo Nottetempo, casa per casa Mondadori 1991 Paolo Volponi La strada per Roma Einaudi 1990 Sebastiano Vassalli La -
Drawing Elena Ferrante's Profile [Workshop Proceedings, Padova, 7 September 2017]
DRAWING ELENA FERRANTE’S PROFILE Workshop ProceedinGs Padova, 7 September 2017 Edited by Arjuna Tuzzi and Michele A. Cortelazzo UPADOVA P PADOVA UNIVERSITY PRESS 7PMVNFSFBMJ[[BUPDPOJMDPOUSJCVUPEFM%JQBSUJNFOUPEJ'JMPTPGJB 4PDJPMPHJB 1FEBHPHJBF 1TJDPMPHJB"QQMJDBUBEFMM6OJWFSTJU EFHMJ4UVEJEJ1BEPWB Prima edizione anno 2018, Padova University Press Titolo originale Drawing Elena Ferrante's Profle. Workshop Proceedings, Padova, 7 September 2017 © 2018 Padova University Press Università degli Studi di Padova via 8 Febbraio 2, Padova www.padovauniversitypress.it Progeto grafco Padova University Press ISBN 978-88-6938-130-0 Stampato per conto della casa editrice dell’Università di Padova − Padova University Press. Tuti i diriti di traduzione, riproduzione e adatamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche e i microflm) sono riservati. Drawing Elena Ferrante's Profle Workshop Proceedings Padova, 7 September 2017 Edited by Arjuna Tuzzi and Michele A. Cortelazzo Table of contents Mirco Degli Esposti Foreword 7 Arjuna Tuzzi, Michele A. Cortelazzo It Takes Many Hands to Draw Elena Ferrante’s Profle 9 Maciej Eder Elena Ferrante: A Virtual Author 31 Patrick Juola Tesaurus-Based Semantic Similarity Judgments: A New Approach to Authorial Similarity? 47 Margherita Lalli, Francesca Tria and Vitorio Loreto Data-Compression Approach to Authorship Atribution 61 George K. Mikros Blended Authorship Atribution: Unmasking Elena Ferrante Combining Diferent Author Profling Methods 85 Pierre Ratinaud Te Brilliant Friend(s) of Elena Ferrante: A Lexicometrical Comparison between Elena Ferrante’s Books and 39 Contemporary Italian Writers 97 Jan Rybicki Partners in Life, Partners in Crime? 111 Jacques Savoy Elena Ferrante Unmasked 123 Rocco Coronato, Luca Zuliani Aferword 143 Foreword Te case of the bestselling Italian author Elena Ferrante is a famous literary mystery much debated in many parts of the world. -

Gli Anni Cinquanta a Napoli: Andirivieni Letterari.*
Gli anni Cinquanta a Napoli: andirivieni letterari.* 1. C’era stata una Napoli frenetica e loquace, pronta allo scambio promiscuo e plurimo, capace di comunicare saltando a piè pari i problemi delle lingue, lesta nello riscoprire l’arte del meticciato. C’erano molti americani, in questa Napoli; e seppure la città, durante quattro storiche giornate, avesse dato prova di saper reagire ai soprusi e alla vessazioni, senza di loro, senza i “liberatori”, non si sarebbe avventurata nel dopoguerra e non sarebbe entrata nei lunghi anni Cinquanta. Fu la prensile e frenetica immaginazione di Domenico Rea a fermare quella Napoli, chissà se vera o inventata da lui, in Breve storia del contrabbando, uno dei racconti che diedero vita a Gesù, fate luce. A seguire le sue parole, quelli dal ’43 al ’47 furono “anni felici, diventati materia di sogno”: “Alle quattro del mattino, Napoli sembrava San Paolo del Brasile. Carrettieri, cocchieri, falegnami, tappezzieri, imbianchini, pittori, calzolai, dolcieri, fattucchiere, vivevano tutti”, e “Americani e napoletani eran diventati cittadini della stessa nazione”. Ma ben presto, quasi ad annunciare l’arrivo degli anni Cinquanta, all’euforia contrabbandesca subentrò “un’ossea delusione”, e amaramente, eccolo, di nuovo, “il lugubre passato di sempre di Napoli che il sole fa veder in rilievo”. Quelli che avevano partecipato al clima di quegli anni, “ridiscero nelle tane; ma con una coscienza e uno spirito diversi, col tanfo della sporcizia del vicolo sull’anima e sotto il peso di una colonna d’ingiustizia piantata in mezzo al loro dissonante cuore. E, per giunta, senza poeti”. * Nous publions cet article, déjà paru dans "la Rivista dei libri", édition italienne de "The New York Review of Books", n° 10, octobre 2001, avec l'aimable auorisation de Silvio Perrella, que nous tenons ici à remercier. -
Scarica L'e-Book in Formato .Pdf
bibliografica | due 1 2 Aldo Lo Presti VIVERE DENTRO LA LETTERATURA Per una bibliografia per immagini di Leone Piccioni Postfazione di Nino Alfiero Petreni Un pittore di Orvieto in India CENTRO STUDI3 PIENTINI Sardegna. Rassegna di turismo,4 arte, spettacolo e sport | 1958 VIVERE DENTRO LA LETTERATURA. PER UNA BIBLIOGRAFIA PER IMMAGINI DI LEONE PICCIONI Credo che la mia generazione sia stata l’ultima ad avere buone ragioni per nutrirsi, forse, appagarsi, vivere dentro o intorno alla letteratura. L. Piccioni In questo primo tentativo di rubricare gli scritti di Leone Piccioni, si sottolinea che sono state registrate soltanto le opere originali1 del critico torinese (compresi gli estratti), contrasse- gnate da un asterisco a precedere la data di pubblicazione, non- ché i libri curati, presentati o testimoniati da Piccioni, ad esclu- sione, pertanto, dei suoi articoli, con alcune – peraltro corpose - eccezioni;2 sono state esplicitate, inoltre, tra parentesi quadre, tutte le dichiarazioni di autorità, di curatela ed ogni altra infor- mazione bibliografica utile a individuare ogni singola voce nel “Servizio Bibliotecario Nazionale” o nei siti specializzati nella compravendita di libri oppure nei sempre più residuali catalo- ghi a stampa delle librerie antiquarie. Sono stati presi in considerazione, infine, sia alcuni “fasci- coli” di periodici per il loro carattere - quasi - “monografico”, sia i volumi che raccolgono la “corrispondenza” picciana. E 1 Si utilizza la medesima definizione adottata da Edmondo Cione nell’“avvertenza” alla Bi- bliografia crociana edita in prima edizione dalla casa editrice milanese Fratelli Bocca nel 1956, p. [71]. 2 Mancano, tra gli altri, anche i contributi che Leone Piccioni ha firmato per “L'Approdo” nella versione radiofonica settimanale confluiti nei fascicoli ciclostilati prodotti ad uso re- dazionale come il Ricordo di Cavafy di Giuseppe Ungaretti andato in onda nella puntata di lunedì 7 gennaio 1957 (Sede di Firenze, Sezione Programmi) pubblicato nel fascicolo n. -

Il Romanzo Italiano Nel Mito Di Proust (E Nel Mancato Mito Di Svevo). Rifl Essioni a Margine Di Non Dimenticarsi Di Proust, a Cura Di Anna Dolfi (FUP 2014, Pp
LEA - Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente, vol. 3 (2014), pp. 461-477 DOI: http://dx.doi.org/10.13128/LEA-1824-484x-15204 Il romanzo italiano nel mito di Proust (e nel mancato mito di Svevo). Rifl essioni a margine di Non dimenticarsi di Proust, a cura di Anna Dolfi (FUP 2014, pp. 603) Recensione di Giuseppe Girimonti Greco Università degli Studi di Milano (<[email protected]>) Ezio Sinigaglia Scrittore (<[email protected]>) 1. Introduzione Il bel volume curato da Anna Dolfi per la Firenze University Press, Non dimenticarsi di Proust. Declinazioni di un mito nella cultura moderna (2014), può soddisfare, com’è lecito aspettarsi da un libro di questa mole – che racco- glie una trentina di contributi accomunati da un tema così aff ascinante, e il cui solo, prezioso “Indice dei nomi” occupa un intero sedicesimo –, le curio- sità più svariate: proustismo e “proustologia” (Enza Biagini), Proust letto da Beckett (Luigi Ferri) e dalla critica francese militante (Riccardo Barontini su Bachelard, Michela Landi su Barthes, Clélie Millner su Deleuze), Proust e la critica italiana (Raff aele Manica su Debenedetti, Paolo Orvieto su Citati, Ma- nuele Marinoni sul gruppo solariano), l’infl uenza di Proust sulla poesia italia- na (Yannick Gouchan su Bertolucci e Francesca Bartolini su Caproni), sulla narrativa francese (Anne-Yvonne Julien su Claude Simon) e statunitense (Giu- seppe Panella su Kerouac), la presenza di Dante in Proust (Claude Perrus), le riduzioni teatrali e cinematografi che dellaRecherche , cui è dedicata un’ampia sezione (Myriam Tanant su Malaparte, Paul Magoutier su Visconti e altri epi- sodi della fortuna cinematografi ca europea di Proust, Giulia Tellini sull’adat- tamento teatrale di Sandro Lombardi e Federico Tiezzi).