IV. Le Stele Etrusche Dell'alta Valdelsa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
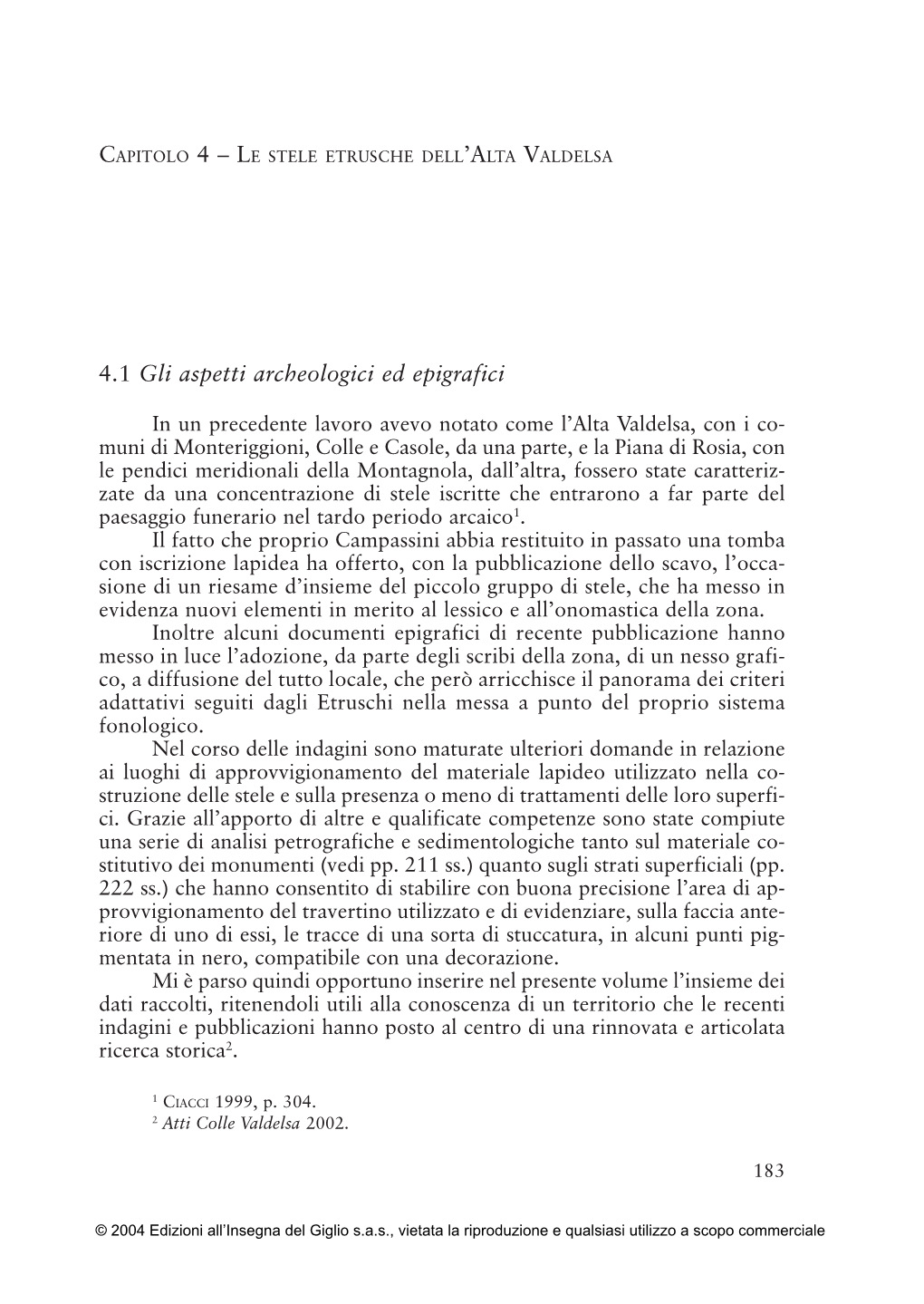
Load more
Recommended publications
-

Guida-Inventario Dell'archivio Di Stato
MINIS TERO PER I BENI CULTURALI E AM BIENTALI PU B BLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO XCII ARCHIVIO DI STATO DI SIENA GUIDA-INVENTARIO DELL'ARCHIVIO DI STATO VOLUME TERZO ROMA 1977 SOMMARIO Pag. Prefazione VII Archivio Notarile l Vicariati 77 Feudi 93 Archivi privati 105 Bandini Policarpo 106 Bologna-Buonsignori-Placidi 108 Borghesi 140 Brancadori 111 Brichieri-Colombi 113 Busacca Raffaele 115 Canonica (la) 116 Nerazzini Cesare 118 Pannocchieschi-D'Elci 120 Petrucci 140 Piccolomini-Clementini 123 Piccolomini-Clementini-Adami 128 Piccolomini-Naldi-Bandini 131 Piccolomini (Consorteria) 134 Sergardi-Biringucci 137 Spannocchi 141 Tolomei 143 Useppi 146 Venturi-Gallerani 148 Particolari 151 Famiglie senesi 152 Famiglie forestiere 161 PR EFAZIONE Nella introduzione al primo volume della guida-inventario dell'Archivio di Stato di Siena furono esposti gli intenti con i quali ci si accinse alla pub blicazione di quell'importante mezzo di corredo che consistevano nel valorizzare il materiale documentario di ciascun fo ndo archivistico per facilitare agli stu diosi la via della ricerca storica. Il caloroso e benevolo accoglimento riservato dagli interessati dice chiaramente quanto fe lice sia stata l'iniziativa e quanto brillanti siano stati i risultati raggiunti, che si sono palesati anche maggiori di quelli previsti. Infa tti la valorizzazione del materiale, oltre all'ordinamento ed alla inventariazione degli atti, presupponeva anche lo studio accurato delle ori gini e delle competenze dell'ufficio o dell'ente che quegli atti aveva prodotto. Per cui, essendo stati illustrati nei primi due volumi 1 ottanta fondi appartenenti alle più importanti magistrature dello Stato, insieme alla storia di ogni singolo ufficio è emersa in breve sintesi anche la storia del popolo senese. -

Popolazione Delle Frazioni Geografiche E Delle Località Abitate Dei Comuni (20 Faseicoli 1'Egionali E Una Appenrliee Con Le Tavole Riassuntive) Voi
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 11° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 24 OTTOBRE 1971 VOLUME III POPOLAZIONE DELLE, FRAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE LOCALITA ABITATE, DEI COMUNI FASCICOLO 9 TOSCANA ROMA - 1974 06 74 - Contratto del 20-12-1972 - (c. 1.400) - Soc. A.B E.T.E. - Roma INDICE AVVERTENZE . Pago V PROVINCIA DI MASSA-CARRARA TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ......................... » 2 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate . » 3 PROVINCIA DI LUCCA TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ......................... » 12 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate ..... » 13 PROVINCIA DI PISTOIA TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ......................... » 30 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate ... .. » 31 PROVINCIA DI FIRENZE TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata ...... ................. » 38 TAVOLA 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate .... » 39 ì 1 t IV i lNDICE I ! I I PROVINCIA DI LIVORNO TAVOLA 1 - Superficie territoliale e jdensità - Numero delle frazioni geografiche, dei centri e ~ei nuclei - Popolazione residente per tipo di località abitata .1... !. Pago 56 I TAVOLA 2 - Altitudine e pop~~~zio~e iresidente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle locahta ablt,te . -

Il Bilancio Di Mandato 2004-2009 Comune Di Colle Di Val D'elsa
Bilancio di mandato 2004-2009 Il Bilancio di mandato 2004-2009 Comune di Colle di Val d’Elsa Sintesi 1 Bilancio di mandato 2004-2009 Presentazione del Sindaco 2 Bilancio di mandato 2004-2009 Finalità e Obiettivi che hanno ispirato la redazione del Bilancio di Mandato del Comune di Colle di Val d’Elsa. Il Comune di Colle di Val D’Elsa ha scelto di realizzare un Bilancio di mandato al fine di rendere il conto alla collettività amministrata sui risultati contenuti rispetto a quanto previsto. In altre parole, tale documento è visto come uno strumento di rendicontazione trasparente, comprensibile ed attendibile sui principali risultati conseguiti dall’Amministrazione nell’arco del periodo di mandato 2004-2009 rispetto ai valori, programmi ed obiettivi dichiarati ad inizio dello stesso. La decisione di redigere un Bilancio di Mandato, documento non obbligatorio per legge, risponde a due esigenze fortemente avvertite dall’Ente. La prima, essenzialmente politica, è quella di rispondere ad una crescente richiesta di accountability da parte della collettività amministrata, basata sull’assunzione da parte dell’Ente di precisi impegni nei confronti della propria comunità di riferimento, la quale richiede strumenti di feed-back informativo, sulla base dei quali valutare l’utilizzo che gli organi politici hanno fatto della delega di potere loro affidata e delle risorse poste a loro disposizione. La seconda esigenza è di tipo amministrativo, ovvero fornire agli organi politici uno strumento gestionale strategico di verifica dell’allineamento tra valori e programmi dichiarati ad inizio del mandato e la loro traduzione in azioni e risultati, nonché una base di partenza per la definizione delle politiche di sviluppo dei prossimi anni, in modo da poter eventualmente “modificare la rotta” ed apportare adeguati correttivi alle strategie o ai programmi in cui esse trovano attuazione. -

Sovicille Delle Meraviglie
Sovicille delle Meraviglie BARONTOLI Secondo la leggenda, nel luogo dove oggi sorge la CHIESA DI SAN PIETRO A BARONTOLI, c'era un tempio romano sacro al dio Fauno; in epoca cristiana, il tempio sarebbe stato poi dedicato a San Pietro. In realtà la prima attestazione di Barontoli e della sua chiesa risale al 730, anno in cui i Longobardi fondarono l'Abbazia di Sant'Eugenio a Siena e la dotarono di beni e possessi tra cui la chiesa di San Pietro. Oggi, della struttura romanica rimangono solo tracce del muro in filaretto, mentre la chiesa, così come ci è pervenuta, sostanzialmente risale al 1700 con alcuni rifacimenti realizzati nel secolo successivo. Del castello di Barontoli, attestato nel 1400, non è rimasta traccia, mentre è pervenuta una villa del 1700, posta di fronte alla chiesa. CAPPELLA DI SANTA CATERINA A SAN ROCCO A PILLI La presenza di Santa Caterina nel territorio di Pilli Caterina purtroppo attraversava frequenti momenti di particolare debolezza e malessere fisico, accusava dei forti dolori ai fianchi, per cui la cognata Lisa Colombini, moglie di Bartolo Benincasa, fratello di Caterina, la invita a trascorrere periodi di riposo in campagna, presso la casa che lei possedeva nel territorio di Pilli con l’attiguo podere che Lisa stessa aveva portato in dote per il suo matrimonio con Bartolo. Nel testo “Santa Caterina da Siena e i suoi compagni” (Augusta Teodosia Drane, Siena 1911, pag. 262) si dice che Caterina trovava giovamento fisico dopo i soggiorni a San Rocco, ospite nella villa della cognata. Anche il letterato senese Girolamo Gigli, nel suo noto “Diario”, afferma che la Santa - frequentando di tanto in tanto il Poderetto di Pilli e specialmente la chiesa parrocchiale di Santa Maria - ricevette particolari grazie dal Signore. -

Miniere E Cave Del Comune Di Roccastrada
WALTER SCAPIGLIATI BIBLIOGRAFIA GEOGIACIMENTOLOGICA E STORICO-MINERARIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCASTRADA AGGIORNATO AL GIUGNO 2011 1 MINIERA DI LIGNITE DELL’ACQUANERA (ROCCATEDERIGHI-SASSOFORTINO) AXERIO G., 1868 MINIERE DI LIGNITE PICEA DEL SIGNOR FERRARI-CORBELLI. STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA - INDUSTRIA MINERARIA. RELAZIONI DEGL'INGEGNERI DEL REAL CORPO DELLE MINIERE, pp. 172-183 TIPOGRAFIA TOFANI, Firenze GIACIMENTOLOGIA, GEOLOGIA REGIONALE, ARTE MINERARIA, SISTEMI DI COLTIVAZIONE, STORIA MINERARIA, PRODUZIONE, IMPIEGHI, COMBUSTIBILI FOSSILI, LIGNITE, MINIERE, CASTEANI, RIBOLLA, F.128 IV NO, ACQUANERA, F.120 III SE, COMUNE DI GAVORRANO, COMUNE DI ROCCASTRADA, PROVINCIA DI GROSSETO, TOSCANA BOCCI A., 2000 LE MINIERE DI LIGNITE MAREMMANE DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE. http://utenti.tripod.it/Boccioldmine/ligniti_maremmane.htm, pp. 1-5 BOCCI ADRIO, Gavorrano STORIA MINERARIA, MINIERE, COMBUSTIBILI FOSSILI, LIGNITE, ARTE MINERARIA, SISTEMI DI COLTIVAZIONE, RIBOLLA, CASTEANI, ACQUANERA, MONTEBAMBOLI, BACCINELLO, PRODUZIONE, OCCUPAZIONE, XX SECOLO, 1919-1921, PROVINCIA DI GROSSETO, TOSCANA BOCCI A., 2003 LA MINIERA DI ROCCATEDERIGHI. http://utenti.tripod.it/Boccioldmine/roccatederighi.htm, pp. 1-3 BOCCI ADRIO, Gavorrano GIACIMENTOLOGIA, STORIA MINERARIA, MINIERE, RAME, OFIOLITI, ROCCATEDERIGHI, COMBUSTIBILI FOSSILI, LIGNITE, ACQUANERA, F.120 III SE, COMUNE DI ROCCASTRADA, PROVINCIA DI GROSSETO, TOSCANA BONAZZA R., 1957-1959 PERMESSO DI RICERCA PER LIGNITE “CASA ACQUANERA” (COMUNE DI ROCCASTRADA). RELAZIONE SUL SERVIZIO MINERARIO, ANNO LXVIII, 83, pp. 121-122 CORPO DELLE MINIERE, Roma GIACIMENTOLOGIA, RICERCA MINERARIA, COMBUSTIBILI FOSSILI, MINIERE, LIGNITE, MIOCENE, ACQUANERA, ROCCATEDERIGHI, F.120 III SE, COMUNE DI ROCCASTRADA, PROVINCIA DI GROSSETO, TOSCANA CIPRIANI N., TANELLI G., 1983 RISORSE MINERARIE ED INDUSTRIA ESTRATTIVA IN TOSCANA. NOTE STORICHE ED ECONOMICHE. ATTI E MEMORIE DELL'ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE “LA COLOMBARIA”, 48, pp. -

2Memoconfanno Archeol
“ANNO DELL'ARCHEOLOGIA IN TOSCANA 2015” Mostre, manifestazioni ed eventi già in calendario per il 2015 1 – MOSTRA “POTERE E PATHOS. BRONZI DEL MONDO ELLENISTICO” programmata a Firenze - Palazzo Strozzi dal 14 marzo al 21 giugno 2015, con altra mostra su “Bronzetti antichi delle collezioni Medicee” al museo Archeologico di Firenze, e con itinerario tematico nel territorio toscano. Organizzata da: Fondazione Palazzo Strozzi, J. Paul Getty Museum di Los Angeles e National Gallery of Art di Washington con la collaborazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. Dal 20 marzo al 21 giugno 2015 il Museo Archeologico Nazionale di Firenze ospiterà la mostra Piccoli, grandi bronzi. Capolavori greci, etruschi e romani delle collezioni mediceo-lorenesi. DATE: dal 14 marzo al 21 giugno 2015 . LUOGO: Firenze - Palazzo Strozzi REFERENTE : Riccardo lami responsabile promocomunicazione Fondazione Strozzi tel 055 3917121 [email protected] , 055 2645155 WEB : http://www.palazzostrozzi.org/Sezione.jsp?idSezione=2870 SCHEDA : La mostra illustra, attraverso l’esposizione di eccezionali esempi di sculture bronzee di grandi dimensioni, lo sviluppo dell’arte nell’Età Ellenistica, diffusa dalla Grecia in tutto il Mediterraneo fra il IV ed il I secolo a.C. L’utilizzo del bronzo, grazie alle sue qualità specifiche, permise di raggiungere livelli inediti di dinamismo nelle statue a figura intera e di naturalismo nei ritratti, in cui l’espressione psicologica divenne un marchio stilistico. Grazie alla collaborazione con il J. Paul Getty Museum di Los Angeles, con la National Gallery of Art di Washington e con il contributo di Bank of America, la mostra vede riuniti reperti provenienti dai più importanti musei archeologici internazionali: le statue monumentali di divinità, atleti e condottieri saranno affiancate ai ritratti dei personaggi di potere, insieme a sculture di marmo e di pietra, scelte per il loro rapporto mimetico col bronzo. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus S33 S33 Bellaria Visualizza In Una Pagina Web La linea bus S33 (Bellaria) ha 9 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Bellaria: 19:50 (2) Brenna: 06:55 - 17:45 (3) Piazza Gramsci: 05:00 - 19:15 (4) Rosia: 07:50 - 18:40 (5) Rosia: 14:35 - 18:30 (6) Rosia - Pontaccio: 07:20 - 12:45 (7) Siena - Ferrovia: 06:40 - 14:05 (8) Sovicille - Capolinea: 14:10 - 15:55 (9) Sovicille - Capolinea: 15:02 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus S33 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus S33 Direzione: Bellaria Orari della linea bus S33 47 fermate Orari di partenza verso Bellaria: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 19:50 martedì 19:50 Piazza Gramsci Piazza Antonio Gramsci, Siena mercoledì 19:50 Curtatone giovedì 19:50 15 Viale Curtatone, Siena venerdì 19:50 Veneto sabato 19:50 11 Viale Vittorio Veneto, Siena domenica Non in servizio Fortezza Medicea 49 Viale Vittorio Veneto, Siena Nazario Sauro 3 Via Nazario Sauro, Siena Informazioni sulla linea bus S33 Direzione: Bellaria Terminal Pescaia Fermate: 47 Durata del tragitto: 40 min Pescaia La linea in sintesi: Piazza Gramsci, Curtatone, Strada dei Cappuccini, Siena Veneto, Fortezza Medicea, Nazario Sauro, Terminal Pescaia, Pescaia, Casone, Parcheggio Fagiolone, Casone Colonna San Marco, Bivio Tinello, Le Cannelle, Costafabbri, La Pellegrina, Pian Delle Fornaci, Parcheggio Fagiolone Costalpino, Agazzara, Il Leccio, Casa Bassa, Volte Strada di Pescaia, Siena Basse, Casalpiano, Pian Dei Mori, Bivio Adige, Ruspaglio, Bivio -

Orari E Percorsi Della Linea Bus
Orari e mappe della linea bus S33 S33 Bellaria Visualizza In Una Pagina Web La linea bus S33 (Bellaria) ha 9 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Bellaria: 19:50 (2) Brenna: 06:55 - 13:40 (3) Piazza Gramsci: 05:00 - 19:15 (4) Rosia: 07:50 - 18:40 (5) Rosia - Pontaccio: 12:45 (6) Siena - Ferrovia: 06:40 - 14:05 (7) Sovicille - Capolinea: 13:13 - 15:55 (8) Sovicille - Capolinea: 15:02 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus S33 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus S33 Direzione: Bellaria Orari della linea bus S33 47 fermate Orari di partenza verso Bellaria: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 19:50 martedì 19:50 Piazza Gramsci Piazza Antonio Gramsci, Siena mercoledì 19:50 Curtatone giovedì 19:50 15 Viale Curtatone, Siena venerdì 19:50 Veneto sabato 19:50 11 Viale Vittorio Veneto, Siena domenica Non in servizio Fortezza Medicea 49 Viale Vittorio Veneto, Siena Nazario Sauro 3 Via Nazario Sauro, Siena Informazioni sulla linea bus S33 Direzione: Bellaria Terminal Pescaia Fermate: 47 Durata del tragitto: 40 min Pescaia La linea in sintesi: Piazza Gramsci, Curtatone, Strada dei Cappuccini, Siena Veneto, Fortezza Medicea, Nazario Sauro, Terminal Pescaia, Pescaia, Casone, Parcheggio Fagiolone, Casone Colonna San Marco, Bivio Tinello, Le Cannelle, Costafabbri, La Pellegrina, Pian Delle Fornaci, Parcheggio Fagiolone Costalpino, Agazzara, Il Leccio, Casa Bassa, Volte Strada di Pescaia, Siena Basse, Casalpiano, Pian Dei Mori, Bivio Adige, Ruspaglio, Bivio La Macchia, La Macchia, Macchia, -

REGISTRO Persone Giuridiche .Pdf
NUM. CODICE CODICE COD. FISC. DENOMINAZIONE CODICE FISCALE INDIRIZZO RAPPR. LEGALE REGISTRO COMUNE PROVINCIA RAPPR.LEGALE Ist. Interdiocesano per il sostentanento del clero di Siena-Colle di Val d'Elsa- Via di Città n. 146 Belli Fabio e BLLFNC45C09I726U 92003400527 052032 052 Montalcino e Abbazia territoriale di Siena Nencini Pietro NNCPTR64L31C847W 1 Monteoliveto Maggiore Via Pesanella n. 68 Fondazione Alimondo Ciampi Onlus 94051520487 052023 Ciampi Daniele CMPDNL55T14859L Radda in Chianti " 2 Fraz. Contignano - Mons. Icilio Parr. S. Maria Assunta 052040 " RSSCLI28S25H790W 3 Radicofani Rossi Via San Michele n. Don Sensano Parr. S. Maria della Stella 11 Chianciano 052009 " Carlo 4 Terme Giovannino Ist.Diocesano per il sostentamento del Via Fiorenzuola clero della Diocesi di Montepulciano 704650522 vecchia n. 2 052015 " Marchi Mario 5 Chiusi Montepulciano Via Berardenga n. 29 Villa Chigi - Assoc. Nazion. Città del vino 702220526 052006 Pioli Giampaolo PLIGPL48M17G687W Castelnuovo " 6 Berardenga Via Banchi di Sotto Mancini Fondaz. Monte dei Paschi di Siena 92035830526 052032 n. 34 Siena " Gabriello 7 Via di Città n. 89 Mancini Accademia musicale Chigiana 68580521 052032 PLIGPL48M17G687W 8 Siena " Gabriello Mons. Arcidiocesi di Siena , Colle di val d'Elsa Piazza Duomo n. 6 80009780521 052032 Buoncristiano BNCNTN43T20C527R e Montalcino" Siena " 9 Antonio c.f. Arcidiocesi Loc. Piana - Mons. Rosi Parr. S. Innocenzo a Piana 052003 RSOCLD55B15F676Q 10 80009780521 Buonconvento " Claudio c.f. Arcidiocesi Via Soccini n. 151 Don Poddighe Parrocchia Santi Pietro e Paoli 052003 11 80009780521 Buonconvento " Gianfranco c.f. Arcidiocesi loc. Bibbiano - Mons. Rosi Parrocchia S. Lorenzo Martire 052003 RSOCLD55B15F676Q 12 80009780521 Buonconvento " Claudio c.f. Arcidiocesi Loc Ponte d'Arbia - Mons. -

L'amministrazione Degli Enti Ecclesiastici Nell'arcidiocesi Di Siena
L’aiistrazioe degli enti ecclesiastici ell’Arcidiocesi di Siea Tra teoria e prassi I beni temporali nella Chiesa • La Chiesa è povera • Gli uffici hanno un fine spirituale • I beni hanno una funzione strumentale • Distribuzione equa delle rendite • Collaborazione dei fedeli al sostentamento della Chiesa e alla sue opere Dal Codex del 1983 • Can. 1254 - §1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. • §2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri. Cosa si intende per Chiesa • Can. 1258 - Nei canoni seguenti con il nome di Chiesa s'intende non soltanto la Chiesa universale o la Sede Apostolica, ma anche qualsiasi persona giuridica pubblica nella Chiesa, a meno che non risulti diversamente dal contesto o dalla natura delle cose. Gli enti della Chiesa di Siena • Arcidiocesi (circoscrizione territoriale) • Parrocchie (circoscrizioni territoriali) • Seminari • Rettorie e santuari • Associazioni pubbliche e private di fedeli • Fondazioni e Fabbricerie • Istituti sostentamento del clero • Istituti religiosi Parrocchie DATI DI SINTESI Forania N° Parrocchie N° Poli Pastorali N° Abitanti Siena Centro 27 15 31008 Siena Nord 23 14 41350 Colle di Val d’Elsa – San Gimignano 26 11 31120 Poggibonsi 17 8 30941 Amiata - Montalcino 20 8 22688 Val d'Arbia 14 8 20788 Val di Merse - Maremma 21 6 17156 TOTALE 148 70 195051 Poli pastorali – Siena Centro Forania Polo Pastorale Parrocchie N° Abitanti S. -

Orario Degli Autobus Urbani Di Siena
Linea 001 /A VIA TOZZI - VIA GALLORI - V.TOZZI ID.Corsa 7414 7841 7369 7842 7370 7371 7393 7372 7373 7394 7374 7375 7395 7376 7377 7396 Subconcessionario BY BUS TRA.IN. BY BUS TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. Concessionario BY BUS TRA.IN. BY BUS TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. TRA.IN. Validità/Frequenza ! " ! " ! ! " ! ! " ! ! " ! ! " SIENA PIAZZA GRAMSCI 6:20 6:20 SIENA VIA TOZZI 6:40 6:40 7:10 7:40 7:45 8:10 8:40 8:45 9:10 9:40 9:45 10:10 10:40 10:45 SIENA V.LE XXIV MAGGIO 6:23 6:23 SIENA VIALE VITTORIO VENETO 6:42 6:42 7:12 7:42 7:47 8:12 8:42 8:47 9:12 9:42 9:47 10:12 10:42 10:47 SIENA V.N.SAURO 6:43 6:43 7:13 7:43 7:48 8:13 8:43 8:48 9:13 9:43 9:48 10:13 10:43 10:48 SIENA V.PESCAIA 6:26 6:26 6:44 6:44 7:14 7:44 7:49 8:14 8:44 8:49 9:14 9:44 9:49 10:14 10:44 10:49 SIENA V. DI COLLINELLA 6:28 6:28 6:48 6:48 7:18 7:48 7:53 8:18 8:48 8:53 9:18 9:48 9:53 10:18 10:48 10:53 SIENA POGGIO AL VENTO 6:29 6:29 6:48 6:48 7:18 7:48 7:53 8:18 8:48 8:53 9:18 9:48 9:53 10:18 10:48 10:53 SIENA ST.CAPPUCCINI 6:31 6:31 6:51 6:51 7:21 7:51 7:56 8:21 8:51 8:56 9:21 9:51 9:56 10:21 10:51 10:56 SIENA V.STROZZI 6:55 6:55 7:25 7:55 8:00 8:25 8:55 9:00 9:25 9:55 10:00 10:25 10:55 11:00 SIENA P.DIAVOLI 6:34 6:34 6:57 6:57 7:27 7:57 8:02 8:27 8:57 9:02 9:27 9:57 10:02 10:27 10:57 11:02 SIENA V.LE CAVOUR 6:36 6:36 6:59 6:59 7:29 7:59 8:04 8:29 8:59 9:04 9:29 9:59 10:04 10:29 10:59 11:04 SIENA PORTA CAMOLLIA 6:37 6:37 7:00 7:00 7:30 8:00 8:05 8:30 9:00 9:05 9:30 10:00 10:05 10:30 11:00 11:05 SIENA V LE V.VENETO SIENA V.LE XXIV MAGGIO SIENA V.LE CADORNA. -

Rendiconto Mandato Comune Di Colle 2004-2009 Esecutivo Per Pdf in Bassa.Indd
COSA ABBIAMO COSTRUITO INSIEME IL RENDICONTO DI MANDATO 2004-2009 COSTRUIRE INSIEME CITTÀ DI www.comune.collevaldelsa.it Colle di Val d’Elsa 2 3 COSA ABBIAMO COSTRUITO INSIEME IL RENDICONTO DI MANDATO 2004-2009 Cosa abbiamo costruito insieme Rendiconto 2004-2009 dell’Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa Stampato nel mese di marzo 2009 Coordinamento editoriale e redazionale: Agenzia RobesPierre, Via del Cavallerizzo 1, Siena Progetto grafi co e impaginazione: Milc, Siena Stampa: Progetto Lavoro - Cooperativa sociale Onlus, Poggibonsi (Siena) CITTÀ DI Colle di Val d’Elsa 4 5 INDICE LA CITTÀ PER LO SPORT ..................................................................................49 L’AMMINISTRAZIONE USCENTE ........................ 6 COSA ABBIAMO FATTO .......................................................................................................................................... 49 DALLA “CITTÀ DELLE TUE IDEE” ALLA “CITTÀ IN MOVIMENTO” ......................6 ECONOMIA E SVILUPPO .................................. 52 COLLE DI VAL D’ELSA: LA CITTÀ, LA CITTÀ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE SUE ECCELLENZE .......................53 IL TERRITORIO E I SUOI AMMINISTRATORI ..... 10 COSA ABBIAMO FATTO PER IL SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO: ALCUNI NUMERI SUL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA ...............................11 INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA ......................................................................................................... 53 LA GIUNTA COMUNALE ....................................................................................18