Le Ville Tra Le Vie Casilina E Prenestina
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Perspektiven Der Spolienforschung 2. Zentren Und Konjunkturen Der
Perspektiven der Spolienforschung Stefan Altekamp Carmen Marcks-Jacobs Peter Seiler (eds.) BERLIN STUDIES OF THE ANCIENT WORLD antiker Bauten, Bauteile und Skulpturen ist ein weitverbreite- tes Phänomen der Nachantike. Rom und der Maghreb liefern zahlreiche und vielfältige Beispiele für diese An- eignung materieller Hinterlassenscha en der Antike. Während sich die beiden Regionen seit dem Ausgang der Antike politisch und kulturell sehr unterschiedlich entwickeln, zeigen sie in der praktischen Umsetzung der Wiederverwendung, die zwischenzeitlich quasi- indus trielle Ausmaße annimmt, strukturell ähnliche orga nisatorische, logistische und rechtlich-lenkende Praktiken. An beiden Schauplätzen kann die Antike alternativ als eigene oder fremde Vergangenheit kon- struiert und die Praxis der Wiederverwendung utili- taristischen oder ostentativen Charakter besitzen. 40 · 40 Perspektiven der Spolien- forschung Stefan Altekamp Carmen Marcks-Jacobs Peter Seiler Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Edition Topoi / Exzellenzcluster Topoi der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin Abbildung Umschlag: Straßenkreuzung in Tripolis, Photo: Stefan Altekamp Typographisches Konzept und Einbandgestaltung: Stephan Fiedler Printed and distributed by PRO BUSINESS digital printing Deutschland GmbH, Berlin ISBN ---- URN urn:nbn:de:kobv:- First published Published under Creative Commons Licence CC BY-NC . DE. For the terms of use of the illustrations, please see the reference lists. www.edition-topoi.org INHALT , -, Einleitung — 7 Commerce de Marbre et Remploi dans les Monuments de L’Ifriqiya Médiévale — 15 Reuse and Redistribution of Latin Inscriptions on Stone in Post-Roman North-Africa — 43 Pulcherrima Spolia in the Architecture and Urban Space at Tripoli — 67 Adding a Layer. -

Architectural Spolia and Urban Transformation in Rome from the Fourth to the Thirteenth Century
Patrizio Pensabene Architectural Spolia and Urban Transformation in Rome from the Fourth to the Thirteenth Century Summary This paper is a historical outline of the practice of reuse in Rome between the th and th century AD. It comments on the relevance of the Arch of Constantine and the Basil- ica Lateranensis in creating a tradition of meanings and ways of the reuse. Moreover, the paper focuses on the government’s attitude towards the preservation of ancient edifices in the monumental center of Rome in the first half of the th century AD, although it has been established that the reuse of public edifices only became a normal practice starting in th century Rome. Between the th and th century the city was transformed into set- tlements connected to the principal groups of ruins. Then, with the Carolingian Age, the city achieved a new unity and several new, large-scale churches were created. These con- struction projects required systematic spoliation of existing marble. The city enlarged even more rapidly in the Romanesque period with the construction of a large basilica for which marble had to be sought in the periphery of the ancient city. At that time there existed a highly developed organization for spoliating and reworking ancient marble: the Cos- matesque Workshop. Keywords: Re-use; Rome; Arch of Constantine; Basilica Lateranensis; urban transforma- tion. Dieser Artikel bietet eine Übersicht über den Einsatz von Spolien in Rom zwischen dem . und dem . Jahrhundert n. Chr. Er zeigt auf, wie mit dem Konstantinsbogen und der Ba- silica Lateranensis eine Tradition von Bedeutungsbezügen und Strategien der Spolienver- wendung begründet wurde. -

Presentazione Di Powerpoint
LA CICLOVIA DI ROMA GRAB 20 LUGLIO 2020 Alessandro Fuschiotto Il GRAB: un anello “a pedali” di 45 km che toccherà i luoghi più significativi di Roma dal centro alla periferia. Il tracciato, a vocazione turistico-culturale, passerà lungo il Colosseo, le Terme di Caracalla, via Appia Antica, la Riserva Naturale dell’Aniene, Villa Ada, Villa Borghese, Via Guido Reni, viale Angelico, Via Lepanto, Via Giulia, il Ghetto, il Campidoglio e Via dei Fori imperiali. Il tracciato del GRAB persegue le finalità richieste: • massima connessione della Ciclovia alla rete ciclabile esistente ed in corso di progettazione al fine rendere la nuova infrastruttura parte integrante del sistema della mobilità urbana; • massima attenzione all’intermodalità eventualmente anche con la realizzazione di servizi dedicati quali ciclostazioni; • massima attenzione alla capacità di innescare processi e progetti di riqualificazione (macroprogetti) delle parti urbane interessate dal passaggio della ciclovia. Ciclovia Turistica Urbana di Roma Il progetto per la prima Ciclovia di Roma prevede la realizzazione di un anello ciclabile ad alta accessibilità. Si tratta di un’infrastruttura complessa finalizzata non solo alla valorizzazione dell’offerta turistica ma anche all’aumento dell’accessibilità urbana ampliata, e alla diffusione di modalità di spostamento più sostenibili e salutari, anche di scala locale. Il progetto di Ciclovia si differenzia da quello di semplice pista ciclabile perchè il suo tracciato dialoga con la città che attraversa, avviando processi di valorizzazione e riqualificazione degli spazi fisici della città oggi trascurati, abbandonati, degradati. Spazi di eccellenza e funzioni urbane quotidiane sono intercettati e messi in rete dalla Ciclovia anche grazie alla massima interconnessione che il tracciato ha con le altre infrastrutture della «mobilità dolce» - piste ciclabili, esistenti e di progetto - e la rete di TPL, con particolare riferimento a quella su ferro. -

Roma Sposa La Bici: 8 Ecco L'anello! 3 Un Progetto
15 16 14 17 19 18 13 20 12 11 21 10 24 23 22 1 9 2 ROMA SPOSA LA BICI: 8 ECCO L'ANELLO! 3 UN PROGETTO Il GRAB, il Grande Raccordo Anulare delle Bici, è la ciclovia 7 IN COLLABORAZIONE CON urbana più bella del mondo e insieme un viaggio di scoperta, un moderno Grand Tour che da una strada di 2300 5 anni fa - l’Appia Antica - arriva alle architetture contemporanee del 6 MAXXI di Zaha Hadid e alla street art del Quadraro e di Torpignattara 4 unendo tra loro Colosseo e acquedotti secolari, San Pietro e Castel Sant’Angelo, Galleria Borghese, Pincio e Auditorium, ville storiche, parchi e paesaggi agrari eccezionali e inaspettati, i percorsi fluviali di Tevere, Aniene e Almone. La realizzazione del GRAB, resa possibile dalla legge di stabilità, porta inoltre con sé la completa pedonalizzazione del museo a cielo aperto dell’Appia Antica, stimola processi di trasformazione e PARTNER TECNICO rigenerazione urbana nelle periferie, spinge Roma a diventare bike friendly. Roma sposa la bici: ecco l’anello! Un raccordo anulare delle bici che deve per forza partire dalla grandiosa arena che ospitava i combattimenti dei gladiatori, il cuore della città e il simbolo dell’Urbe nel mondo. In pochi colpi di pedale si passa da un’emozione all’altra, prima accarezzando IN SELLA, il Colosseo, poi sfiorando la via Sacra e l’Arco di Costantino, infine costeggiando uno dei 7 colli di Roma - il Palatino- spazio verde disseminato SI PARTE! di rovine evocative. Secondo la leggenda è il luogo dove tutto ebbe inizio, dove Romolo uccise il gemello Remo e fondò la città nel 753 a.C. -
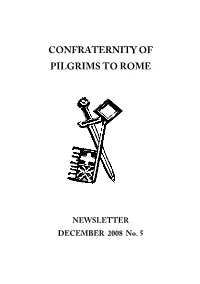
December Newsletter Issue 5
CONFRATERNITY OF PILGRIMS TO ROME NEWSLETTER DECEMBER 2008 No. 5 Contents 1 Editorial Alison Raju Chris George 2 Postcards from a Pilgrimage John and Wendy Beecher 7 Rome for the modern pilgrim, 3: Constantine’s building programme Howard Nelson 27 Camino de Santiago / Cammino per Roma: a comparison Alison Raju 30 Bourg St. Pierre to the Grand Saint-Bernard summit with Homo Viator Babette Gallard 32 Letter to the Editor Francis Davey 33 Letter to VF friends, Summer 2008 International Via Francigena Association 36 Additions to the CPR Library, July to October 2008 Howard Nelson 38 Secretary's Notebook Bronwyn Marques Confraternity of Pilgrims to Rome Founded November 2006 www.pilgrimstorome.org Chairman William Marques [email protected] Webmaster Ann Milner [email protected] Treasurer Alison Payne [email protected] Newsletter Alison Raju <[email protected] Chris George < [email protected] Secretary Bronwyn Marques [email protected] Company Secretary Ian Brodrick [email protected] AIVF Liason Joe Patterson [email protected] Editorial This is the fifth issue of the Confraternity of Pilgrims to Rome's Newsletter. For technical reasons it was not possible to publish it in December 2008 as scheduled but this delayed issue is exactly as it would have been had it appeared on time. There are four articles, two letters, a listing of new additions to the CPR library and the section entitled “Secretary's Notebook,” containing short items of information likely to be of interest to our members. John and Wendy Beecher have written a set of “postcards” of their pilgrimage, after which Howard Nelson continues his series of articles exploring the extraordinary richness that Rome presents to the modern pilgrim, with the third one dealing with Constantine’s building programme. -

2009 Sustainability Report
2009 ACEA SUSTAINABILITY 2009 REPORT ACEA SUSTAINABILITY Corporate Identity Socio-economic Relations Environmental Issues Company Fact Sheets 2009 SUSTAINABILITY REPORT with Stakeholders Italy-Overseas Corporate Identity • Socio-economic Relations with Stakeholders Group Profile GRI Economic and Social GRI Environmental Performance Fact Sheets Concerning Key Group Performance Indicators Indicators Companies Environmental Issues • Environmental Accounts (attached on CD Rom) Strategy and Sustainability Customers and the Community Corporate Governance Environmental Sustainability in the and Management Systems Suppliers Group: Management Systems Acea SpA piazzale Ostiense,2 - 00154 Rome and Biodiversity Stakeholders and Sharing Human Resources tel +39 06 57991 Energy Added Value Shareholders and Financial Backers fax +39 06 57994146 Water Institutions and the Company www.acea.it Rational Use of Resources www.ambientandoci.it Emissions and Waste [email protected] Air Quality in Rome Research Environmental Accounts (attached on CD Rom) Copdefinitivaingl:Cop Ident Az 01/04/11 16:23 Pagina 1 2009 ACEA SUSTAINABILITY 2009 REPORT ACEA SUSTAINABILITY Corporate Identity Socio-economic Relations Environmental Issues Company Fact Sheets 2009 SUSTAINABILITY REPORT with Stakeholders Italy-Overseas Corporate Identity • Socio-economic Relations with Stakeholders Group Profile GRI Economic and Social GRI Environmental Performance Fact Sheets Concerning Key Group Performance Indicators Indicators Companies Environmental Issues • Environmental Accounts (attached -

The Buildings of the Emperor Maxentius on the Via Appia, Rome Author: Lorraine Kerr Pages: 24–33
Paper Information: Title: A Topography of Death: the Buildings of the Emperor Maxentius on the Via Appia, Rome Author: Lorraine Kerr Pages: 24–33 DOI: http://doi.org/10.16995/TRAC2001_24_33 Publication Date: 05 April 2002 Volume Information: Carruthers, M., van Driel-Murray, C., Gardner, A., Lucas, J., Revell, L., and Swift, E. (eds.) (2002) TRAC 2001: Proceedings of the Eleventh Annual Theoretical Roman Archaeology Conference, Glasgow 2001. Oxford: Oxbow Books Copyright and Hardcopy Editions: The following paper was originally published in print format by Oxbow Books for TRAC. Hard copy editions of this volume may still be available, and can be purchased direct from Oxbow at http://www.oxbowbooks.com. TRAC has now made this paper available as Open Access through an agreement with the publisher. Copyright remains with TRAC and the individual author(s), and all use or quotation of this paper and/or its contents must be acknowledged. This paper was released in digital Open Access format in April 2013. A Topography of Death: the buildings of the emperor Maxentius on the Via Appia, Rome Lorraine Kerr Introduction It has often been noted that the circus of Maxentius, part of a complex of buildings erected by that emperor on the Via Appia beh-veen AD 306-12, is curiously positioned relative to contemporary and pre-existing structures. This feature, and the generally cramped nature of the site, is usually explained in terms of restrictions imposed by the natural topography of the area (e.g., D' Alessio 1998: 17; Ioppolo 1999: 45-46).1 However, a recent visit to the complex suggested that the orientation of the circus was not controlled exclusively by topographic factors, but also by the location of an important pre-existing tomb built in the immediate area, which is here argued to have been purposely integrated into the Maxentian architectural scheme. -

Festival Internazionale Dell'ambiente
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE PROGRAMMA Eventi permanenti del Festival h. 09.00 – 19.00 Anno 2050, quale energia? Centrale Montemartini, Via Ostiense 106 Nell'ambito dell'iniziativa ON OFF dell’ENEA, una mostra interattiva per capire l’energia e saperne di più sull’ambiente Dal 25 settembre al 18 ottobre (chiuso il lunedì) Ingresso compreso nel prezzo del biglietto del Museo A cura di ENEA h. 09.30 – 19.00 Ambiente e Territorio del IX Municipio al Parco della Caffarella e di Torre del Fiscale Ingresso da Largo Tacchi Venturi e da vicolo dell’Acquedotto Felice Dal 25 al 27 settembre spettacoli, mostre, percorsi culturali e ludici, visite guidate e laboratori Ingresso libero, Info 06 7803710, 328 1623639, 333 6891754, Demetra Onlus A cura dal Municipio IX h. 09.00 – 18.00 Ecomotori – Mobilità ecologica Piazzale di Ponte Milvio Dal 26 al 27 settembre area dimostrativa ed espositiva di automobili e veicoli a basso impatto ambientale Ingresso libero Info 328 4232156, www.ecomotori.net A cura del Municipio XX h. 09.00 – 19.00 Ambiente in III Municipio Piazza Bologna, Parco dei Galli, Castro Laurenziano, Villa Mercede Dal 25 al 28 settembre dibattiti, visite guidate, laboratori per bambini e spettacoli teatrali. Ingresso libero. Info 06 69603218 A cura del Municipio III h. 9.30 – 18.30 Come investire sull’ambiente Area verde di Via Rosa Raimondi Garibaldi Dal 25 al 27 settembre pulizia straordinaria dell’area, avvio dell’iniziativa Baratto e Riuso tra i cittadini, presentazione dell’Orto in casa, dibattiti e incontri. Ingresso libero. Info 06 69611202 A cura del Municipio XI e del Circolo Garbatella di Legambiente h. -

PRENESTINO Creating Connections: Reclaiming Lost Space and Reinforcing Social Bonds
PRENESTINO Creating Connections: Reclaiming Lost Space and Reinforcing Social Bonds Maddie Collins | Eli Learner | Helena Park | Joseph Reigle 2 Prenestino Preface Acknowledgements We want to acknowledge the vital guidance of our instructors Professor Nancy Brooks, Professor Greg Smith and Marco Gissara PhD., all of whom helped to contextualize our observations within local and contemporary academic perspectives. Additionally, we extend our gratitude to the individuals who were willing to speak to us for our interviews--Silvano and the bocce club members, Astro Nascente, Giulia Barra, Debora, Cristiana, Sabrina, Enzo, Marco, and Allesandra. 3 Table of Contents 1. Introduction 5 2. Overview 6 3. Historical Background 9 4. Methodology 14 5. Demographic Analysis 16 6. Physical Analysis 31 7. Community Engagement 45 8. Assessment and Recommendations 47 9. Bibliography 64 10. Appendix 65 4 Prenestino Introduction to Prenestino Introduction Our neighborhood study of Prenestino was conducted under the video call by Professor Greg Smith or our Teaching Assistant Marco Cornell in Rome Workshop course during the Spring 2020 semester. Gissara who could speak to residents in Italian and then translate Our class consisted of eight undergraduate students who were their notes into English for us. Additionally, we compensated for the separated into two groups of four to conduct separate neighborhood brief time we spent in the neighborhood itself through reflexive analyses. The neighborhood study is designed to provide students exercises such as cognitive mapping as well through virtual tools with opportunities for experiential and reflexive learning.1 Our such as Google Maps. This summary of our unique learning learning process went through stages of on the ground observations experience hopefully communicates the unavoidable limitations of in the neighborhood, statistical and policy analysis, interviews with our study. -

Municipio I PIAZZA DEL FANTE PORTA SAN SEBASTIANO VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA (Parco Della Resistenza) LARGO CHIARINI PIAZZA PADRE
Municipio I PIAZZA DEL FANTE PORTA SAN SEBASTIANO VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA (Parco della Resistenza) LARGO CHIARINI PIAZZA PADRE DEGLI STROZZI CASTEL SANT'ANGELO VIA DEL QUIRINALE - V.PIACENZA (Villa Sant'Andrea) COLLE OPPIO PIAZZA VITTORIO VIA CARLO FELICE VIA GALVANI VIA GOMENIZZA (Villa Gomenizza) VIA TOMMASO GULLI VIA MARCELLO PRESTINARI VIA SABOTINO-VIA PLAVA-VIA MONTENERO-VIA MONTESANTO PARCO CELIO PIAZZA REMURIA PIAZZA SANTA MARIA LIBERATRICE PIAZZA SAN COSIMATO VILLA SCIARRA PIAZZA DANTE PIAZZALE AMMIRAGLIO BERGAMINI VILLA CELIMONTANA VIA CAPO PRATI VIA C. GALVANI PIAZZA DELLE FINANZE VIA PARCO DELLA VITTORIA (Parco della Vittoria) VIA MARMORATA VIA DI PORTA LATINA (Parco degli Scipioni) VIA SILVIO PELLICO PARCO MONTE MARIO Municipio II VIA ANTRODOCO/VIA SOMALIA (Villa Chigi fronte strada) LAGO PICCOLO (Villa Ada) PIAZZA MASSA CARRARA VIA MASCAGNI 134 VIA DEI PICENI (Parco dei Galli) VIA NEMORENSE/VIA MOCCALE (Villa Leopardi) VIA PANAMA (Parco Rabin) VIA PRATO DELLA SIGNORA-VIA SALVIUCCI VIA GERMANIA-VIA XVII OLIMPIADE VILLA NARDUCCI VIA B. AMMANNATI (Villa Balestra) VILL ADA parte alta (pineta) VILLA PAGANINI VIA TIBURTINA (Parco Caduti 19 Luglio) VIA PINCIANA (Villa Borghese - 3 di 4) PARCO DEI DAINI (Villa Borghese - 2 di 4) VIA NEMORENSE (Parco Nemorense) VIA ESCULAPIO - MADAMA LETIZIA (Villa Borghese - 1 di 4 - Laghetto) VIALE TIZIANO/PIAZZALE MANILA VIA DI VILLA GRAZIOLI (Villa Grazioli) VIALE PARIOLI (Villa Glori 2) VIA MASCAGNI seconda area PIAZZA MANCINI LAGO GRANDE (Villa Ada) VIALE PARIOLI (Villa Glori 1) VIA NOMENTANA -

Download PDF Datastream
Network Culture in Italy in the 1990s and the Making of a Place for Art and Activism By Valeria Federici Ph. D., Brown University, 2019 Dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree in Doctor of Philosophy in the Department of Italian Studies at Brown University PROVIDENCE, RHODE ISLAND MAY 2019 © Copyright 2019 by Valeria Federici This dissertation by Valeria Federici is accepted in its present form by the Department of Italian Studies as satisfying the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Date___________ ____________________________ Prof. Massimo Riva, Advisor Recommended to the Graduate Council Date___________ ____________________________ Evelyn Lincoln, Reader Date___________ ____________________________ Courtney J. Martin, Reader Approved by the Graduate Council Date___________ ____________________________ Andrew G. Campbell, Dean of the Graduate School iii Valeria Federici received her PhD in Italian Studies and, while at Brown University, she obtained an MA in History of Art and Architecture through the Open Graduate Education program. Federici had graduated in Letters from the Università Roma Tre in Rome, Italy. In 2015, she co- organized Chiasmi, the Brown-Harvard graduate student conference. In 2016, with the collaboration of the Center for Digital Scholarship at Brown University, she completed a digital interface that investigates the relationships between the Garibaldi Panorama (a painting, two hundred sixty feet in length, which has been digitized at Brown University) -

Roma Caput Hipster
1 Ai Tre scalini 2 Antica Barberia Peppino 3 Auditorium Parco della Musica 4 Baccano 5 Bar Latteria 6 Bar San Calisto 7 Basilica dei Santi Cosma e Damiano 8 Basilica dei Santi Quattro Coronati 9 Basilica di San Clemente ROMA CAPUT 10 Basilica di San Pietro in Vincoli 11 Basilica di Santa Maria del Popolo 12 Bassetti 13 Bir & Fud LA GIUSTINIANA 14 Black Market Monti 15 Caffetteria-bistrot, Chiostro del Bramante 16 Cappella Sistina 17 Centrale Montemartini HIPSTER 18 Checchino dal 1887 19 Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola 20 Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza Cibo e bere Cultura Monumenti Negozi Passeggiate 21 Chiesa di Santa Maria della Concezione 22 Chiesa di Santa Maria della Vittoria 23 Chiesa evengelica metodista 99 TOR SAN GIOVANNI 24 Chiosco Casina Tusculum GROTTAROSSA CASTEL GIUBILEO 25 Cimitero Acattolico di Roma 26 Cinema Greenwich 27 Cinetown Skatepark 28 Clivo di Scauro TOR DI QUINTO CASAL BOCCONE OTTAVIA 29 Cocktail bar, Hotel Majestic 30 Cohouse Pigneto VAL MELAINA 31 Convento di San Francesco a Ripa grande 32 Crypta Balbi 87 33 Da Enzo al 29 34 Da Felice 35 Dal Verme MONTE SACRO SAN BASILIO 36 Dar Filettaro a Santa Barbara ALTO 37 Domus Aurea 38 Ex Cartiera Latina, Parco MONTE SACRO Regionale dell’Appia Antica 39 Ezio Pellicanò 47 PONTE MAMMOLO 40 Fontana delle Tartarughe TRIONFALE 73 92 41 Foro Italico 42 Galleria Nazionale d’Arte Moderna 41 43 Giardino degli Aranci 58 3 PARIOLI 44 Giardino giapponese, Istituto TRIESTE 53 giapponese di cultura FLAMINIO 45 Giuseppe Di Iorio, calzolaio TRIONFALE 57 46 Globe Theatre 56 47 Il chiosco