Di Alcuni Recenti Scrittori
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
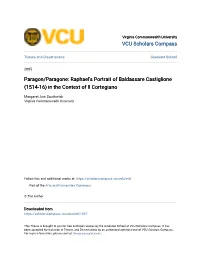
Raphael's Portrait of Baldassare Castiglione (1514-16) in the Context of Il Cortegiano
Virginia Commonwealth University VCU Scholars Compass Theses and Dissertations Graduate School 2005 Paragon/Paragone: Raphael's Portrait of Baldassare Castiglione (1514-16) in the Context of Il Cortegiano Margaret Ann Southwick Virginia Commonwealth University Follow this and additional works at: https://scholarscompass.vcu.edu/etd Part of the Arts and Humanities Commons © The Author Downloaded from https://scholarscompass.vcu.edu/etd/1547 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at VCU Scholars Compass. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of VCU Scholars Compass. For more information, please contact [email protected]. O Margaret Ann Southwick 2005 All Rights Reserved PARAGONIPARAGONE: RAPHAEL'S PORTRAIT OF BALDASSARE CASTIGLIONE (1 5 14-16) IN THE CONTEXT OF IL CORTEGIANO A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts at Virginia Cornmonwealtli University. MARGARET ANN SOUTHWICK M.S.L.S., The Catholic University of America, 1974 B.A., Caldwell College, 1968 Director: Dr. Fredrika Jacobs Professor, Department of Art History Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia December 2005 Acknowledgenients I would like to thank the faculty of the Department of Art History for their encouragement in pursuit of my dream, especially: Dr. Fredrika Jacobs, Director of my thesis, who helped to clarify both my thoughts and my writing; Dr. Michael Schreffler, my reader, in whose classroom I first learned to "do" art history; and, Dr. Eric Garberson, Director of Graduate Studies, who talked me out of writer's block and into action. -

Ministero Per I Beni E Le Attività Culturali E Per Il Turismo Archivio Di Stato Di Genova
http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Archivio di Stato di Genova Instructiones et relationes Inventario n. 11 Regesti a cura di Elena Capra, Giulia Mercuri, Roberta Scordamaglia Genova, settembre 2020, versione 1.1 - 1 - http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DELLE UNITÀ ARCHIVISTICHE Nella richiesta occorre indicare il nome del fondo archivistico e il numero della busta: quello che nell’inventario è riportato in neretto. Ad esempio per consultare 2707 C, 87 1510 marzo 20 Lettere credenziali a Giovanni Battista Lasagna, inviato in Francia. Tipologia documentaria: Lettere credenziali. Autorità da cui l’atto è emanato: Consiglio degli Anziani. Località o ambito di pertinenza: Francia. Persone menzionate: Giovanni Battista Lasagna. occorre richiedere ARCHIVIO SEGRETO 2707 C SUGGERIMENTI PER LA CITAZIONE DELLE UNITÀ ARCHIVISTICHE Nel citare la documentazione di questo fondo, ferme restando le norme adottate nella sede editoriale di destinazione dello scritto, sarà preferibile indicare la denominazione completa dell’istituto di conservazione e del fondo archivistico seguite dal numero della busta, da quello del documento e, se possibile, dall’intitolazione e dalla data. Ad esempio per citare 2707 C, 87 1510 marzo 20 Lettere credenziali a Giovanni Battista Lasagna, inviato in Francia. Tipologia documentaria: Lettere credenziali. Autorità da cui l’atto è emanato: Consiglio degli Anziani. Località o ambito di pertinenza: Francia. Persone menzionate: Giovanni Battista Lasagna. è bene indicare: Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, b. 2707 C, doc. 87 «Lettere credenziali a Giovanni Battista Lasagna, inviato in Francia» del 20 marzo 1510. - 2 - http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it SOMMARIO Nota archivistica p. -

Repertorio Degli Statuti Della Liguria
FONTI PER LA STORIA DELLA LIGURIA XIX Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII) a cura di Rodolfo Savelli REGIONE LIGURIA – ASSESSORATO ALLA CULTURA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA Genova 2003 PRESENTAZIONE ABBREVIAZIONI ACG = Archivio Storico del Comune Genova AEP = Archives du Ministère des Affaires Etrangères Parigi ASA = Archivio storico ingauno Albenga ASF = Archivio di Stato Firenze ASG = Archivio di Stato Genova ASS = Archivio di Stato Savona AST = Archivio di Stato Torino BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana BCB = Biblioteca Civica Berio Genova BDG = Biblioteca Durazzo Genova BEM = Biblioteca Estense Modena BNN = Biblioteca Nazionale Napoli BRT = Biblioteca Reale Torino BSR = Biblioteca del Senato Roma BUG = Biblioteca Universitaria Genova IISL = Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera SASV = Sezione di Archivio di Stato Ventimiglia 1. Il progetto di realizzare un nuovo repertorio degli statuti della Li- guria prese avvio anni or sono, e fu sostenuto dalla Società Ligure di Storia Patria, dall’allora Istituto di Storia del diritto dell’Università di Genova (confluito poi nel Dipartimento di cultura giuridica « Giovanni Tarello »), dall’Accademia « Giovanni Capellini » (La Spezia) e dalla Regione Liguria. Nella fase iniziale vi furono proficui confronti con colleghi delle Università di Milano, Torino, Siena e Messina. Si decise di effettuare il censimento scegliendo come confini di indagine quelli delle Regioni attuali, per evitare sovrapposizioni (visto che il progetto originario prevedeva che i gruppi di ricerca in Liguria, Lombardia e Piemonte procedessero di pari passo); le duplicazioni sarebbero state ineliminabili per quei territori, quali la Lunigia- na o il basso Piemonte, dalla complessa storia civile e istituzionale, che non si identifica con le vicende di uno solo degli stati d’ancien régime 1. -

The Marriage of True Minds
THE MARRIAGE OF TRUE MINDS Of the Rise and Fall of the Idealized Conception of Friendship in the Renaissance Von der Gemeinsamen Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität Hannover zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) genehmigte Dissertation von ROBIN HODGSON, M. A., geboren am 21.06.1969 in Neustadt in Holstein 2003 Referent: Prof. Dr. Gerd Birkner Korreferenten: Prof. Dr. Dirk Hoeges Prof. Dr. Beate Wagner-Hasel Tag der Promotion: 30.10.2003 ABSTRACT (DEUTSCH) Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der Freundschaftsbegriff der Renaissance, der seinen Ursprung wesentlich in der antiken Philosophie hat, seine Darstellungsweisen in der europäischen (insbesondere der englischen und italienischen) Literatur des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts, und der Wandel, dem dieser beim Epochenwechsel zur Aufklärung im siebzehnten Jahrhundert unterworfen war. Meine Arbeit vertritt die Hypothese, dass sich die Konzeptionen der verschiedenen Formen zwischenmenschlicher Beziehung die sich spätestens seit dem achtzehnten Jahrhundert etablieren konnten, auf die konzeptionellen Veränderungen des Freund- schaftsbegriffs und insbesondere auf den Wandel des Begriffsverständnisses von Freundschaft und Liebe während der Renaissance und des sich anschließenden Epochenwechsels zurückführen lassen. Um diese Hypothese zu verifizieren, habe ich daher nach einer kurzen Übersicht über die konzeptionellen Ursprünge des frühneuzeitlichen Freundschaftsbegriffs zunächst das Wesen der primär auf den philosophischen -

The Medieval Genoese Consciousness Between Their Government and Their Colonial World
ANZAI, The Medieval Genoese Consciousness between their Government and their Colonial World The Medieval Genoese Consciousness between their Government and their Colonial World in Romania by the Analysis of a Letter Yoko Kamenaga ANZAI* 1. Introduction Recently the historians of medieval and Renaissance Italy often discuss on the view of “political language” (linguaggi politici) as new tendency of political history, in particular, as a way of analysis of political thought in its broad sense.1 In relation to the Genoese medieval history, Giovanna Petti Balbi described the language of power in the governmental ceremony or celebration.2 And some articles of Christine Shaw belong to this category. For example, she examined the various registers of some Genoese counsels and found the Genoese pragmatism based on the sense of the value of money.3 The subject of this paper treats the relationship between the mother city Genoa and its colonial people in Romania, whose world spreads in the coastal area of the Aegean and of the Black Sea largely. I try to reconsider each action and consciousness of the Genoese government staffs and of the Genoese in their colonial world through the analysis of a letter mainly. The letter has its particular style of phrase. In addition to the background and contents themselve, we would clarify their mentality. 2. The sources The sources that we treat here are L. Balletto ed. Liber Officii Provisionis Romanie.4 Officium Provisionis Romanie is an office of the Genoese Commune in charge of its colonial administration. We can find its existence at least in 1377.5 In relation to the circumstance of * Gakushuin University 1 For example, Andrea Gamberini, Lo stato visconteo: linguaggi politici e dinamiche costituzionali, Milano, 2005. -

Reti Medievali E-Book Monografie 4
Reti Medievali E-Book Monografie 4 Reti Medievali E-book Comitato scientifico Claudio Azzara (Università di Salerno) Pietro Corrao (Università di Palermo) Roberto Delle Donne (Università di Napoli Federico II) Stefano Gasparri (Università di Venezia) Paola Guglielmotti (Università di Genova) Gian Maria Varanini (Università di Verona) Andrea Zorzi (Università degli Studi di Firenze) Giovanna Petti Balbi Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale Firenze University Press 2007 Governare la città : pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale / Giovanna Petti Balbi. – Firenze : Firenze university press, 2007. (Reti Medievali. E-book, Monografie; 4) http://www.storia.unifi.it/_RM/e-book/titoli/PettiBalbi.htm http://digital.casalini.it/9788884536037 ISBN 978-88-8453-603-7 (online) ISBN 978-88-8453-604-4 (print) 945.1804 (ed. 20) Liguria - Medioevo Volume realizzato con il contributo del Prin 2004, Linguaggi e culture politiche nell’Italia del Rinascimento, coordinato da Giuseppe Petralia. Impaginazione: Alberto Pizarro Fernández Editing: Leonardo Raveggi © 2007 Firenze University Press Università degli Studi di Firenze Firenze University Press Borgo Albizi, 28 50122 Firenze, Italy http://epress.unifi.it/ Printed in Italy Indice Introduzione 7 I. Organizzazione familiare 13 1. Strutture familiari nella Liguria medievale 15 2. La vita e la morte: riti e comportamenti in ambito urbano 29 3. I Visconti di Genova: identità e funzioni dei Carmadino (secoli XI-XII) 51 4. I Fieschi: un percorso familiare 83 II. Dinamiche sociali 99 1. Magnati e popolani in area ligure 101 2. L’apogeo della città tra Due e Trecento 127 3. I Gerosolimitani in Liguria in età medievale tra tensioni politiche e compiti istituzionali 145 4. -

Spazi Per La Memoria Storica
SPAZI PER LA MEMORIA STORICA ROMA 2009 Genova, Complesso monumentale di Sant’Ignazio: particolare della loggia di Psiche Genova, Palazzetto criminale PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO SAGGI 93 SPAZI PER LA MEMORIA STORICA La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell’Archivio di Stato Atti del convegno internazionale Genova, 7 - 10 giugno 2004 a cura di ALFONSO ASSINI e PAOLA CAROLI MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2009 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI Servizio III - Studi e ricerca Direttore generale per gli archivi: Luciano Scala Direttore del Servizio III: Patrizia Ferrara Impaginazione: Fausto Amalberti Autorizzazioni alla pubblicazione delle immagini: Accademia Nazionale dei Lincei, Roma Archivio di Stato di Venezia Archivio Storico del Comune di Genova Biblioteca Civica Berio, Genova Biblioteca Nazionale Braidense, Milano British Library, Londra Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova Staatsbibliothek, Berlino © 2009 Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale per gli archivi ISBN 978-88-7125-302-2 Stampato nel mese di novembre 2009 a cura della Tipografia Brigati Glauco & c. s.d.f. – Genova ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA Manifestazioni “Genova capitale della cultura 2004” Convegno internazionale Spazi per la memoria storica La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell’Archivio di Stato Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Complesso monumentale di Sant’Ignazio, -

Cardinal Pietro Bembo and the Formation of Collecting Practices in Venice and Rome in the Early Sixteenth Century
IL COLLEZIONISMO POETICO: CARDINAL PIETRO BEMBO AND THE FORMATION OF COLLECTING PRACTICES IN VENICE AND ROME IN THE EARLY SIXTEENTH CENTURY A Dissertation Submitted to the Temple University Graduate Board In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree DOCTOR OF PHILOSOPHY By Susan Nalezyty January, 2011 Examining Committee Members: Tracy E. Cooper, Advisory Chair, Department of Art History Marcia B. Hall, Department of Art History Elizabeth Bolman, Department of Art History Peter Lukehart, External Member, CASVA, National Gallery of Art i © by Susan Nalezyty 2010 All Rights Reserved ii ABSTRACT Il collezionismo poetico: Cardinal Pietro Bembo and the Formation of Collecting Practices in Venice and Rome in the Early Sixteenth Century Candidate’s Name: Susan Nalezyty Degree: Doctor of Philosophy Temple University, 2011 Doctoral Advisor: Tracy E. Cooper Cardinal Pietro Bembo’s accomplishments as a poet, linguist, philologist, and historian are well known, but his activities as an art collector have been comparatively little studied. In his writing, he directed his attention to the past via texts—Ciceronean Latin and Petrarchan Italian—for their potential to transform present and future ideas. His assembly of antiquities and contemporary art served an intermediary function parallel to his study of texts. In this dissertation I investigate Bembo as an agent of cultural exchange by offering a reconstruction of his art collection and, in so doing, access his thinking in a way not yet accomplished in previous work on this writer. Chapter One offers a historiographic overview of my topic and collecting as a subject of art historical study. Chapter Two maps the competition and overlapping interests of collectors who bought from Bembo’s heirs. -

Andrea Lercari LA NOBILTÀ CIVICA a GENOVA E in LIGURIA DAL
Andrea Lercari LA NOBILTÀ CIVICA A GENOVA E IN LIGURIA DAL COMUNE CONSOLARE ALLA REPUBBLICA ARISTOCRATICA 1 Ogni studioso che si trovi ad affrontare un tema afferente alla storia genovese, sia questo di taglio politico, sia economico, sia ancora storico-artistico o architettonico o urbanistico, deve confron- tarsi con il composito e complesso ceto dirigente che ebbe il control- lo politico e sociale della città dalle origini del Comune, nel XII secolo, a tutta la durata della Repubblica aristocratica, nata nel 1528 e caduta nel 1797. Attraverso un’evoluzione continua e articolata, il gruppo di potere, diviso nelle fazioni cittadine dei guelfi e ghibellini, prima, e dei nobiles e populares, poi, con la riforma costituzionale del 1528 si organizzò in un vero e proprio patriziato sovrano, nel quale confluirono coloro che avevano già acquisito il diritto di parte- cipare all’amministrazione della cosa pubblica. Si era trattato in sostanza di un’operazione di riordino del ceto dirigente cittadino – nel quale erano già riscontrabili tutte le caratteristiche di una vera e propria nobiltà civica – ispirata dalla necessità di porre fine alle lotte di fazione per il controllo della città. 1 Desidero esprimere un sentito ringraziamento per aver favorito la mia partecipazione al convegno Le aristocrazie cittadine. Evoluzione dei ceti dirigenti urbani nei secoli XV-XVIII all’amico Saverio Simi de Burgis, il quale come discendente di una delle famiglie compo- nenti la nobiltà genovese sin dalle sue origini, i Di Negro, condivide l’interesse per le vicen- de del ceto dirigente dell’antica Repubblica di Genova, e a Marino Zorzi e Girolamo Mar- cello del Majno membri del comitato organizzatore del convegno. -

Copertina2011.Pub (Sola Lettura)
Annuario Statistico Edizione 2012 Sistema Statistico Nazionale Direzione Statistica Prefazione L’Annuario Statistico del Comune di Genova, nelle sue 370 pagine, fornisce una fotografia puntuale ed aggiornata della città attraverso un significativo repertorio di informazioni e dati su tematiche di rilievo quali: economia, lavoro, inflazione, cultura, evoluzione demografica, sanità, trasporti, ambiente e giustizia. Un capitolo è dedicato alla Civica Amministrazione con particolare attenzione alle notizie storiche, all’organizzazione, alle rappresentanze politiche ed ai servizi comunali. L’annuario 2012, la cui maggior parte dei dati è relativa all'anno 2011, non solo aggiorna le tavole pubblicate nell’edizione dell’anno precedente, ma presenta anche serie storiche decennali o quinquennali che consentono di seguire nel tempo, anche attraverso la rappresentazione grafica di un andamento, l’evoluzione di determinati fenomeni. L’attuale edizione presenta aspetti innovativi in termini di contenuto: è stata arricchita di nuove sezioni ed ampliata con informazioni relative all’organizzazione comunale, all’attività dei Municipi, all’istruzione universitaria, alla giustizia. Sono state, inoltre, introdotte tavole contenenti nuovi indicatori ambientali e, all’interno del capitolo dedicato all’Economia, è possibile acquisire i dati dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura svoltosi nel 2010. Le note introduttive ai singoli capitoli sono state dotate di una veste grafica colorata, più consona all'utilizzo via web, con titoli laterali che accompagnano -

Simon Boccanegra
Simon Boccanegra Melodramma in un prologo e tre atti Libretto di Francesco Maria Piave e Arrigo Boito Musica di Giuseppe Verdi PERSONAGGI PROLOGO Simon Boccanegra, corsaro al servizio della Repubblica genovese Baritono Jacopo Fiesco, nobile genovese Basso Paolo Albiani, filatore d’oro genovese Basso Pietro, popolano di Genova Baritono Marinai, Popolo, Domestici di Fiesco, ecc. DRAMMA Simon Boccanegra, primo Doge di Genova Baritono Maria Boccanegra, sua figlia, sotto il nome di Amelia Grimaldi Soprano Jacopo Fiesco, sotto il nome di Andrea Basso Gabriele Adorno, gentiluomo genovese Tenore Paolo Albiani, cortigiano favorito del Doge Basso Pietro, altro cortigiano Baritono Un Capitano dei balestrieri Tenore Un’Ancella di Amelia Mezzosoprano Soldati, Marinai, Popolo, Senatori, Corte del Doge, ecc. L'azione è in Genova e sue vicinanze, intorno alla metà del secolo XIV. N.B.: Tra il Prologo ed il Dramma passano 25 anni. Prima rappresentazione assoluta: Venezia, Teatro La Fenice, 12 marzo 1857 Nuova versione con la revisione di Arrigo Boito: Milano, Teatro alla Scala, 24 marzo 1881 (Editore Casa Ricordi, Milano) PROLOGO Simone Io?... no. Una piazza di Genova. Nel fondo la chiesa di San Lorenzo. A destra il Paolo palazzo dei Fieschi, con gran balcone: nel muro, Ti tenta di fianco al balcone, è un’immagine davanti a ducal corona? cui arde un lanternino; a sinistra altre case. Varie strade conducono alla piazza. È notte. Simone Vaneggi? [1. Scena] Paolo (con intenzione) Paolo e Pietro in scena, continuando un E Maria? discorso. Simone Paolo O vittima innocente Che dicesti?... all’onor di primo abate del funesto amor mio!... Dimmi, di lei Lorenzin, l’usuriere?.. -

Quaderni D'italianistica : Revue Officielle De La Société Canadienne
Donatella Baldini The Play of the Courtier: Corre- spondences between Castiglione's // libro del Cortegiano and Shake- speare's Lovers Labouras Lost When Castiglione, in devising the narrative frame of the dialogues in // libro del Cortegiano, chooses to distance himself from the fictional situation he is presenting and places himself in England, on a public visit to King Henry VII, he seems to anticipate figuratively the wide popularity that his work would enjoy among the men of letters and the intellectuals of the Enghsh Renais- sance. Even if this is a coincidence, it is a significant one. Castighone, as both his hfe and writings witness, is aware of the growing cosmopoUtanism of the European courts as hegemonic centers of culture. In // libro del Cortegiano he advocates the development of a transregional courtly culture in Italy - whose first and foremost sign would be a linguistic koinè - beyond the particular dif- ferences characterizing the various municipal habits and ethoi. By extension, such a unifying process is seen to affect culturally, if not politically, the life of the European courts in general, as the repeated references to the habits of non- Italian courts and courtiers, such as the French and the Spanish ones, suggest. Castighone's undeniable awareness of national differences, and his focus on specifically Italian cultural debates such as the so-called questione della lin- gua, must not obscure his consciousness of belonging to an emerging class, tied to the political order of the courts established all over Europe rather than in a specific place.' Castighone's concerns are symbolized in the choice of setting for his Cortegiano, which, as Mazzacurati notices, is "un non-luogo, un pa- lazzo-città sorto da poco tra monti quasi disabitati, senza retroterra urbano, senza caratteri forti di territorio, quasi senza passato" (179).