Bollettino Aprile 2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
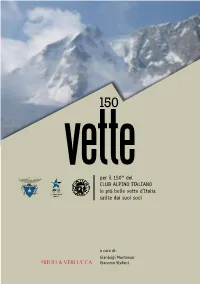
Per Il 150° Del CLUB ALPINO ITALIANO Le Più Belle Vette D'italia
150 vette per il 150° del CLUB ALPINO ITALIANO le più belle vette d’Italia salite dai suoi soci a cura di: Gianluigi Montresor Giacomo Stefani SOMMARIO *Saluto del Presidente del CAI – Umberto Martini pag. xxx *150 vette per 150 anni del CAI – Giacomo Stefani pag. xxx *Coordinare 1.500 “autori” – Gianluigi Montresor pag. xxx *LE 150 VETTE pag. xxx *Tabelle riepilogative e tavole statistiche pag. xxx *Credits e ringraziamenti pag. xxx 20 Grivola Percorrendo la Valle d’Aosta da Villeneuve e poi con una doppia di 10 mt ad un intaglio. A Sarre appaiono, maestose, le magnifiche pareti destra per un diedrino con 1 chiodo, possibile Gruppo/Massiccio nord-est e nord-ovest, purtroppo ormai sempre neve e vetrato, (III+) ci si riporta in cresta. Da Alpi Graie, più povere di ghiaccio. In posizione isolata, ai qui in poi, aggirando eventuali difficoltà sul gruppo del Gran Paradiso sottogruppo della Grivola Quota 3.969 m Latitudine Longitudine 45°35’45”N - 7°15’27”E Regioni italiane interessate Valle d’Aosta Punti d’appoggio *Rifugio Vittorio Sella (2.584) - CAI Biella *Bivacco Gratton (3.198) Società Guide Cogne *Bivacco Balzola (3.477) CAI Torino Cartografia Tavolette 1:25.000 IGM Carta n.2 1:50.000 IGC Bibliografia essenziale GUIDE DEI monti margini settentrionali del gruppo, è un belvedere versante sud-est, raggiungere la cima con passi D’Italia - Gran Paradiso grandioso sulle montagne valdostane. di III. Gli ultimi 100 metri di cresta si possono CAI / TCI evitare (consigliato) ricongiungendosi con la via Cenni di storia alpinistica normale che sale dal versante sud Foto J. -

CAI SETTEMBRE 2018 A.Pdf
CAI SETTEMBRE 2018_cai giugno 06/11/18 11:49 Pagina 1 Il DAV VIsItA Il CAI DI BergAmo PIzzo DI sCotes e refugIos AnDInos h Agosto c D’AustrIA i b o r O i p l A e l Settembre 2018 NoTIzIArIo DeLLA SezIoNe e SoTToSezIoNI CAI DI BergAmo Una casa per la montagna Anno XXIIII n.. 105 // Settttembrre 2018 // Trriimessttrralle // “Posstte IIttalliiane Spa -- Spediiz.. iin Abb.. Posstt.. -- D..L.. 353//2003 ((conv.. IIn L.. 27//02//2004 n.. 46)),, Arrtt.. 1,, Comma 2,, DCB Berrgamo” CAI SETTEMBRE 2018_cai giugno 06/11/18 11:49 Pagina 2 Editoriale Le ALpi OrObiche Emozioni in cammino Notiziario del Club Alpino Italiano Sezione e Sottosezioni di Bergamo SeTTemBre 2018 dei giovani e ragazzi Anno XXII - n° 105 editore Sezione di Bergamo “Antonio Locatelli” del Club Alpino Italiano sulle Orobie (Associazione di Volontariato) Via Pizzo della Presolana 15, 24125 Bergamo Tel. 035-4175475 Fax 035-4175480 Direttore responsabile a stagione estiva in montagna sta terminando, come i rifugi Nevio Oberti alpini preparano la chiusura di porte e griglie, per attendere una Direttore editoriale nuova stagione invernale. Paolo Valoti Nascono spontanei ricordi di attività vissute e esperienze ascol - Comitato di redazione L Nevio Oberti, Luca Merisio, tate tra i sentieri e rifugi delle Orobie, a conferma di una stagione positi - Glauco Del Bianco va e ricca di soddisfazioni per tutti i frequentatori appassionati, trekkers Segretaria: Clelia Marchetti e turisti, italiani e stranieri, grazie anche al lodevole e competente lavo - Hanno collaborato ro dei gestori dei nostri -

Ministero Della Difesa
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP4) NELL'ESERCITO, NELLA MARINA E NELL'AERONAUTICA Archivio quesiti 2ª immissione 2013 Geografia Codice Domanda A B C D 1 Il giorno 27 di agosto, quando nello Sri Lanka sono le ore 9:00, 15:00 23:30 12:30 21:00 alle Barbados sono le… 2 Un Graisano viene da… Grado (GO) Giovo (TN) Gragnano (NA) Gravina di Catania (CT) 3 La capitale del Nepal è… Palikir Ulan Bator Katmandu Kuala Lumpur 4 La moneta in uso in Papua Nuova Guinea (PGK), si chiama… kina kip kwacha kyat 5 Le province del Molise sono… 1 2 3 4 6 Un cittadino del Ciad è un… ciadiano ciadese ciadita ciadense 7 La moneta in uso nel Malawi (MWK), si chiama… kyat kip kina kwacha 8 Il giorno 1 di giugno, quando in Estonia sono le ore 21:00, in 24:00 17:00 12:00 20:00 Albania sono le… 9 Un Opitergino viene da… Oderzo (TV) Opera (MI) Oppido Lucano (PZ) Oppeano (VR) 10 Il Monte Grappa (1.774 m) fa parte delle… Alpi Atesine Alpi Pennine Prealpi Venete Alpi Marittime 11 Un cittadino dell'Honduras è un… hondurese hondurita honduregno hondurino 12 Quale dei seguenti paesi ha il maggior numero di abitanti? Birmania Italia Ucraina Turchia 13 Non confina con l'Eritrea… Etiopia Gibuti Somalia Sudan 14 La distanza in linea d'aria tra New York e Città del Capo è di 12.600 km 15.100 km 17.600 km 18.900 km circa… 15 La sigla della provincia di Rimini è… RM RI RN RR 16 Non confina con il Burkina Faso… Guinea Costa d'Avorio Benin Togo 17 La distanza stradale -

The Alpine Club Library
206 The Alpine Club Library. The entire text of the second edition is revised, rearranged, and rewritten, and the authors have not only simplified the general plan of the guide, but, acting on the advice of the reviewers of the first edition, have added a number of new features, and at the same time have not increased the bulk of the volume. The plan of listing peaks alphabetically within their groups has been retained, and to each peak is added not only the altitude, but the rna p reference number and a key letter indicating its oceanic watershed. It has been considered undesirable to retain the earlier sectional sketch maps, and instead a general key-map has been included. A new feature, noticeably absent from the first edition, is an index of passes with appropriate textual references. A glance at the index of peaks reveals in italics how many mountains in the Rockies are but tenta tively named ; and it is to be hop~ed most emphatically that the decisions of the Geographic Board of Canada, in confirming or revising the suggestions of pioneer mountaineers, will be arrived at with more wisdom and appropriateness, and less regard for passing political fancy, than has been evinced in the recent past. • N. E. 0 . THE ALPINE CLUB LIBRARY. By A. J. MAcKINTOSH. The following works have been added to the Library: • Club Publications . (1) Akad. Alpenclub Bern. 25. · Jahresbericht 1929-30. 9 x 5! : pp. 34 : plates. (2) t\kad. Alpenclub Ziiric~ 34. Jahresbericht. 9 x 6: pp. 43. 1929 (3b) Akad. -

Les Hautes Vallées Du Queyras
Paris Chamonix bulletin des Clubs alpins français d’Ile-de-France // 5 euros // numéro 214 février mars 2012 ski de fond Les hautes vallées du Queyras randonnée pédestre Dans le Far West américain : Bryce Canyon National Park raquette ski de montagne à Autrans Traversée à ski des Alpes Bergamasques www.clubalpin-idf.com ISSN 1269-4339 Paris Chamonix//numéro 214//février mars 2012 Vie du club épauler et à terme les remplacer. Il a aussi Comité directeur pour fixer le moment venu, remercié François Garrouste qui soutient le le montant de la part club de la cotisation Samedi 3 décembre 2011 trésorier en effectuant un travail important 2013 dans une fourchette d’augmentation le Caf IdF a tenu son assemblée en matière de statistiques. de 0 à 3 % par rapport aux tarifs 2012. générale ordinaire annuelle Concernant le site web du club, il a noté le Le secrétaire général a ensuite fait le point de Une quarantaine de personnes se sont sans faute réalisé par les webmasters pour la pratique des activités au cours de l’année retrouvées pour faire le point de la situation l’implémentation d’un système de règlement écoulée et des perspectives pour 2012 : de notre club à la fin de l’exercice 2011 en ligne par carte bancaire des frais d’inscrip- D’une manière générale la plupart des activi- et réfléchir aux axes de développement tion aux sorties. Il a salué particulièrement tés ont enregistré une bonne fréquentation souhaitables. l’implication d’Emmanuel Klein qui a assuré au cours de 2011. Celle-ci aurait pu être meil- L’assemblée a d’abord rendu hommage à les développements techniques. -

L'elenco Delle 150 Cime
Foglio1 CIMA REGIONE ORGANIZZATORE Monte Maggiorasca Liguria CAI Rapallo Monte Saccarello Liguria CAI Sanremo Monte Mongioie Piemonte CAI Albenga Cima del Marguareis Piemonte CAI Mondovì Monte Gelas Piemonte CAI Cuneo Monte Argentera Piemonte CAI Savona Monte Tenibres Piemonte CAI Ligure Rocca Provenzale Piemonte CAI Cuneo Monviso Piemonte CAI Saluzzo + CAAI locale Bric Bucie Piemonte CAI Germanasca Rocciamelone Piemonte CAI Susa Uja Bessanese Piemonte CAI Lanzo Uja di Mondrone Piemonte CAI Ala di Stura Levanna Orientale Piemonte CAI Venaria Becco Meridionale della Tribolazione Piemonte CAI Rivarolo + CAAI locale Punta Fourà Piemonte-Valle d'Aosta CAI Chivasso Torre di Lavina Piemonte CAI Cuorgnè Gran Paradiso Valle d'Aosta CAI Verres Testa del Rutor Valle d'Aosta CAI Aosta Monte Emilius Valle d'Aosta CAI St. Bartlemy Grivola Valle d'Aosta CAAI Aiguilles de Trelatete Valle d'Aosta Monte Bianco Valle d'Aosta CAI UGET Grandes Jorasses Valle d'Aosta CAI Torino + UGET Mont Dolent Valle d'Aosta CAAI Monte Vertosan Valle d'Aosta CAI Aosta Mont Gelè Valle d'Aosta CAI Aosta Monte Roisetta Valle d'Aosta CAI Verres Testa Grigia Valle d'Aosta CAI Gressoney Cervino Valle d'Aosta AGAI Breithorn Occidentale Valle d'Aosta CAI Chatillon Liskamm Occidentale Valle d'Aosta CAI Biella Pagina 1 Foglio1 Punta Dufour Piemonte CAI Varallo Monte Mucrone Piemonte CAI Biella Monte Tagliaferro Piemonte CAI Varallo Pizzo d'Andolla Piemonte CAI Villadossola Blinnenhorn Piemonte CAI Busto A. e Somma Lomb. Mottarone Piemonte CAI Omegna Monte San primo Lombardia CAI -
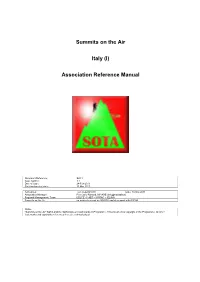
(I) Association Reference Manual
Summits on the Air Italy (I) Association Reference Manual Document Reference: S28.1 Issue number: 1.1 Date of issue: 28-Feb-2011 Participation start date: 15-Mar-2011 Authorized: Tom Read M1EYP Date: 10-Mar-2011 Association Manager: Pier Carlo Riccardi, IW1ARE ([email protected]) Regional Management Team: IZ0LCZ - I1ABT – IK1RAC – IZ2JNN Summits-on-the-Air an original concept by G3WGV and developed with G3CWI Notice “Summits on the Air” SOTA and the SOTA logo are trademarks of Programme. This document is copyright of the Programme. All other trademarks and copyrights referenced here are acknowledged. Association Reference Manual – Italy I Table of contents 1 CHANGE CONTROL 4 2 ASSOCIATION REFERENCE DATA 5 2.1 PROGRAMME DERIVATION ................................................................................................................ 6 2.2 GENERAL INFORMATION ................................................................................................................... 7 2.3 RIGHTS OF WAY AND ACCESS ISSUES ................................................................................................ 7 2.4 MAPS AND NAVIGATION .................................................................................................................... 7 2.5 SAFETY CONSIDERATIONS ................................................................................................................ 8 2.6 FOREIGN HAMS IN ITALY ................................................................................................................. 9 2.7 -

Montagne Scalate Flavio 2018
MONTAGNE SCALATE FLAVIO dicembre 2018 PIEMONTE A. VALSESIA VALSERMENZA 1. Pizzo Tracciora (1917 m) Sci - alpinismo 2. Massa dei Ratei (1930 m) 3. Punta Castello (2095 m) 4. Massa della Sajunca (2314 m) 5. Massa del Castello (2435 m) 6. Cima Colmetta (2458 m) 7. Cima Massero (1696 m) 8. Cima Castello (1985 m) 9. Cima Triola (1934 m) 10. Monte Cervero (2068 m) 11. Colma Bella (2232 m) 12. Cima Lampone (2584 m) 13. Cima del Tiglio (2548 m) Sci - alpinismo 14. Cima Trasinera (2620 m) 15. Orello del Saiunché (2655 m) Sci - alpinismo 16. Pizzo Montevecchio (2789 m) Cresta nord 17. Cima del Soglio (2331 m) 18. Pizzo Quarazzolo (2798 m) 19. Palone del Badile (2675 m) 20. Pizzo della Moriana (2631 m) 21. Pizzo Tignaga (2653 m) Sci - alpinismo 22. Cimone della Loccia (2508 m) 23. Cimonetto (2480 m) 24. Cimone (2453 m) 25. Cima Pianone (2467 m) 26. Colma Masset (1530 m) 27. Cengio del Badile (2132 m) 28. Piccolo Altare (2684 m) 29. Corno Piglimo (2894 m) 30. Punta Piccolo Piglimo (2747 m) 31. Corno Mud (2802 m) 32. Monte Tagliaferro (2964 m) Cresta nord-ovest / cresta nord-est 33. Cima Carnera (2741 m) Cresta nord-est / cresta ovest 34. Cima delle Pisse (2551 m) 35. Oro dell’Asino (1661 m) VAL MASTALLONE 36. Pizzo del Moro (2334 m) 37. I Tre Pizzi (2271 m) 38. Pizzo Nona (2247 m) 39. Corno del Sole (2163 m) 40. Chastal (2242 m) 41. Cima Cresta (2324 m) 42. Monte Mora (2307 m) 43. Cima Capezzone (2421 m) 1 MONTAGNE SCALATE FLAVIO dicembre 2018 44. -

AURONZO DI CADORE (BL) – ANNO XVI N
Semestrale del CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione Cadorina “Luigi Rizzardi” AURONZO DI CADORE (BL) – ANNO XVI n. 32. Dicembre 2015 - Spedizione in A. P. – D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, NE/VE QVOTAQVOTA 864864 QVADERNI DI VITA DI MONTAGNA “Quando arrivi in vetta ad un monte non fermarti, continua a salire” Un Maestro del buddismo Zen ANNO XVI. N. 32. DICEMBRE 2015. Semestrale Registrato presso la Cancelleria del Tribunale di Belluno col n. 15/2000 in data 01.08.2000 Iscritto al Registro Nazionale della Stampa n. 10331 - R.O.C. N. 6944 Spedizione in abbonamento postale - art. 1, comma 1, Legge n. 46/2004 - CMP/CPO Venezia PAOLA DE FILIPPO ROIA Direttore Responsabile GLAUCO GRANATELLI Direttore Editoriale e-mail: [email protected] COMITATO DI REDAZIONE Alberto M. Franco (G.I.S.M.) Mirco Gasparetto (G.I.S.M.), Mario Spinazzè Questo numero esce in collaborazione con l’Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti” di Fermo HANNO COLLABORATO: Borsetto L., Bresciani M., Carrel A., Cattaruzza P.S., Censi C., Chen J. Colli G., Fornari A., Galvan A.E. Martin F., Mazzitelli F., Orlich V., Patriarca E., Rotelli A., Zhang L., Vaia F. FOTOGRAFIE di Coledan W., Granatelli G., Grilli B.A. Mazzitelli F., Patriarca E., Raffaelli P., Vaia F. EDITORE - CLUB ALPINO ITALIANO Sezione Cadorina “Luigi Rizzardi” Piazza Regina Pacis, C.P. 30, 32041 Auronzo di Cadore BL - Tel. 0435.99454 REDAZIONE Via B. Ricasoli, 13 - 30174 Venezia-Mestre - Tel. 041.942672 e-mail: [email protected] STAMPA Grafiche Vianello srl - Via Postioma, 85 - 31050 Ponzano TV Prezzo di copertina € 3,80 - Numeri arretrati € 7,00 Abbonamento 2014: Ordinario € 6,00 - Sostenitore € 8,00 - Benemerito € 12,00 C.C.P. -
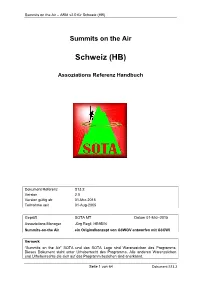
Summits on the Air – ARM V2.0 Für Schweiz (HB)
Summits on the Air – ARM v2.0 für Schweiz (HB) Summits on the Air Schweiz (HB) Assoziations Referenz Handbuch Dokument Referenz S13.2 Version 2.0 Version gültig ab 01-Mrz-2015 Teilnahme seit 01-Aug-2005 Geprüft SOTA MT Datum 01-Mrz–2015 Assoziations Manager Jürg Regli, HB9BIN Summits-on-the Air ein Originalkonzept von G3WGV entworfen mit G3CWI Vermerk “Summits on the Air” SOTA und das SOTA Logo sind Warenzeichen des Programms. Dieses Dokument steht unter Urheberrecht des Programms. Alle anderen Warenzeichen und Urheberrechte die sich auf das Programm beziehen sind anerkannt. Seite 1 von 64 Dokument S13.2 Summits on the Air – ARM v2.0 für Schweiz (HB) Inhaltsverzeichnis 1 ÄNDERUNGSPROTOKOLL..................................................................................................................... 4 ASSOZIATIONS REFERENZ DATEN ........................................................................................................... 11 1.1 REGIONSEINTEILUNG ........................................................................................................................... 12 1.2 GENERELLE INFORMATIONEN .............................................................................................................. 12 1.3 KARTENMATERIAL ............................................................................................................................... 12 1.4 HAFTUNGSAUSSCHLUSS ....................................................................................................................... 13 1.5 LETZTE WORTE................................................................................................................................... -

Nazewnictwo Geograficzne Ś Wiata
NAZEWNICTWO GEOGRAFICZNE NAZEWNICTWO GEOGRAFICZNE Ś WIATA Zeszyt 12 Ś WIATA 12. Europa – Cz WIATA 12. Europa Europa Część II ęść II IISBNSBN 9978-83-254-0825-178-83-254-0825-1 GŁÓWWNYNY UURZRZĄD GGEODEZJIEODEZJI I KKARTOGRAFIIARTOGRAFII OOkladka.inddkladka.indd 226767 66/10/10/10/10 110:13:170:13:17 PPMM KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przy Głównym Geodecie Kraju NAZEWNICTWO GEOGRAFICZNE ŚWIATA Zeszyt 12 Europa Część II GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 2010 EEuropa2.indburopa2.indb 1 66/10/10/10/10 9:49:219:49:21 PPMM KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przy Głównym Geodecie Kraju Waldemar Rudnicki (przewodniczący), Andrzej Markowski (zastępca przewodniczącego), Maciej Zych (zastępca przewodniczącego), Katarzyna Przyszewska (sekretarz); członkowie: Stanisław Alexandrowicz, Andrzej Czerny, Janusz Danecki, Janusz Gołaski, Romuald Huszcza, Sabina Kacieszczenko, Dariusz Kalisiewicz, Artur Karp, Zbigniew Obidowski , Jerzy Ostrowski, Jarosław Pietrow, Jerzy Pietruszka, Andrzej Pisowicz, Bogumiła Więcław, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Bogusław R. Zagórski Opracowanie Elżbieta Chudorlińska (Belgia, Holandia, Irlandia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania), Andrzej Czerny (Austria, Niemcy), Jarosław Pietrow (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja), Agnieszka Pietrzak (Hiszpania, Malta, Portugalia, Włochy), Maksymilian Skotnicki (Francja), Maciej Zych (Andora, Francja, Gibraltar, Guernsey, Holandia, Jan Mayen, Jersey, Liechtenstein, Luksemburg, -

COMMISSION DECISION of 25 January 2008 Adopting, Pursuant To
L 77/106 EN Official Journal of the European Union 19.3.2008 COMMISSION DECISION of 25 January 2008 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, a first updated list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region (notified under document number C(2008) 271) (2008/218/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, sites of Community importance for the Alpine biogeo- graphical region within the meaning of Article 1 of Having regard to the Treaty establishing the European Commu- Directive 92/43/EEC. The obligations resulting from nity, Articles 4(4) and 6(1) of Directive 92/43/EEC are applicable as soon as possible and within six years at most from the adoption of the first updated list of sites of Community Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 importance for the Alpine biogeographical region. on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (1) and in particular the third subparagraph of Article 4(2) thereof, (6) On the other hand, the update of the initial list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical Whereas: region is necessary in order to reflect any changes in site related information submitted by the Member States (1) The Alpine biogeographical region referred to in Arti- following the adoption of the Community list. In that cle 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC, comprises the Com- sense, the first updated list of sites of Community munity territory of the Alps (Austria, Italy, Germany, importance for the Alpine biogeographical region consti- France, Slovenia), the Pyrenees (France and Spain), the tutes a consolidated version of the initial list of sites of Apennine mountains (Italy), the northern Fennoscandian Community importance for the Alpine biogeographical mountains (Sweden and Finland), the Carpathian moun- region.