C:\Eipli-2019-Hydro\Conza
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Coastal Ocean Forecasting with an Unstructured Grid Model in the Southern Adriatic and Northern Ionian Seas
Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 17, 45–59, 2017 www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/17/45/2017/ doi:10.5194/nhess-17-45-2017 © Author(s) 2017. CC Attribution 3.0 License. Coastal ocean forecasting with an unstructured grid model in the southern Adriatic and northern Ionian seas Ivan Federico1, Nadia Pinardi1,2,3, Giovanni Coppini1, Paolo Oddo2,a, Rita Lecci1, and Michele Mossa4 1Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici – Ocean Predictions and Applications, via Augusto Imperatore 16, 73100 Lecce, Italy 2Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Via Donato Creti 12, 40100 Bologna, Italy 3Universitá degli Studi di Bologna, viale Berti-Pichat, 40126 Bologna, Italy 4Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, Politecnico di Bari, Via E. Orabona 4, 70125 Bari, Italy anow at: NATO Science and Technology Organisation – Centre for Maritime Research and Experimentation, Viale San Bartolomeo 400, 19126 La Spezia, Italy Correspondence to: Ivan Federico ([email protected]) Received: 13 May 2016 – Published in Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss.: 25 May 2016 Accepted: 6 December 2016 – Published: 11 January 2017 Abstract. SANIFS (Southern Adriatic Northern Ionian ternative datasets at different horizontal resolution (12.5 and coastal Forecasting System) is a coastal-ocean operational 6.5 km). system based on the unstructured grid finite-element three- The SANIFS forecasts at a lead time of 1 day were com- dimensional hydrodynamic SHYFEM model, providing pared with the MFS forecasts, highlighting that SANIFS is short-term forecasts. The operational chain is based on a able to retain the large-scale dynamics of MFS. -

Progetto CARG Per Il Servizio Geologico D’Italia - ISPRA: F
I S P R A Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA Organo Cartografi co dello Stato (legge n°68 del 2.2.1960) NOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA alla scala 1:50.000 foglio 450 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI A cura di: T. S. Pescatore1†, F. Pinto1 Con contributi di: P. Galli2 (Sismicità e Strutture Sismogeniche) S. I. Giano3 (Geologia del Quaternario e Geomorfologia) R. Quarantiello1 (Geologia Applicata) M. Schiattarella3 (Tettonica e Morfotettonica) PROGETTORedazione scientifica: M.L. Putignano4 1 Dipartimento di Scienze per la Biologia, Geologia e l’Ambiente, Università degli Studi del Sannio - Benevento 2 Dipartimento di Protezione Civile Nazionale - Roma 3 Dipartimento Scienze Geologiche, Università degli Studi della Basilicata - Potenza 4 Istituto di Geologia Ambientali e Geoingegneria - IGAG - CNR - RomaCARG CNR Ente realizzatore: Consiglio Nazionale delle Ricerche NoteIllustrative F450_S.Angelo dei Lomabardi_17_01_2020_cc.indd 1 17/01/2020 16:20:53 Direttore del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA: C. Campobasso Responsabile del Progetto CARG per il Servizio Geologico d’Italia - ISPRA: F. Galluzzo Responsabile del Progetto CARG per il CNR: R. Polino (IGG), fino al 2009, P. Messina (IGAG) Gestione operativa del Progetto CARG per il Servizio Geologico d’Italia - ISPRA: M.T. Lettieri per il Consiglo Nazionale delle Ricerche - CNR: P. Messina (IGAG) PER IL SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA - ISPRA: Revisione scientifica: R. Di Stefano (†), A. Fiorentino, F. Papasodaro, P. Perini Coordinamento cartografico: D. Tacchia (coord.), S. Grossi Revisione informatizzazione dei dati geologici: L. Battaglini, R. Carta, A. Fiorentino (ASC) Coordinamento editoriale: D. Tacchia (coord.), S. Grossi PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE: Funz. -
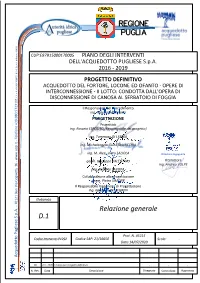
D.1 Relazione Generale
CUP:E97B15000170005 PIANO DEGLI INTERVENTI DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. 2016 - 2019 PROGETTO DEFINITIVO ACQUEDOTTO DEL FORTORE, LOCONE ED OFANTO - OPERE DI INTERCONNESSIONE - II LOTTO: CONDOTTA DALL'OPERA DI DISCONNESSIONE DI CANOSA AL SERBATOIO DI FOGGIA Il Responsabile del Procedimento ing. Massimo Pellegrini PROGETTAZIONE Progettisti ing. Rosario ESPOSITO (Responsabile del progetto) ing. Tommaso DI LERNIA ing. Michelangelo GUASTAMACCHIA ing. M. Alessandro SALIOLA geom. Giuseppe VALENTINO Il Direttore ing. Andrea VOLPE ing. Roberto LAVOPA Collaborazione alla progettazione geom. Pietro SIMONE Il Responsabile Ingegneria di Progettazione ing. Massimo PELLEGRINI Elaborato - 70121 Bari Via Cognetti, 36 www.aqp.it Telefono +39.080.5723111 Relazione generale D.1 Prot. N. 45215 Codice SAP: 21/16650 Scala: - Data 14/07/2020 Acquedotto Pugliese S.p.A. 00 OTT. 2020 Emesso per Progetto definitivo - - - N. Rev. Data Descrizione Disegnato Controllato Approvato Progetto definitivo“Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione Secondo Lotto: condotta dall’opera di disconnessione di Canosa al serbatoio di Foggia” Relazione generale Pagina 1 di 132 INDICE 1. PREMESSA ..................................................................................................................... 4 1.1 SCHEMA GENERALE DELLA GRANDE ADDUZIONE DELLA PUGLIA ........................................ 5 1.2 OPERE ESISTENTI CHE INTERESSANO L’INTERVENTO .......................................................... 7 1.2.1 Generalità .................................................................................................................. -
![Verso Il Patto Val Ofanto.Ppt [Sola Lettura]](https://docslib.b-cdn.net/cover/6903/verso-il-patto-val-ofanto-ppt-sola-lettura-986903.webp)
Verso Il Patto Val Ofanto.Ppt [Sola Lettura]
Calitri (AV) 14 ottobre 2009 verso il Patto della Val d’Ofanto Il Marchio “identitario” della bioregione ofantina Mauro Iacoviello Parole Chiave Identità Scenario strategico Manifesto Mappa di Valori Contratto Bioregionalismo Complessità Osservatorio Visione/Metafora Partecipazione pioniera Reti/Filiere corte e lunghe nella bioregione Territorializzazione della programmazione VAS locali come strumento Rete Ecologica Mutifunzionale (REM) Multifunzione/multiobiettivo Sviluppo … lontano dall’equilibrio Lentezza e fascinazione (F. Cassano) Calitri 14 ottobre 2009 …prima… Calitri 14 ottobre 2009 8 Valori 1. L’agricoltura multifunzionale come valore patrimoniale 2. Il Terzo Paesaggio sulla natura ibrida della Valle 3. Rete Ecologia L’Ofanto come corridoio/condotto 4. Partecipazione pioniera attorno a progettualità di tipo compensativo, visibilie, minima, ed efficace 5. La territorializzazione del PSR 2007/2013 6. Sportello unico per la multifunzionalità dell’agricoltura 7. Le vie di terra e di acqua 8. Il Parco dei Poli i presidi urbani vitali e multifunzionali nella Valle (esiti di dell’incontro del 16 febbraio 2009 a San Ferdinando di Puglia in occasione della presentazione dell’Atlante Cartografico Ambientale del parco regionale del fiume Ofanto 2008) Calitri 14 ottobre 2009 Il fiume “sistema complesso” (esiti di dell’incontro del 16 febbraio 2009 a San Ferdinando di Puglia in occasione della presentazione dell’Atlante Cartografico Ambientale del parco regionale del fiume Ofanto 2008) Calitri 14 ottobre 2009 Il fiume per la Rete Ecologica -

Scarica Il Documento
REGIONE BASILICATA COMUNE DI MONTEMILONE PROVINCIA DI POTENZA www.newgreen.it COMUNE DI VENOSA COMUNE DI SPINAZZOLA COMUNE DI BANZI PROVINCIA DI POTENZA PROVINCIA DI BAT PROVINCIA DI POTENZA COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO PROVINCIA DI POTENZA PROVINCIA DI POTENZA Via Diocleziano, 107 - 80125 Napoli Tel. 081.19566613 Fax. 081.7618640 COD.REG DESCRIZIONE SCALA DI RAPP. N.P. REPORT FOTOGRAFICO AREE PROTETTE COD. INT. RICADENTI NELLE AREE CONTERMINI ELAB. 26 ENERGY REDATTO VERIFICATO APPROVATO REVISIONE Revisione 0 Dott. R.Castaldo Arch. M.Lombardi Ing. G.Delli Priscoli Ing. G.Faella Ing. G.De Masi DATA Cogein 01/2020 REPORTAGE FOTOGRAFICO VINCOLI AMBIENTALI PUGLIA Rete ecologica - connessioni terrestri DESCRIZIONE La rete ecologica q XQVLVWHPD interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la ELRGLYHUVLWjSRQHQGR quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. Una rete ecologica DQGUj a formare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando FRVu a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla ELRGLYHUVLWj E' costituita da diversi elementi tra cui i corridoi ecologici, che si identificano come fasce che permettono una FRQWLQXLWj fra due habitat di maggiore estensione. Si tratta di una FRQWLQXLWj di tipo strutturale, senza implicazioni sull'uso relativo da parte della fauna e, quindi sulla loro efficacia funzionale, dipendendo quest'ultima da fattori intriseci a tali ambiti (area del corridoio, ampiezza, collocazione rispetto ad aree analoghe, TXDOLWj ambientale, tipo di matrice circostante, ecc.) ed estrinseci ad essi (caratteristiche eto-ecologiche delle specie che possono, potenzialmente, utilizzarlo). All'interno di un corridoio ecologico uno o SL habitat naturali permettono lo spostamento della fauna e lo scambio dei patrimoni genetici tra le specie presenti aumentando il grado di ELRGLYHUVLWj Le connessioni terrestri rappresentano una delle due tipologie di corridoi ecologici (insieme ai corridoi fluviali). -

RILEGGERE UN TERRITORIO ATTRAVERSO LA FERROVIA: Il Caso Dell’Irpinia E Dell’Avellino - Rocchetta Sant’Antonio
XXXIX CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI RILEGGERE UN TERRITORIO ATTRAVERSO LA FERROVIA: il caso dell’Irpinia e dell’Avellino - Rocchetta Sant’Antonio di Maria Giulia Contarino1, Emanuele Von Normann2 1 Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre Largo G. Battista Marzi 10, Roma | [email protected] 2 Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre Largo G. Battista Marzi 10, Roma | [email protected] ABSTRACT “I paesi dell’Irpinia d’Oriente hanno una particolare, desolata bellezza, ma nessuno li conosce davvero questi paesi. Perché per attraversarli nelle loro fibre ultime bisogna lasciare la macchina e camminare senza aspettarsi nulla di stupefacente. A dispetto degli inerti e dei rancorosi in paese c’è sempre qualcosa da vedere, da sentire. Chi ha detto che qui la vita deve essere un luogo di fatiche infernali? Chi ha detto che non ci possiamo più stupire, che dobbiamo solo lamentarci o intristire? L’Irpinia c’è ancora, non è tutta scomparsa, ma bisogna viaggiare, viaggiare verso oriente. Non bisogna avere l’ansia di scavalcare le montagne per inseguire le città maggiori. Bisogna restare sull’Altura.” (Franco Arminio – Viaggio nel Cratere) Attraverso i suoi 118km, la linea ferroviaria Avellino-Rocchetta Sant’Antonio offre un decalogo preciso e minuzioso dell’immensa eterogeneità dell’Irpinia. Un’eterogeneità paesaggistica, culturale e sociale che racconta un territorio che per troppo tempo è rimasto isolato ma che, proprio a causa di questa sua condizione in principio svantaggiosa, ha conservato tutti quegli elementi di pregio delle tradizioni popolari e dei paesaggi incontaminati. Lungo il suo percorso, che ricalca fedelmente quello di due dei più importanti fiumi della provincia, il Calore e l’Ofanto, il tracciato ferroviario dà la possibilità, a chi visita per la prima volta l’Irpinia, di cogliere gli elementi che storicamente e morfologicamente hanno caratterizzato questa provincia. -

Avellino and Irpinia
Generale_INGL 25-03-2008 13:28 Pagina 148 Avellino and Irpinia 148 149 A mantle of woods covers the “green Irpinia”, from an environmental point of view, one of the most i beautiful and rich territories of Italy: it includes parks and naturalistic oases, mountains and high plains full of springs, grottoes, lakes, rivers, waterfalls, woods… The magic colours and scents invite walks in an unspoiled environment, long Ente Provinciale per il itineraries which at every step reveal spectacular Turismo di Avellino views of grandiose mountains, streams and wide via Due Principati 32/A valleys. Avellino tel. 0825 747321 Discovering Irpinia step by step, amidst the marvels www.eptavellino.it of the landscape, emerges its cultural and artistic heritage: Etruscans, Greeks, Romans, Goths, Provincia di Avellino Longobards…in three thousand years many peoples Assessorato al Turismo have passed by these lands and left their marks: in piazza Libertà 1 Avellino the Roman ruins, the severe catacombs, the tel. 0825 793058 Longobard ruins and Baroque monuments. There is no village in Irpinia without a story to tell. Irpinia is Ente Parco Regionale also world famous for its glorious wine growing del Partenio tradition: it is the land of the Docg wines: Taurasi, via Borgonuovo 1 Summonte (AV) Greco di Tufo and Fiano. These wines exalt the tel. 0825 691166 typical local cuisine: quality products and old www.parcopartenio.it recipes guarantee excellent dishes. Inns, trattorias and famous restaurants unite passion, experience Atripalda Palazzo dell’ex Dogana and innovation, and offer the possibility to savour dei Grani real culinary masterpieces. piazza Umberto I The choice of accomodations is wide and varied, for tel. -

Roman Expansion, Environmental Forces, and the Occupation of Marginal Landscapes in Ancient Italy
Article The Agency of the Displaced? Roman Expansion, Environmental Forces, and the Occupation of Marginal Landscapes in Ancient Italy Elisa Perego 1,2,* and Rafael Scopacasa 3,4,* 1 Institut für Orientalische und Europäische Archäologie, Austrian Academy of Sciences, A 1020 Vienna, Austria 2 Institute of Archaeology, University College London, London WC1H 0PY, UK 3 Department of History, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte 31270-901, Brazil 4 Department of Classics and Ancient History, University of Exeter, Exeter EX4 4RJ, UK * Correspondence: [email protected] (E.R.); [email protected] (R.S.) Received: 1 February 2018; Accepted: 16 October 2018; Published: 12 November 2018 Abstract: This article approaches the agency of displaced people through material evidence from the distant past. It seeks to construct a narrative of displacement where the key players include human as well as non-human agents—namely, the environment into which people move, and the socio-political and environmental context of displacement. Our case-study from ancient Italy involves potentially marginalized people who moved into agriculturally challenging lands in Daunia (one of the most drought-prone areas of the Mediterranean) during the Roman conquest (late fourth-early second centuries BCE). We discuss how the interplay between socio-political and environmental forces may have shaped the agency of subaltern social groups on the move, and the outcomes of this process. Ultimately, this analysis can contribute towards a framework for the archaeological study of marginality and mobility/displacement—while addressing potential limitations in evidence and methods. Keywords: Marginality; climate change; environment; ancient Italy; resilience; archaeology; survey evidence; displacement; mobility 1. -

Relazione Idraulica
REGIONE BASILICATA Gaudiano di Lavello Matera Potenza ADDUTTORE ALTO FASCIA LITORANEA BARESE LAVORI PER LA COSTRUZIONE E PER L'ALLESTIMENTO DEL MANUFATTO DI REGOLAZIONE DELL'ADDUTTORE IN CORRISPONDENZA DELLA DERIVAZIONE PER LE ZONE ALTE DI GAUDIANO PROGETTO ESECUTIVO A-ELABORATI DESCRITTIVI Luglio 2014 A2 Relazione idraulica IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Prof. Ing. A.F. PICCINNI Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7288 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Avv. G. MUSACCHIO INDICE 1 Premessa ..................................................................................................................... 2 2 Lo schema idraulico esistente ...................................................................................... 3 2.1 Opere di sbarramento ........................................................................................... 4 2.1.1 Invaso del Rendina, invaso del Locone e traversa Santa Venere ................. 5 2.2 Le opere di adduzione ........................................................................................... 7 3 Le opere in progetto ..................................................................................................... 9 4 Verifiche idrauliche ..................................................................................................... 12 4.1 Moto permanente ................................................................................................ 12 4.2 Risultati .............................................................................................................. -

Digitalizzato Da Gerardo Di Pietro, Binningen, Svizzera
digitalizzato da Gerardo Di Pietro, Binningen, Svizzera 1 digitalizzato da Gerardo Di Pietro, Binningen, Svizzera 2 digitalizzato da Gerardo Di Pietro, Binningen, Svizzera 3 digitalizzato da Gerardo Di Pietro, Binningen, Svizzera 4 digitalizzato da Gerardo Di Pietro, Binningen, Svizzera SOMMARIO AGOSTINO PELULLO Il Contratto di fiume e il protagonismo dei giovani ............................................................................................. 7 SERAFINO CELANO Perché un contrattoper l’Ofanto .................................... 9 STANISLAO DE MARSANICH Tra parole e territorio ................................. 11 IL CURATORE In una frattura ........................................................................ 17 DI QUEST’ACQUA PERTURBATA A RIVA ................................... 20 PINO APRILE Se nasci dove sono nato io ........................................................ 21 SALVATORE SALVATORE Ofanto ............................................................... 24 MARCELLO GIANNOTTI - ILARIA CAMMARATA l’oasi Wwf “Lago Di Conza” ............................................................................................................... 26 FRANCA MOLINARO Il parco dell’Ofanto .................................................... 28 LEANDRO PISANO Tra le rive dell’Ofanto ed il “lago di Conza .................. 30 MAURO IACOVIELLO Nuovi briganti ........................................................... 33 FRANCO ARMINIO Il fiume e la regola ............................................. 37 EMILIA BERSABEA CIRILLO -

La Diga Locone
C O N S O R Z I O D I B O N I F I C A T E R R E D’ A P U L I A – B A R I – LA DIGA LOCONE Ubicata sul torrente omonimo, affluente del fiume Ofanto, in agro di Minervino Murge, località “Monte Melillo” BARI, novembre 2011 AREA GESTIONE E MANUTENZIONE IL DIRETTORE Dott. Ing. Giovanni MARINELLI RELAZIONE SCHEMI IDRICI DELLA REGIONE PUGLIA I principali schemi idrici interregionali ad uso plurimo che interessano la Puglia sono: schema del Fortore (Puglia e Molise) a servizio della Puglia Nord: comprende quasi tutta la provincia di Foggia ad eccezione di 13 comuni del Subappennino dauno prossimi al confine con il Molise che vengono invece alimentati dall’Acquedotto Molisano Destro; schema dell’Ofanto (Campania, Basilicata e Puglia) al servizio della Puglia Centrale: comprende la provincia di Bari e parte delle province di Brindisi e Taranto, oltre a servire al- cune utenze della provincia di Matera; schema Jonico-Sinni (Basilicata, Puglia e Calabria) al servizio della Puglia Meridionale: comprende la provincia di Lecce e parte delle province di Taranto, Brindisi e Matera. Vi sono anche schemi idrici minori di interesse regionale quali, il Carapelle e il Gravina- Pentecchia. LO SCHEMA OFANTO Lo schema Ofanto è di interesse interregionale e presenta 5 invasi: Conza e Osento in Campania Rendina in Basilicata Marana Capacciotti e Locone in Puglia Le risorse idriche rese disponibili dallo schema soddisfano i fabbisogni irrigui ed industriali dei territori lucani e pugliesi del medio e basso Ofanto. La funzionalità dell’intero schema è regolata dalla Traversa di Ponte Santa Venere realizzata sull’asta principale del fiume, in località Rocchetta Sant’Antonio. -

Studio-Di-Fattibilità-Albergabici
Provincia di Barletta Andria Trani in qualità di Soggetto delegato per la gestione per Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto (per effetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 998/2013) Provincia di Barletta Andria Trani – Gestione Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto Ing. Vincenzo Guerra Dirigente Settore Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura ed Aziende Agricole, Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti STUDIO DI FATTIBILITA’ Ciclo-via della Valle dell’Ofanto ALBERGABICI - CANNE DELLA BATTAGLIA ALBERGABICI - INVASO DEL LOCONE Progettisti: Arch. Mauro Iacoviello Arch. Daniela B. Lenoci Arch. Marco Stigliano Elaborato Elaborato: Relazione Unica Data: Scala File: Aggiornamenti: Ottobre 2020 Sommario 1. Premesse e finalità generali della proposta ............................................................................................... 2 2. Albergabici dalle funzioni complesse ......................................................................................................... 8 2.1 Albergabici presso l'Ecomuseo di Canne della Battaglia ..................................................................... 8 2.2 Albergabici, Ecoforesteria e Centro di Educazione Ambientale presso l’invaso del Locone ............ 11 3. Vincoli e procedure autorizzative ............................................................................................................ 17 4. Disponibilità delle aree .............................................................................................................................. 18