Scuderia Brescia Corse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liste Visiteurs 2012
Liste Visiteurs 2012 1 ET 1 FONT 3 100 EXPRESS 101 SECURITE PRIVEE 2 D CONSTRUCTION GRAND OUEST 20 MINUTES 20TY CENTURY FOX VIDEO 268 ECHOFRACHT RAIL S R O 2AC 2AF CONSEIL 2B2M SARL 2E2C 2ETW CONSULTING SERVICES 2HAG 2IPS 2K CONSEIL 2LCI 2M 2M DISPAM 2WMS 3 SUISSES FRANCE 3AINGG 3B EMBALLAGES 3DSOFT 3F INDUSTRIE 3GRT 3I CONSULTING 3M 3M FRANCE 3M LOGISTICS 3M SOA LOGISTICS SAS 3S CONSEIL 3SUISSES 3T FRANCE 4 ELEMENTS CONSEIL 43 BT 4GLOBAL FORWARDING BV 4I SA 4ICOM 4M FRANCE 4NET 4PL EUROPE RUSSIA 4PLANET 4POLE 4S NETWORK 4SH 4SH FRANCE 6 IT 79 AGENCY A A A A A A O A C I D A C OERSSLEFF CHARTERING A CCENTS A CONSTRUCT S A R L A CONSTRUCT SARL A D C A D F A GUILLEMET ET FILS A I P A I T A L O G I INTERNATIONAL A LAZRAK IMMOBILIER A N P E A PIN UP WORLD A PLUS A PLUS FINANCE A PLUS SA A R M E LOGISTIQUE A RAYMOND A S A SAFE A SCHULMAN A SIS A T B A T S A V N A VOS FOURNITURES A22 EXPERT EN LOGISTIQUE A2C CONSEIL ET FORMATION A2E A2MCONSEIL A2P A2PARTNER A3 MULTIMEDIA A5A ARCHITECTES A7INGENIERIE AA SRL AAA AACFT AADL AAE AAF SA AAO AAP DISTIBUTION AAPL AASSET AASSET SECURITY Liste Visiteurs 2012 AB CONCEPT AB CONSULT AB CONSULTING AB FERRIES AB TRANS AB2E AB3C ABACOM ABB ABB FRANCE DIV ENERGIE ABBOTT FRANCE SAS ABBS ABC MARKETS ABC PLASTIK ABCAL ABCD ABCD ADVANCED ABCD ADVANCED BUILDING ABCD GROUP ABCD INTERNATIONAL ABCD MAROC ABCD TELECOM ABCE LOGISTIC MTS RESEAU MTO ABCLOG ABEDO ABENA FRANTEX ABENDLAND ABERSON SARL ABERSOPN SARL ABESIM ABGA ABGRALL LEVY ABILEO ABIS ABLOY ABLOY OY ABONEX ABONEX S R O ABRALOG ABREU CARGO ABRICARD ABRISO -

Drago Regvart, Svestrani Oktanac – Automobilista I Motociklista !
Drago Regvart, svestrani oktanac – automobilista i motociklista ! Regvart je svoju sportsku karijeru započeo kao motociklista, točnije vozač speedwaya ! Davne 1955. godine bio je reprezentativac speedwaya bivše države ... Nastavak slijedi u automobilima. 1954 12.09 : Zagreb?? Yugoslavia v. Austria 1955 05.08 : Maribor Yugoslavia 31 Austria 36 (Att: 4,000) Branko Regvart Drago Regvart Mika Snjaric Josip Klemencic Valentin Medved Slavko Lampe 1956 ??.?? : Crikvencia Yugoslavia 28 Austria 38 (Att : 15,000) Drago Regvart 9 Josef Kamper 12 Josip Klemencic 9 Otto Holoubek 10 Valentin Medved 5 Hans Sidlo 9 Vinko Mrak 4 Erich Tomaschek 4 Ruzic 1 Alfred Sitzwohl 3 1957 ??.?? : Zagreb Yugoslavia 54 Austria 53 (Att: 8,000) Drago Regvart 14 Otto Holoubek 14 Valentin Medved 14 Hans Sidlo 11 Josip Klemencic 11 Erich Sidlo 11 Vinko Mrak 8 Rabel 10 Erich Tomaschek ? 1960 08.05 : Kranj Yugoslavia v. Austria Joze Visocnik Valentin Unterkofler Franc Babic Kurt Schwingenschlogl Joze Mocnik Johan Hartl Mateuz Rozman Ivan Kos Drago Perko 21.08 : Zagreb Yugoslavia won Austria Drago Perko Josef Bossner Drago Regvart V Metz Tone Mlakar Valentin Medved WORLD TEAM CUP 1970 Great Britain seeded to Final CONTINENTAL QUARTER-FINAL (1st & 2nd to Continental Semi-Final) 21.06 : Crikvenica, Yugoslavia Czechoslovakia 48 Yugoslavia 28 Bulgaria Miroslav Verner 12 Drago Regvart Alexander Kostov Zdenek Majstr 12 Drago Perko Peter Petkov Jiri Stancl 12 Ivan Molan Peter Iliev Vaclav Verner 12 Drasko Orsic Georgi Macev Jan Klokocka † - Jose Visocnik Re: Individual Speedway World Championship. Osijek. May 8, 1966. I can help You with the finishing positions, but don't know the points scored for positions 11 to 16. -

The Charm of Heritage Looks to the Future
THE CHARM OF HERITAGE LOOKS TO THE FUTURE The first “real” Ferrari and the first production Lamborghini Touring Superleggera; the jewels of Lamborghini from the Miura to the Super Trofeo; the first vehicle ever built in Italy; the joy of experiencing the 1950s of the Nicolis Museum; the pink Jaguar that took over the first page of Car Life and the cutting edge models that marked turning points in the history of cars. Just a few days from the inauguration on 20 October, Auto e Moto d’Epoca in Padua reveals the marvels of the past and the common thread linking heritage to the present day. Link Foto Gallery From 20 to 23 October 2016, 4500 cars, 500 motorbikes and 1600 exhibitors will be meeting in Padua for the biggest Classic market in Europe. At Auto e Moto d’Epoca the charm of heritage is united with previews of contemporary cars based on passion that unites past and future and the continuous innovation that keeps them united. So, the show, which has become the most important in Italy - will be opening with 16 international brands, the cars that have made history and those that will do so in the future. The national previews and new products from Alfa Romeo, Abarth, Audi, Citroën, DS, Maserati, Land Rover, Jaguar, Mercedes, Pagani, Porsche, Tesla, Volkswagen and Volvo will be alongside vintage models that have marked the evolution and created the legend of each car manufacturer. Among the top pavilions are the three souls of Lamborghini’s heritage, united in a large single stand with the Lamborghini Museum, the “Polo Storico”, the Lamborghini Club Italia and an exiting panorama from the Miura to the Super Trofeo of the jewels from Sant’Agata. -

REGISTRO ITALIANO ALFA ROMEO (R.I.A.R.) International Club Il Presidente
Fondato nel 1962 REGISTRO ITALIANO ALFA ROMEO (R.I.A.R.) International Club Il Presidente REGISTERED LETTER Arese, 26 October 2016 Newsletter no. 268 Dear Members, 2016 for RIAR under the flag of the Targa Florio – a year started with the event in Arese and ended with the trade fair in Padova. 20020 Arese (MI) Arese 20020 www.riar.it Our usual presence at the fair was in fact one more way of paying tribute to the - - history of the Targa Florio, which this year celebrated its 110th year of life. Alfa Romeo - second only to Porsche with its 11 victories - conquered as many as 10 absolute victories in this legendary Sicilian race, one of the most ancient and prestigious motor race in the world. But certainly, it was Alfa and the audacity of its drivers, which, particularly from the ‘20s to the ‘40s, created the extraordinary legend and @alfaromeo.com @alfaromeo.com enthusiasm around the Milanese brand. And the RIAR, as you may remind, set off Viale Luraghi, snc snc Luraghi, Viale – remembering its men and cars in March of this year at the Museum in Arese. The ACI (Automobile Club Italia) then invited four of our prestigious and exceptional vehicles to Palermo and Floriopoli in May for the Targa Speed event, together with the most registroalfa famous drivers of the past, “captained” by Jean Todt, President of FIA, to give life to the suggestive celebration of the one hundred years of Targa races. E.mail: - FCA Group Italy Italy FCAGroup – In late June, we were once again in Sicily with the rally “The Sicily of the Gattopardi on the Hundredth Anniversary of the Targa Florio”, and at last in Padova, once again invited by the ACI to the institutional prestige of its stand, where we exhibited two 44428183 important and very significant vehicles in the history of Alfa at the Targa: the RL TF from 1924, and the 33 TT 12 Fernet Branca, precisely the cars of the first and last victory of Alfa Romeo on the Madonie Mountains. -

Karl E. Ludvigsen Papers, 1905-2011. Archival Collection 26
Karl E. Ludvigsen papers, 1905-2011. Archival Collection 26 Karl E. Ludvigsen papers, 1905-2011. Archival Collection 26 Miles Collier Collections Page 1 of 203 Karl E. Ludvigsen papers, 1905-2011. Archival Collection 26 Title: Karl E. Ludvigsen papers, 1905-2011. Creator: Ludvigsen, Karl E. Call Number: Archival Collection 26 Quantity: 931 cubic feet (514 flat archival boxes, 98 clamshell boxes, 29 filing cabinets, 18 record center cartons, 15 glass plate boxes, 8 oversize boxes). Abstract: The Karl E. Ludvigsen papers 1905-2011 contain his extensive research files, photographs, and prints on a wide variety of automotive topics. The papers reflect the complexity and breadth of Ludvigsen’s work as an author, researcher, and consultant. Approximately 70,000 of his photographic negatives have been digitized and are available on the Revs Digital Library. Thousands of undigitized prints in several series are also available but the copyright of the prints is unclear for many of the images. Ludvigsen’s research files are divided into two series: Subjects and Marques, each focusing on technical aspects, and were clipped or copied from newspapers, trade publications, and manufacturer’s literature, but there are occasional blueprints and photographs. Some of the files include Ludvigsen’s consulting research and the records of his Ludvigsen Library. Scope and Content Note: The Karl E. Ludvigsen papers are organized into eight series. The series largely reflects Ludvigsen’s original filing structure for paper and photographic materials. Series 1. Subject Files [11 filing cabinets and 18 record center cartons] The Subject Files contain documents compiled by Ludvigsen on a wide variety of automotive topics, and are in general alphabetical order. -

Se C'è Una Persona Cui Tutti Noi Appassionati Delle Auto Storiche E
Se c’è una persona cui tutti noi appassionati delle auto storiche e delle competizioni con le mitiche dobbiamo quasi Luca Grandori e Giovanni Lurani premiano Marco Cajani. tutto, questi è Luca Grandori. Giornalista di straordinarie a- perture e intuizioni, “inventore” delle corse con le classiche ha riportato alla vita e in pista quelle automobili che invece sarebbero rimaste nei garage e destinate a quei, per me tristanzuoli, rally mangia-bevi. No, Luca no non poteva sop- portare una simile tristezza e allora, dopo una serie di visite in Inghilterra a fiutare l’ambiente torna, mette in piedi la Scu- deria del Portello e raduna attorno a sé un’elite di piloti dilet- tanti e di personalità del mondo dell’industria, della finanza e della cultura tutte perfettamente amalgamate nella Scuderia dalla comune passione e dalla capacità di guidare forte e bene. E di gente che andava molto, ma tanto, sin dagl’inizi ce n’era parecchia. Citare qualcuno significa fare un torto a tutti gli altri… Ricordo benissimo come avvenne la mia coopta- zione nella Scuderia del Portello. Luca, tra le altre cose, ave- va inventato il mitico Auto Capital, io dirigevo il Corriere dei Piccoli. Tutti e due, lui e io, ci si vedeva quasi ogni giorno in via Scarsellini, sede della Casa editrice, e spesso, dati i miei natali giornalistici nel mondo dell’auto a Quattroruote, che si faceva? Si parlava di donne e motori. E cominciò la mia vita in comune con Luca in senso giornalistico e corsaiolo. Gran- dori portò sulle piste di tutta Europa, le stesse che vedevano i Grand Prix o che erano state il teatro delle classiche di du- rata, il gruppetto di patiti che si confrontarono così coi driver inglesi, olandesi, tedeschi, svizzeri nel Campionato Europeo delle auto storiche. -
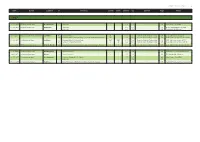
Unknown - - 001 2.0 - LH Lang Heck | Long Tail
Copyright © Rob Semmeling 1 Date Event Location # Driver(s) Overall Class Chassis CC Entrant Type Notes 1967 00.04.1967 Porsche private test Hockenheim - Unknown - - 001 2.0 - LH Lang Heck | Long Tail 00.04.1967 Porsche private test Unknown - Unknown - - 001 2.0 - LH At the Volkswagen test track - Unknown - - 002 2.0 - LH Possibly in Wolfsburg ? 09.04.1967 Essais des 24 Heures du Mans Le Mans 40 Gerhard Mitter 21 - 001 2.0 Porsche System Engineering LH S-ZL 126 | later scrapped 41 Gerhard Mitter | Herbert Linge | Fritz Huschke von Hanstein 28 - 002 2.0 Porsche System Engineering LH S-ZD 946 | scrapped in Dec 1967 11.06.1967 24 Heures du Mans Le Mans 40 Gerhard Mitter | Jochen Rindt DNF DNF 003 2.0 Porsche System Engineering LH S-ZL 691 | red nose | QF 22 41 Jo Siffert | Hans Herrmann 5 1 004 2.0 Porsche System Engineering LH S-ZL 692 | green nose | QF 21 30.07.1967 BOAC International 500 Brands Hatch 12 Hans Herrmann | Jochen Neerpasch (replaced Kurt Ahrens) 4 4 007 2.2 Porsche System Engineering KH S-ZL 855 | modified tail | QF 12 00.10.1967 Porsche private test Nürburgring - Hans Herrmann - - 007 2.2 - KH Südschleife | completed 600 km Late 1967 Porsche private test Monza - Hans Herrmann - - 007 2.2 - KH Full circuit with chicanes 08.12.1967 Porsche press day Hockenheim - Ludovico Scarfiotti | Jo Siffert - - 007 2.2 - KH Kurz Heck | Short Tail - Unknown - - --- 2.2 - LH 14.12.1967 Porsche private test Daytona - Hans Herrmann | Rolf Stommelen | Jochen Neerpasch - - 011 2.2 - LH Accident Neerpasch | car damaged Copyright © Rob Semmeling -

1963 •1º Rally Sardegna
1963 •1º Rally Sardegna - Alfa Romeo Giulietta SZ 1964 •1º Bolzano-Mendola - Fiat Abarth 1000 •1º Trofeo Micangeli - Fiat Abarth 1000 •1º Trofeo Lumezzane - Fiat Abarth 1000 1967 •3º Campionato Europeo Turismo - Fiat Abarth 1000 1968 •1º Colle di Nizza - Fiat Abarth 1000 •1º V.Veneto-Cansiglio - Abarth 1000SP •1º Coppa Acqua Cerelia - Abarth 1000SP •3º 500 km Nürburgring - Abarth 1600SP 1969 •1º GP del Mugello - Abarth 2000 •1º Campionato Europeo Montaga - Abarth 2000 1970 •1º GP del Mugello - Abarth 2000 •1º Cesana-Sestriere - Abarth 2000 •3º 24 ore Daytona - Ferrari 512S •4º 1000 km Monza - Ferrari 512S 1971 •1º Imola - Ferrari 512M •1º Vallelunga - Abarth 2000 1972 •1º 1000 km di Spa (mit Brian Redman) - Ferrari 312 PB •1º Targa Florio (mit Sandro Munari) - Ferrari 312 PB •1º Campionato Europeo Sport 2000 •1º 500 km Imola - Ferrari 312 PB •1º 9 ore Kylami - Ferrari 312 PB •1° Brescia-Monte Maddalena - Abarth 3000 1972 Scuderia Ferrari •6º GP Gran Bretagna - Ferrari 312 B2 1973 •2º 1000 km Nürburgring - Ferrari 312 PB •2º 24 ore Le Mans - Ferrari 312 PB 1973 Scuderia Ferrari •4º GP Brasile - Ferrari 312 B2 •4º GP Sudafrica - Ferrari 312 B2 •7º GP Francia - Ferrari 312 B3 •7º GP Austria - Ferrari 312 B3· 1974 •1º 1000 km di Monza - Alfa Romeo 33 •3º GP Presidente Medici - Iso Williams •4º GP Italia - Iso Williams •6º GP Sud Africa - Iso Williams 1975 •1º 800 km di Digione - Alfa Romeo 33 •1º 1000 km di Monza - Alfa Romeo 33 •1º 1000 km di Pergusa - Alfa Romeo 33 •1º 1000 km del Nürburgring - Alfa Romeo 33 •1º Targa Florio (mit Nino Vaccarella) -

Pp74-81 Motorsportx Bmwfin
Circuit CROSSFIRE Want to get behind the wheel of a racing car? You already are. Jesse Crosse on how track technology is transforming BMW road cars 74 BMWMagazine BMWMagazine 75 Circuit The look on Wolfgang Nehse’s face is beginning to motorsport-inspired technology could be transferred to worry me. At dinner the night before he was relaxed but the cars we drive every day on ordinary roads. now his eyes have narrowed, the corners of his mouth BMW’s history is full of examples of how its road turned down into a snarl. He’s staring through the M3’s cars have been adapted for racing. What is, perhaps, less windscreen, his gaze fixed on a point near the end of the appreciated is how lessons learned from track success have racetrack’s start-finish straight. He reaches for the stubby been ploughed back into the next generation of road cars to aluminium-trimmed lever, pushes it forward hard and improve the bloodline. And it’s not just M cars. Deliver the mashes the throttle pedal into the carpet. merest sliver from a 316i to a mechanic and he’ll find The M3’s straight-six engine barks a swift response and motorsport DNA. within half a second is howling and snarling defiance at Today, there are as many motorsport-inspired options on the hidden electronics keeping the wheels stationary on the road cars as there are colours. You can now have sequential smooth tarmac. I just have time for a nervous tweak of my paddle-shift gearboxes in dozens of models – not to mention safety harness before the clutch finally bites. -

Targapedia Ottobre.Indd
www.siciliamotori.it CAP. XVII La Targa non è più prova mondiale già da due anni e in una Floriopoli quasi disabitata il Preside volante taglia vittorioso il suo terzo traguardo Allegato al numero di ottobre 2013 di Sicilia Motori (Registrazione tribunale di Palermo n° 7/97del 25/26 febbraio 1997) Direttore Responsabile: Dario Pennica Copia omaggio non in vendita separatamente dalla rivista Testi: Enzo Manzo - Foto: Piergiorgio Ferreri ed Effe Model (per gentile concessione Targapedia.com) SiciliaMotori . CXXXVII 58 a - 6 1 a edizione 1974-1977 LE ULTIME EDIZIONI DI VELOCITÀ CHIUSO IL CICLO “MONDIALE”, LA TARGA RIMANE ANCORA NEL CUORE DEI TANTI APPASSIONATI. LA GARA PERÒ FA I CONTI CON L’INCIDENTE DI CIUTI CHE COSTA LA VITA A DUE SPETTATORI CXXXVIII . SiciliaMotori Gabriele Ciuti guida on l’edizione del 1973 si chiude il ciclo l’Osella priva del cofano “mondiale” della Targa Florio iniziato nel motore e dell’alettone. 1955. Ma in quest'anno un’altra “illustre” Il pilota marchigiano scompare dal Mondiale Marche: la Ferra- uscirà di strada ri. E la competizione che per circa vent’an- travolgendo il pubblico. C ni è stata protagonista assoluta dello sport automo- Sotto: l’inedita coppia bilistico cede il primato alla Formula 1 di Bernie Larrousse-Ballestrieri Ecclestone. Le ultime edizioni della Targa Florio di regala dopo 20 anni velocità, valide ora solo per il Campionato Italiano la quarta vittoria Velocità, si corrono in tono minore: mancano le sfi de alla Lancia dirette tra le grandi case automobilistiche e i loro pi- loti in lizza per il titolo, e anche il pubblico diserta l’appuntamento guardando sempre con maggiore attenzione al Rallye Internazionale di Sicilia. -

The FD0”X” Fittipaldi Years - Innovation Despite the Results by Darren Galpin
The FD0”X” Fittipaldi Years - Innovation despite the results by Darren Galpin When one thinks of the Copersucar Fittipaldi FD cars, the usual reaction is to dismiss them, and to marvel at the fact the Emerson Fittipaldi could waste his last years in F1 in such cars. But as usual, there is more to this tale than meets the eyes, and more than is usually reported. The build-up In 1969, Emerson Fittipaldi was in Britain pursuing a career in Formula Ford. Needing a bit of a help with his car, he raised some cash and asked a friend, Richard Divila, to come over and give him a hand. Richard Divila, a Brazilian national who had an English mother, was a technical graduate who was planning to do a PhD in automotive design and had a background in aerospace. He went to England planning to spend two weeks helping out Emerson, and embarked on a lifelong career instead. Emerson’s brother Wilson also moved to England, and together they set up their own team to enter into F3 and F2, Richard becoming “team manager, engineer, secretary, truckie, mechanic, chief cook and bottle washer”, progressing through various F3 and F2 Lotus’s, and acting as Emerson’s private engineer in F1. It was a busy time, as they were running almost every weekend. If they weren’t running in F1 or F2, they ran in sportscars and GT’s instead. By the time Wilson moved on to Bernie Ecclestone’s Brabham, Divila was busy modifying the Fittipaldi team cars to what they called “Fittipaldi spec”. -

Champagne! in Victory...*
Champagne! In Victory...* Celebrating the 50th anniversary of the spraying of champagne by a sporting victor A Top Gear Special Edition Written by TSCC members, compiled by Colin Allerdice & edited by Stephen Knox * “Champagne! In victory one deserves it, in defeat one needs it.” - Napoleon Bonaparte ISSN 2207-9327 1 Contents Introduction Page 3 Alfa Romeo at Le Mans Page 7 Ford GT40 and the Le Mans 24 Hour Classic Page 10 Fabulous Ford GT40 1964 to 1969 Page 12 Ferrari’s First Win Page 13 Jaguar XK120 at Le Mans Page 15 Jaguar at Le Mans from my perspective – Geoff Scott Page 17 Mercedes-Benz Wins Page 18 Jaguar Le Mans 1950s Domination Page 20 Jaguar D-Type Page 24 Aston Martin DBR2 Page 26 The Birdcage Maserati Page 28 Ferrari’s last win for a front-engined V12 Page 30 Alfa Romeo Giulia TZ Page 32 Bring it On Page 34 Ferrari 250LM Page 37 Ford GT40 replica Page 40 Safir GT40 Mk V Continuation Page 42 Porsche and Le Mans Page 44 Mazda Wins in 1991 Page 46 McLaren F1 GTR Page 48 1999 BMW Wins Page 50 BMW Sports Car Fact File Page 52 TSCC Members’ Page and Photos Page 54 2 THOROUGHBRED SPORTS CAR CLUB The Thoroughbred Sports Car Club’s (“TSCC”) theme for its display at the 2017 Shannon’s Sydney Classic was on “the day that changed sport forever” – not just motor sport but ALL sport. It has been fifty (50) years since Dan Gurney and A.J. Foyt won the 1967 24 Hours of Le Mans in a Ford GT40 Mark IV, and Gurney, on the rostrum, spontaneously shook a bottle of Moet & Chandon and sprayed it on everyone in his vicinity.