Erudizione E Creatività Di Bruno Maier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
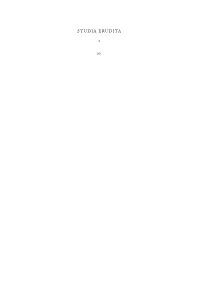
2012.Il Veliero Di Quasimodo. in Miscellanea Baroni Copy.Pdf
STUDIA ERUDITA * 16. Comitato promotore Anna Bellio, Cristina Benussi, Giorgio Cavallini, Ilaria Crotti, Davide De Camilli, Edoardo Esposito, Giuseppe Farinelli, Luigi Fontanella, Pierantonio Frare, Pietro Frassica, Vicente Gonzáles Martín, Renata Lollo, Bortolo Martinelli, Ermanno Paccagnini, Maria Pagliara, Paola Ponti, Angelo R. Pupino, Andrea Rondini, Giuseppe Savoca, Fabrizio Serra Hanno partecipato al lavoro redazionale Maria Cristina Albonico, Silvia Assenza, Paola Baioni, Elisa Bolchi, Rita Gianfelice, Enrica Mezzetta, Federica Millefiorini, Anna Pastore, Paola Ponti, Barbara Stagnitti, Francesca Strazzi LETTERATURA E OLTRE Studi in onore di Giorgio Baroni a cura di paola ponti PISA · ROMA FABRIZIO SERRA EDITORE MMXII La pubblicazione di questo volume ha ricevuto il contributo finanziario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sulla base di una valutazione dei risultati della ricerca in essa espressa (anno 2011) * Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge. Proprietà riservata · All rights reserved © Copyright 2012 by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale, Edizioni dell’Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa, -

C O N N E C T I V I
Generali Group Magazine since 1893 Number 6 – Series 13 – March 2017 CONNECTIVITY connectivity CONNECTIVITY Everything is shrouded in a cloud of data and we can be anywhere, anytime. The Internet has upended our lifestyle and our interactions with others, connecting us in real time with remote contexts and faraway cultures. We have torn down physical barriers and obtained access to products and services everywhere, and we have built virtual communities with people we have never met. As individuals, employees and consumers, we have gained access to extraordinary opportunities. All this is possible thanks to the ease and immediacy that enable us to share information. Perhaps now we are just beginning to recognize the huge changes that have happened since the invention of the Internet over 25 years ago. Are we sure we can anticipate where connectivity will lead us to in the near future? —ak. OPENING REMARKS OPENING REMARKS Connectivity 99% of interesting things have“ not yet been invented” by Simone Bemporad —Sebastian Thrun Editor in Chief Connectivity has caught us up in rise of China and India, once among But in the world of complex Some Luddites consider connectivity a revolution that has reshaped the world’s poorest nations. connection systems technology and digitalisation as threats to job everything about how we live, love, is constantly evolving as this special creation. That is not really true. work, play, shop and share – how our There are many countries that are in the issue of il bollettino will show. Value creation doesn’t come from very hearts and minds encounter the course of transforming from a wholly Devoted to the various aspects of routine tasks or monotonous repetition world around us. -

'Outside Perspective' to the Works of Kosovel by Illustrating And
K.Pizzi, 17/11/07, 12:52 [article published in Kosovelova Poetika/ Kosovel’s Poetics, special issue of Primerjalna knjizevnost 28(2005), pp. 239-249] ‘QUALE TRIESTINITA`?’: VOICES AND ECHOES FROM ITALIAN TRIESTE Abstract: In focusing on Italian Trieste and, in particular, on as large as possible a corpus of Triestine poetry contemporary to S.Kosovel, my paper provides a perspective that is peripheral and ‘outside’. Special attention is paid to the Futurist avant-garde: the Futurist leader Marinetti considered Trieste as Futurist city par excellence and the first Futurist soirees took place at Teatro Rossetti between 1909 and 1910. Futurism attracted a large group of local artists, some of whom (e.g. Carmelich and Cernigoj) were personally known by and became close to Kosovel. The poets Sanzin and Miletti espoused enthusiastically the Futurist linguistic experimentalism, as well as the movement’s national/nationalist tendencies. Poetry of national and romantic inspiration is also of fundamental importance: Slataper’s vitalist approach to the rugged Karst region, though pre-Great War, provides scope for comparative approaches. Nationalist poetry, much of which officially compromised with the Fascist regime (Cambon, Corraj, Alma Sperante), is equally integral to the Triestine cultural landscape of the 1920s and ‘30s. By shedding light on a significant portion of poetry in Italian arising from the vibrant, if largely hostile, cultural environment of Trieste, my paper invites an implicit rather than explicit assessment of Kosovel’s role and contribution to the European avant-garde. 1 K.Pizzi, 17/11/07, 12:52 ‘QUALE TRIESTINITA`?’: VOICES AND ECHOES FROM ITALIAN TRIESTE In re-evaluating as large as possible a corpus of Triestine poetry in Italian, my article intends to court the poetics and production of Šrečko Kosovel. -
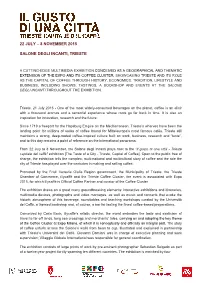
Cs Il Gusto Di Una Citta' Trieste Capitale Del Caffe
22 JULY – 8 NOVEMBER 2015 SALONE DEGLI INCANTI, TRIESTE A CUTTING-EDGE MULTIMEDIA EXHIBITION CONCEIVED AS A GEOGRAPHICAL AND THEMATIC EXTENSION OF THE EXPO AND ITS COFFEE CLUSTER, SHOWCASING TRIESTE AND ITS ROLE AS THE CAPITAL OF COFFEE THROUGH HISTORY, ECONOMICS, TRADITION, LIFESTYLE AND BUSINESS, INCLUDING SHOWS, TASTINGS, A BOOKSHOP AND EVENTS AT THE SALONE DEGLI INCANT I THROUGHOUT THE EXHIBITION. Trieste, 21 July 2015 - One of the most widely-consumed beverages on the planet, coffee is an elixir with a thousand aromas and a sensorial experience whose roots go far back in time. It is also an inspiration for innovation, research and the future. Since 1719 a freeport for the Hapsburg Empire on the Mediterranean, Trieste’s wharves have been the landing point for millions of sacks of coffee bound for Mitteleuropa's most famous cafés. Trieste still maintains a strong, deep-rooted coffee-inspired culture built on work, business, research and “taste”, and to this day remains a point of reference on the international panorama. From 22 July to 8 November, the Salone degli Incanti plays host to the “Il gusto di una città - Trieste capitale del caffè" exhibition [The Taste of a City - Trieste, Capital of Coffee]. Open to the public free of charge, the exhibition tells the complex, multi-national and multicultural story of coffee and the role the city of Trieste has played over the centuries in making and selling coffee. Promoted by the Friuli Venezia Giulia Region government, the Municipality of Trieste, the Trieste Chamber of Commerce, illycaffè and the Trieste Coffee Cluster, the event is associated with Expo 2015, for which illycaffè is Official Coffee Partner and curator of the Coffee Cluster. -

It529/2000-2001 Mainstream and Marginality: the Literature of Trieste
IT529/2000-2001 MAINSTREAM AND MARGINALITY: THE LITERATURE OF TRIESTE -Part II (Final Year) Course code: IT529 -1 Unit, Teaching Period I (weeks 1-12) Title: Mainstream and Marginality in Italian Literature: The Literature of Trieste Department: S.E.C.L. (Italian) Convenor and Teacher: Dr.Katia Pizzi ; email: [email protected]; office: CNW 219; ext.7909. OFFICE HOURS: Tuesday 12-13 and Thursday 4-5 Relationship to Other Courses: A sound knowledge of Italian is a prerequisite for this course. Students must be finalists. The course is not compulsory and is available as a wild course. Aims and objectives: The course is designed as an introduction to Italian literature of the late XIX and XX century in a regional perspective. The focus will be on the city of Trieste and its hinterland. Students will concentrate on the close reading of texts in Italian and will develop skills to deal with different kinds of textual material: narrative fiction, poetry in Italian and dialect, film. Handbook entry: This course focuses on possibily the most interesting region in Italy on the North-Eastern border. The interest derives from the great variety of literary influences experienced locally, the anxiety generated by the proximity of the border, and the ‘difficult’ relationship established with the culture of the motherland Italy. The emphasis will be on literature, culture and history. Though not specifically linguistic, local varieties (i.e. dialects) will also be dealt with. Students will have a chance to become acquainted with a wide range of textual material: film, poetry both in Italian and dialect and narrative fiction. -

Kampert, Magdalena Anna (2018) Self-Translation in 20Th-Century Italian and Polish Literature: the Cases of Luigi Pirandello, Maria Kuncewiczowa and Janusz Głowacki
Kampert, Magdalena Anna (2018) Self-translation in 20th-century Italian and Polish literature: the cases of Luigi Pirandello, Maria Kuncewiczowa and Janusz Głowacki. PhD thesis. https://theses.gla.ac.uk/71946/ Copyright and moral rights for this work are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This work cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Enlighten: Theses https://theses.gla.ac.uk/ [email protected] Self-translation in 20th-century Italian and Polish literature: the cases of Luigi Pirandello, Maria Kuncewiczowa and Janusz Głowacki Magdalena Anna Kampert Submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of PhD School of Modern Languages and Cultures College of Arts University of Glasgow September 2018 3 Abstract This thesis examines the phenomenon of self-translation in two different cultural contexts: the Italian context of self-translation within national borders and the Polish context of self-translation in displacement. It focuses on four case studies: Luigi Pirandello’s self-translations of ’A birritta cu ’i ciancianeddi (1916) and Tutto per bene (1920), Maria Kuncewiczowa’s self-translation of Thank you for the Rose (1950-1960) and Janusz Głowacki’s assisted self-translation of Antygona w Nowym Jorku (1992). -

M08222211* JESENSKI IZPITNI ROK Višja Raven ITALIJANŠČINA Izpitna Pola 1
Šifra kandidata: Državni izpitni center *M08222211* JESENSKI IZPITNI ROK Višja raven ITALIJANŠČINA Izpitna pola 1 A) Bralno razumevanje B) Poznavanje in raba jezika Sobota, 30. avgust 2008 / 80 minut (40 + 40) Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik. Kandidat dobi dva ocenjevalna obrazca. SPLOŠNA MATURA NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalna obrazca). Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Časa za reševanje je 80 minut. Priporočamo vam, da za reševanje vsakega dela porabite 40 minut. Izpitna pola vsebuje 3 naloge v delu A in 5 nalog v delu B. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 70, od tega 30 v delu A in 40 v delu B. Za posamezno nalogo je število točk navedeno v izpitni poli. Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič (0) točkami. Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha. Ta pola ima 12 strani, od tega 1 prazno. © RIC 2008 2 M082-222-1-1 A) BRALNO RAZUMEVANJE (Priporočeni čas reševanja: 40 minut) 1. besedilo Leggete attentamente le seguenti descrizioni. VISITA GUIDATA ALLE CASE DI 6 ARTISTI A Andrea Mantegna – Il grande artista del Rinascimento soggiornò a lungo a Mantova, dove dipinse, tra gli altri, i celebri Cristo morte, San Sebastiano e Madonna della Vittoria. -

Il Portolano A
il Portolano A. XIII - Gennaio / Settembre 2007 PERIODICO TRIMESTRALE DI LETTERATURA N. 49/50 - € 8,00 SABAEDITORIALE tempo (si pensi a Soffici, Papini, Prezzolini, solo per citarne alcu- ni): “La cricca letteraria di Fi- SABA renze – scriverà nel gennaio 1905 – mi muove guerra ad ol- dai territori tranza; usando naturalmente di tutti i mezzi della mediocrità. Il si- della solitudine lenzio, le lodi peggiori di ogni (1883-1957) biasimo, la calunnia e via discor- f.g. rendo…”. E la sua rarefatta colla- borazione “vociana” (1912) sarà avvertita come “male accolta e ell’agosto 1957 Umberto con troppe riserve”. NSaba ci lasciava. Si spengeva A Firenze tornerà a 24 anni, una delle più autorevoli voci del- passandovi quasi un anno di “fer- la poesia italiana ed europea del ma” (pur alternandosi con Trieste) Novecento. nel convento di Monteoliveto, da Il “Portolano” lo ha voluto ri- sempre “Sezione di Ospedale Mi- cordare, non solo per la coinci- litare” (per malattie particolari), denza cinquantenaria, ma anche rubricato nell’amministrazione del per le tracce fiorentine che con- Regio Esercito, quale “Deposito corsero alla sua riflessione esi- di Monte Uliveto”, un complesso stenziale e poetica. architettonico riconducibile alla Saba fu a Firenze fra il 1905 e paternità michelozziana. il 1908 (tra l’aprile e l’ottobre L’esperienza militare (consu- 1907 è a Monte Uliveto); poi nel mata da Saba in periodo di pace) 1911, poco dopo sposato, e nel coinciderà con la retorica del bel- 1915 è documentato in una foto licismo: con Virgilio Giotti a San Felice a Umberto Saba. Ema (fra il Poggio Imperiale e il “Qui andiamo sì, ma a tanta no- vicino Galluzzo); vi tornò dopo stra guerra l’8 settembre del ’43, costretto a manca il nemico che ci miri al SABA / GUAGNINI,DEDENARO,CARRAI, fuggire da Trieste per il timore cuore, PESCINI,TARANI,GRISANCICH,SODOMACO, delle recrudescenze naziste anti- manca la morte che il fuggiasco atterra, BRANDALISE,ALBISANI,SALIBRA,CRESCENTE, semite. -

Italian 2053
Italian 2053 (221) Introduction to Italian Cinema: Sex and Politics in Italian Cinema Instructor: Dana Renga ([email protected]) M 2:15-5:00 #3420 Pre-Requisites: Not open to students with credit for 221. GE VPA and diversity global studies course. Course Description: In Italian culture sex and politics are intimately entwined. In this course we will examine the crossovers between “private” arenas of home and family and “public” realms of politics, the economy and religion. This course presents students with an overview of Italian cinema from the last seventy years and looks in detail at films by ten seminal Italian directors. We will touch upon major movements in Italian film history, including Neorealism, commedia all’italiana, engaged or political cinema and new Italian comedy. Topics to be addressed include: Unification, Italian fascism, the so-called “economic miracle,” Italy’s not-so “Dolce vita,” regional identity and racism, gender relations, the mafia, political corruption, and terrorism. Taught in English. Italian 2102 (202) Contemporary Italian Society Instructors: TBA M W F 9:10-10:05 #3421 Janice Aski ([email protected]) M W F 9:10-10:05 #3422 Pre-Requisites: A grade of C- or above in 1103, or permission of the instructor. Not open to students with credit for 202. FL Admis Cond course. Course Description: In this course you will learn about a variety of aspects of Italian contemporary society and culture, while at the same time focusing on the four language skills: listening, reading, writing, and speaking. Since you are transitioning from the elementary to the intermediate level, at this point more emphasis will be placed on developing your reading skills so that you will be exposed to a lot of Italian in authentic contexts. -

TRIESTE Storia - Arte - Cultura E Tradizioni
TRIESTE Storia - Arte - Cultura e Tradizioni "Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore; come un amore con gelosia" Umberto Saba Indice La storia... dalle origini ai nostri giorni ............................................................ pag.2 Le voci letterarie più significative: ............................................................. pag.3 Virgilio Giotti Giani Stuparich Scipio Slataper Italo Svevo L'irredentismo, la Grande Guerra e il passaggio all'Italia ............................... pag. 6 Redipuglia: ........................................................................................................... pag. 7 Giuseppe Ungaretti La comunità ebraica di Trieste ........................................................................... pag. 9 Risiera di San Sabba: ........................................................................................... pag. 10 Umberto Saba Foiba di Basovizza ............................................................................................... pag. 11 Città ...................................................................................................................... pag. 12 Castelli .................................................................................................................. pag. 13 Luoghi di culto non cattolici ............................................................................... pag. 15 Monumenti .......................................................................................................... -

Cinque Lettere Di Eugenio Montale a Mario Fubini Carlo Alberto Girotto
Cinque lettere di Eugenio Montale a Mario Fubini Carlo Alberto Girotto To cite this version: Carlo Alberto Girotto. Cinque lettere di Eugenio Montale a Mario Fubini. Ellisse. Studi storici di letteratura italiana, L’Erma di Bretschneider, 2012, VII, pp.211-228. hal-01408814 HAL Id: hal-01408814 https://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/hal-01408814 Submitted on 5 Dec 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. L’Ellisse Studi storici di letteratura italiana Anno VII 2012 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER L’Ellisse, VII Studi storici di letteratura italiana Copyright 2012 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER Via Cassiodoro, 19 - Roma www.lerma.it - [email protected] Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell’Editore. L’Ellisse : studi storici di letteratura italiana. - 1(2006)- . - Roma : «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2006 .- v. ; 24 cm Annuale ISSN 1826-0187 CDD 21. 850.5 1. Letteratura italiana - Periodici INTERAZIONI MONTALIANE a cura di Silvia Chessa e Massimiliano Tortora Interazioni montaliane a cura di Silvia Chessa e Massimiliano Tortora SAGGI E NOTE Massimiliano Tortora, L’incipit di Ossi di seppia. -

Italian-Writers-Petition-For-Pound.Pdf
1 DOCUMENTARY –––––––––––––––––––– Italian Writers Petition for Pound, 1956-1957 by Carlo Pulsoni [Carlo Pulsoni published the short essay "Liberate il poeta Pound" in the 20 March issue of Atlante, for which Massimo Bacigalupo has very graciously provided a translation into English. The original essay can be read at http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Liberate_il_poeta_Pound.html. Many thanks to the author for permission to reproduce the piece here.] Twenty years have passed since the death of Vanni Scheiwiller, a "useless publisher of books and micro-books," as he loved to define himself. If his editorial merits are well known, perhaps less known is his role as promoter of the Italian petition to free Ezra Pound from the St. Elizabeths criminal asylum, where Pound had been imprisoned since the end of 1945. Thanks to the archival papers of the Fondo Scheiwiller stored in the APICE Center of the University of Milan, the salient stages of the story can be reconstructed. The appeal should have come out on Pound's seventieth birthday (October 30, 1955), but various circumstances prevented this. The failure was mitigated by the publication in the Corriere della Sera of an article by Giovanni Papini with an eloquent title: “We ask for the pardon of a poet.” In the following months Vanni goes back to work on the petition, hoping to deliver it to the American embassy, as he writes to Giuseppe Ungaretti in the first days of April 1956. In reality the delivery was to take place only in the month of August and was to have, in addition to Diego Valeri and Sergio Solmi as promoters, the following signatories: G.