Il Portolano A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
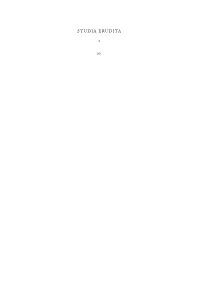
2012.Il Veliero Di Quasimodo. in Miscellanea Baroni Copy.Pdf
STUDIA ERUDITA * 16. Comitato promotore Anna Bellio, Cristina Benussi, Giorgio Cavallini, Ilaria Crotti, Davide De Camilli, Edoardo Esposito, Giuseppe Farinelli, Luigi Fontanella, Pierantonio Frare, Pietro Frassica, Vicente Gonzáles Martín, Renata Lollo, Bortolo Martinelli, Ermanno Paccagnini, Maria Pagliara, Paola Ponti, Angelo R. Pupino, Andrea Rondini, Giuseppe Savoca, Fabrizio Serra Hanno partecipato al lavoro redazionale Maria Cristina Albonico, Silvia Assenza, Paola Baioni, Elisa Bolchi, Rita Gianfelice, Enrica Mezzetta, Federica Millefiorini, Anna Pastore, Paola Ponti, Barbara Stagnitti, Francesca Strazzi LETTERATURA E OLTRE Studi in onore di Giorgio Baroni a cura di paola ponti PISA · ROMA FABRIZIO SERRA EDITORE MMXII La pubblicazione di questo volume ha ricevuto il contributo finanziario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sulla base di una valutazione dei risultati della ricerca in essa espressa (anno 2011) * Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge. Proprietà riservata · All rights reserved © Copyright 2012 by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma. Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale, Edizioni dell’Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa, -

50 Anni Di Friuli a Roma
Prima di copertina (dal basso in alto): Carnelutti, Desio, Moselli, Rubbia, Afro, Mirko, Angeli, Pasolini, Turoldo, Astaldi. Retro di copertina (dall’alto in basso): Tondo, Tessitori, Valerio, Toros, Leicht, Sartogo, Galanti, Zucchet, Girolami, Degano. Mostra Cinquant’anni di Friuli a Roma Una presenza dal 1945 Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed il Patrocinio di: Senato della Repubblica Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Regione Lazio Comune di Roma Galleria “L’Agostiniana” Roma, piazza del Popolo, 12 11 aprile - 5 maggio 2002 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Fogolâr Furlàn di Roma Friuli nel Mondo Realizzazione e stampa Arti Grafiche Friulane SpA Tavagnacco, Udine Regione Friuli Venezia Giulia Regione Lazio Comune di Roma Astaldi S.p.A. - Roma Generali - Assicurazioni Generali Banca Intesa - Milano Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Udine Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone (CRUP) Faber S.p.A. - Cividale del Friuli Dal Fari - azienda agricola - Cividale del Friuli Telit Mobile Terminals S.p.A. - Trieste Consorzio Latterie Friulane Prosciutto di San Daniele Mostra “Cinquant’anni di Friuli a Roma” Comitato scientifico: Giovan Battista Altan, storico; Ugo Bari, generale; Giuseppe Bergamini, dir. Civici Musei Udine; Ferruccio Clavora, dir. Friuli nel Mondo; Antonio Clemente, giornalista; Fausto Corrubolo, maestro; Damiano Damiani, regista; Licio Damiani, critico; Ermes Disint, giornalista; Piero Fortuna, giornalista; Rodolfo Grasso, architetto; Luciano Pettoello Mantovani, docente; Bruno Martinis, Accademico dei Lincei; Carlo Mattiussi, ingegnere; Franco Mistretta, ministro; Carlo Mittoni, generale; Giuliana Morandini, scrittrice; Stanislao Nievo, scrittore; Piero Nigris, magistrato; Mario Padovan, critico; Leonardo Pascoletti, architetto; Gian Luigi Pezza, avvocato; Alberto Picotti, scrittore; Gianfranco Plenizio, maestro; Claudio Pighin, docente; Francesco Pittoni, ingegnere; Mario Quargnolo, critico; Isabella Reale, dir. -

Il Premio Viareggio
Il Premio Viareggio Se il Bagutta è il decano dei premi letterari italiani, il secondo per longevità è il Premio Viareggio, fondato nel 1929 da Leonida Rèpaci, con il contributo di Alberto Colantuoni e Carlo Salsa. Come lo Strega, anche il Viareggio è stato contestato (nel 1968 Italo Calvino lo rifiutò con un telegramma in cui sosteneva di ritenere ormai conclusa l’epoca dei premi letterari) ma nonostante ciò oggi appare ancora ben vitale. L’obiettivo, come scrisse il fondatore, era quello di creare una manifestazione di più vasto respiro rispetto al Bagutta, nato pochi anni prima, attirando “le simpatie di coloro che la dittatura stava isolando”. Tale obiettivo non sfuggì al regime, che presto mise sotto controllo l’istituzione; la presenza di un personaggio come Rèpaci, giornalista notoriamente antifascista, era di per sé sospetta. Interrotto allo scoppio della seconda guerra mondiale, il Premio rinacque nel dopoguerra per volontà del suo fondatore che ne rimase presidente fino alla morte, nel 1985. Gli successero Natalino Sapegno e Cesare Garboli. Dopo un periodo di presidenza di Rosanna Bettarini, ora a guidare il Premio è Simona Costa. La giuria è attualmente costituita da un gruppo stabile di una ventina di addetti/e ai lavori (accademici e accademiche, scrittori, scrittrici, giornalisti /e ecc.). L’analisi dei risultati del Premio non è semplicissima, dal momento che, fin dall’inizio, le giurie hanno distribuito i riconoscimenti senza attenersi a una norma prestabilita, creando con molta libertà una grande quantità di segnalazioni, medaglie, targhe diverse ed estemporanee, cosa che ha dato adito a qualche critica. Tenendo conto solo delle opere di narrativa, poesia e saggistica (e non dei premi minori, delle opere prime o dei “premi del presidente”) su 247 premi calcolati complessivamente per le tre sezioni, 213 sono stati consegnati a uomini, solo 34 a donne: una percentuale che non arriva al 14%. -

History and Emotions Is Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena
NARRATING INTENSITY: HISTORY AND EMOTIONS IN ELSA MORANTE, GOLIARDA SAPIENZA AND ELENA FERRANTE by STEFANIA PORCELLI A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Comparative Literature in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2020 © 2020 STEFANIA PORCELLI All Rights Reserved ii Narrating Intensity: History and Emotions in Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena Ferrante by Stefania Porcell i This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Comparative Literature in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. ________ ______________________________ Date [Giancarlo Lombardi] Chair of Examining Committee ________ ______________________________ Date [Giancarlo Lombardi] Executive Officer Supervisory Committee: Monica Calabritto Hermann Haller Nancy Miller THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT Narrating Intensity: History and Emotions in Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena Ferrante By Stefania Porcelli Advisor: Giancarlo Lombardi L’amica geniale (My Brilliant Friend) by Elena Ferrante (published in Italy in four volumes between 2011 and 2014 and translated into English between 2012 and 2015) has galvanized critics and readers worldwide to the extent that it is has been adapted for television by RAI and HBO. It has been deemed “ferocious,” “a death-defying linguistic tightrope act,” and a combination of “dark and spiky emotions” in reviews appearing in popular newspapers. Taking the considerable critical investment in the affective dimension of Ferrante’s work as a point of departure, my dissertation examines the representation of emotions in My Brilliant Friend and in two Italian novels written between the 1960s and the 1970s – La Storia (1974, History: A Novel) by Elsa Morante (1912-1985) and L’arte della gioia (The Art of Joy, 1998/2008) by Goliarda Sapienza (1924-1996). -

C O N N E C T I V I
Generali Group Magazine since 1893 Number 6 – Series 13 – March 2017 CONNECTIVITY connectivity CONNECTIVITY Everything is shrouded in a cloud of data and we can be anywhere, anytime. The Internet has upended our lifestyle and our interactions with others, connecting us in real time with remote contexts and faraway cultures. We have torn down physical barriers and obtained access to products and services everywhere, and we have built virtual communities with people we have never met. As individuals, employees and consumers, we have gained access to extraordinary opportunities. All this is possible thanks to the ease and immediacy that enable us to share information. Perhaps now we are just beginning to recognize the huge changes that have happened since the invention of the Internet over 25 years ago. Are we sure we can anticipate where connectivity will lead us to in the near future? —ak. OPENING REMARKS OPENING REMARKS Connectivity 99% of interesting things have“ not yet been invented” by Simone Bemporad —Sebastian Thrun Editor in Chief Connectivity has caught us up in rise of China and India, once among But in the world of complex Some Luddites consider connectivity a revolution that has reshaped the world’s poorest nations. connection systems technology and digitalisation as threats to job everything about how we live, love, is constantly evolving as this special creation. That is not really true. work, play, shop and share – how our There are many countries that are in the issue of il bollettino will show. Value creation doesn’t come from very hearts and minds encounter the course of transforming from a wholly Devoted to the various aspects of routine tasks or monotonous repetition world around us. -

«Si Risponde Lavorando». Lettere 1941-1992
BIBLIOTECA DI STUDI DI FILOLOGIA MODERNA ISSN 2420-8361 (ONLINE) – 47 – DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, PSICOLOGIA Università degli Studi di Firenze Coordinamento editoriale Gianfranco Bandini, Andrea Guazzini, Emiliano Macinai Ilaria Moschini, Donatella Pallotti, Beatrice Töttössy BIBLIOTECA DI STUDI DI FILOLOGIA MODERNA Collana Open Access fondata nel 2004 dal Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di Firenze Direttore Beatrice Töttössy Comitato scientifico internazionale (http://www.fupress.com/comitatoscientifico/biblioteca-di-studi-di-filologia-moderna/23) Enza Biagini (Professore Emerito), Nicholas Brownlees, Martha Canfield, Richard Allen Cave (Emeritus Professor, Royal Holloway, University of London), Piero Ceccucci, Massimo Ciaravolo (Università Ca’ Foscari Venezia), John Denton, Anna Dolfi (Professore Emerito), Mario Domenichelli (Professore Emerito), Maria Teresa Fancelli (Professore Emerito), Massimo Fanfani, Paul Geyer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Ingrid Hennemann, Sergej Akimovich Kibal’nik (Institute of Russian Literature [the Pushkin House], Russian Academy of Sciences; Saint-Petersburg State University), Ferenc Kiefer (Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences; Academia Europaea), Michela Landi, Murathan Mungan (scrittore), Stefania Pavan, Peter Por (CNRS Parigi), Gaetano Prampolini, Paola Pugliatti, Miguel Rojas Mix (Centro Extremeño de Estudios y Cooperación Iberoamericanos), Giampaolo Salvi (Eötvös Loránd University, Budapest; -

Premi Letterari Italiani E Questioni Di Genere
Premi letterari italiani e questioni di genere Loretta Junck Toponomastica femminile Riassunto Si prenderà in esame il numero dei riconoscimenti ottenuti dagli scrittori e dalle scrittrici nei più importanti premi letterari italiani (Strega, Campiello, Viareggio, Bancarella, Bagutta, Calvino) con lo scopo di valutare attraverso un’analisi comparativa sia il gap di genere esistente in questo campo specifico, sia l’evoluzione del fenomeno nel tempo, verificando la presenza delle scrittrici nel canone letterario del Novecento e nelle intitolazioni pubbliche. Obiettivo della ricerca è ottenere un quadro, storico e attuale, della considerazione, da parte della critica letteraria ma non solo, della presenza femminile nel campo della produzione letteraria. Parole chiave: premi letterari, gap di genere, intitolazioni pubbliche. 1 L’idea della ricerca L’idea di una ricerca sui premi letterari italiani è nata in chi scrive dalla lettura di un interessante articolo dell’editore Luigi Spagnol dal titolo “Maschilismo e letteratura. Che cosa ci perdiamo noi uomini”, comparso nell’ottobre del 2016 in illibraio.it. “Il mondo letterario e la società in generale – si chiede l’autore – riconoscono alle opere scritte dalle donne la stessa importanza che viene riconosciuta a quelle scritte dagli uomini? Siamo altrettanto pronti, per esempio, a considerare una scrittrice o uno scrittore dei capiscuola, ad accettare che una donna possa avere la stessa influenza di un uomo sulla storia della letteratura?” La risposta è no, e il numero insignificante di presenze femminili negli albi d’oro dei grandi premi letterari – Nobel, Goncourt, Booker, Strega, Pulitzer – dove le donne sono un quinto degli uomini, non fa che confermare questa intuizione. -

Historical Narrative and Subjectivity in Anna Banti's Camicia Bruciata
“Who Am I?”: Historical Narrative and Subjectivity in Anna Banti's Camicia bruciata “Who Am I?”: Historical Narrative and Subjectivity in Anna Banti's Camicia bruciata By Lucy Delogu Translated by Steven Haire “Who Am I?”: Historical Narrative and Subjectivity in Anna Banti's Camicia bruciata, by Lucy Delogu This book first published 2012 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2012 by Lucy Delogu All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-4050-5, ISBN (13): 978-1-4438-4050-7 TABLE OF CONTENTS Introduction ................................................................................................. 1 The Women’s Question in Italy Chapter One............................................................................................... 19 The Poetics of Anna Banti Chapter Two.............................................................................................. 49 The Construction of the Feminine in Bantian Narrative Chapter Three............................................................................................ 71 La camicia bruciata Chapter Four........................................................................................... -

'Outside Perspective' to the Works of Kosovel by Illustrating And
K.Pizzi, 17/11/07, 12:52 [article published in Kosovelova Poetika/ Kosovel’s Poetics, special issue of Primerjalna knjizevnost 28(2005), pp. 239-249] ‘QUALE TRIESTINITA`?’: VOICES AND ECHOES FROM ITALIAN TRIESTE Abstract: In focusing on Italian Trieste and, in particular, on as large as possible a corpus of Triestine poetry contemporary to S.Kosovel, my paper provides a perspective that is peripheral and ‘outside’. Special attention is paid to the Futurist avant-garde: the Futurist leader Marinetti considered Trieste as Futurist city par excellence and the first Futurist soirees took place at Teatro Rossetti between 1909 and 1910. Futurism attracted a large group of local artists, some of whom (e.g. Carmelich and Cernigoj) were personally known by and became close to Kosovel. The poets Sanzin and Miletti espoused enthusiastically the Futurist linguistic experimentalism, as well as the movement’s national/nationalist tendencies. Poetry of national and romantic inspiration is also of fundamental importance: Slataper’s vitalist approach to the rugged Karst region, though pre-Great War, provides scope for comparative approaches. Nationalist poetry, much of which officially compromised with the Fascist regime (Cambon, Corraj, Alma Sperante), is equally integral to the Triestine cultural landscape of the 1920s and ‘30s. By shedding light on a significant portion of poetry in Italian arising from the vibrant, if largely hostile, cultural environment of Trieste, my paper invites an implicit rather than explicit assessment of Kosovel’s role and contribution to the European avant-garde. 1 K.Pizzi, 17/11/07, 12:52 ‘QUALE TRIESTINITA`?’: VOICES AND ECHOES FROM ITALIAN TRIESTE In re-evaluating as large as possible a corpus of Triestine poetry in Italian, my article intends to court the poetics and production of Šrečko Kosovel. -

Rewriting Dante: the Creation of an Author from the Middle Ages to Modernity
Rewriting Dante: The Creation of an Author from the Middle Ages to Modernity by Laura Banella Department of Romance Studies Duke University Date: _______________ Approved: ___________________________ Martin G. Eisner, Supervisor ___________________________ David F. Bell, III ___________________________ Roberto Dainotto ___________________________ Valeria Finucci Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Studies in the Graduate School of Duke University 2018 ABSTRACT Rewriting Dante: The Creation of an Author from the Middle Ages to Modernity by Laura Banella Department of Romance Studies Duke University Date: _________________ Approved: ___________________________ Martin G. Eisner, Supervisor ___________________________ David F. Bell, III ___________________________ Roberto Dainotto ___________________________ Valeria Finucci An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Studies in the Graduate School of Duke University 2018 Copyright by Laura Banella 2018 Abstract Rewriting Dante explores Dante’s reception and the construction of his figure as an author in early lyric anthologies and modern editions. While Dante’s reception and his transformation into a cultural authority have traditionally been investigated from the point of view of the Commedia, I argue that these lyric anthologies provide a new perspective for understanding how the physical act of rewriting Dante’s poems in various combinations and with other texts has shaped what I call after Foucault the Dante function” and consecrated Dante as an author from the Middle Ages to Modernity. The study of these lyric anthologies widens our understanding of the process of Dante’s canonization as an author and, thus, as an authority (auctor & auctoritas), advancing our awareness of authors both as entities that generate power and that are generated by power. -

Rhythmical Figures in Dante's Commedia: a Study of Memory And
Rhythmical Figures in Dante’s Commedia: A Study of Memory and Composition after Gianfranco Contini Ryan Robert Pepin Pembroke College This thesis is submitted for the degree of Doctor of Philosophy February 2020 This thesis is the result of my own work and includes nothing which is the outcome of work done in collaboration except as declared in the Preface and specified in the text. It is not substantially the same as any that I have submitted, or, is being concurrently submitted for a degree or diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other University or similar institution except as declared in the Preface and specified in the text. I further state that no substantial part of my thesis has already been submitted, or, is being concurrently submitted for any such degree, diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other University or similar institution except as declared in the Preface and specified in the text. It does not exceed the prescribed word limit for the relevant Degree Committee. Abstract Rhythmical Figures in Dante’s Commedia: A Study of Memory and Composition after Gianfranco Contini Ryan Pepin This thesis takes Contini’s 1965 study ‘Un’interpretazione di Dante’, and its discussion of repeated lines and part-lines, as its point of departure in order to pursue new understanding of the compositional processes of Dante’s Commedia. It shows how the repetition of similar items, or ‘figures’, relates to orality both in a transmissional, or textual-critical sense, as well as in a compositional, or oral-formulaic, sense. -

The New Italian Novel Edited by Zygmunt G. Baranski and Lino Pertile
Differentia: Review of Italian Thought Number 8 Combined Issue 8-9 Spring/Autumn Article 50 1999 The New Italian Novel edited by Zygmunt G. Baranski and Lino Pertile Robert Dombroski Follow this and additional works at: https://commons.library.stonybrook.edu/differentia Recommended Citation Dombroski, Robert (1999) "The New Italian Novel edited by Zygmunt G. Baranski and Lino Pertile," Differentia: Review of Italian Thought: Vol. 8 , Article 50. Available at: https://commons.library.stonybrook.edu/differentia/vol8/iss1/50 This document is brought to you for free and open access by Academic Commons. It has been accepted for inclusion in Differentia: Review of Italian Thought by an authorized editor of Academic Commons. For more information, please contact [email protected], [email protected]. reviews 391 issues of Judaism and gender raised least, a discrete occasion for reflecting in the works of Lombroso and Serao, on some aspect of alienated human though is never completely success existence. Italian literary culture once ful. enjoyed relative autonomy; it existed The discourses raised by both in a space roped off from society and Lombroso and Serao which address designated as a refuge from commer crucial concerns of the late nine cialization and ideological violence. teenth-century, such as the place and Then one could read the history of identity of women and Jews in soci modem Italy in novels that not only ety and the role of science to mediate spoke to the development of civic pressing social issues, have a contem consciousness but also programmed porary relevance. Moreover, the mind of the reader to a totalizing Harrowitz's work is an important logic.