Stati Uniti D'europa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ciampi Invoca: Tornare Alla Concertazione 2006
4 oggi sabato 25 ottobre 2003 ro dei controllori del traffico aereo aderenti all' in Sicilia allo sciopero generale di Cgil Cisl e Uil. Nella A Fiumicino sono stati Anpcat. Alla Fiat di Termini Imerese provincia di Messina hanno scioperato il 100% degli Nel dettaglio, secondo quanto reso noto dalla So- addetti della «Birra Messina», il 60% nella raffineria cancellati 145 voli di linea cietà di gestione Aeroporti di Roma, sono stati 73 i sciopera il 90% degli operai di Milazzo, 230 su 250 dipendenti dell'Edilpower di voli soppressi in partenza (46 nazionali e 27 interna- San Filippo del Mela. A Caltanissetta il 100% degli zionali) e 72 quelli in arrivo (43 nazionali e 29 interna- operai del polo tessile. A Palermo hanno incrociato le ROMA Sono stati 145 in tutto, tra nazionali (89) e zionali). PALERMO Il 90% dei lavoratori della Fiat di Termini braccia il 55% dei lavoratori delle Fs, il 75% dei dipen- internazionali (56), i voli cancellati ieri all’aeroporto Sono stati, infine, 101 (62 nazionali e 39 interna- Imerese e il 95% di quelli del Cantiere navale di denti Amat (1.430 persone), il 70% dell'Enel. A Cata- Leonardo da Vinci di Fiumicino per lo sciopero gene- zionali) i voli rischedulati, quelli, cioè, che hanno Palermo. Il 100% degli operai del petrolchimico di nia hanno scioperato 90 dipendenti su 120 della Coca rale che ha interessato dalle 12.30 alle 16.30 anche il subito un cambiamento d’orario rispetto al program- Gela tra diretto (esclusi gli addetti alla tenuta degli Cola e 38 su 40 della Parmala, mentre a Trapani comparto del trasporto aereo, a cui si è aggiunta, ma originale e che quindi hanno subito un ritardo impianti) e indotto. -

Descargas Fiscales a Las Empresas Familiares, Ayudas Directas a Los Patronos Y Una Mayor Flexibilidad Legal Con La Entrada En Vigor De Nuevos Tipos De Contratos
» Biografías Líderes Políticos » _Organismos » Unión Europea » Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi © NATO Photo Italia Acttualliizaciión:: 3 jjulliio 2019 Primer ministro (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011); miembro del Parlamento Europeo (1999-2001, 2019-) Mandatto:: 8 mayo 2008 -- 16 noviiembrre 2011 Naciimiientto:: Miillán,, rregiión de Lombarrdíía,, 29 septtiiembrre 1936 Parttiido pollííttiico:: Forrza IIttalliia ((antterriiorrmentte,, dell Puebllo de lla Liiberrttad,, PdL)) Proffesiión:: Emprresarriio Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Presentación Ya en el poder, ya en la oposición, Silvio Berlusconi, el más atípico de los líderes europeos, ha dominado la escena política italiana de los últimos 17 años, período que abren y cierran unas circunstancias históricas muy concretas. Su cuasi década en el Ejecutivo, dividida en tres legislaturas y cuatro gobiernos, fue una anomalía democrática permanente, a saber: la reunión en una misma persona de la mayor fortuna privada del país y del cargo de primer ministro. Una situación insólita que este empresario-político, maestro del espectáculo y el ardid, capaz de mantener unas altas cotas de popularidad pese al cúmulo de desaguisados, no hizo más que agudizar en la medida que convirtió el conflicto de intereses y la prevaricación encubierta en principios consuetudinarios de gobierno. Al terminar 2011, el balance de esta singular experiencia es, para Italia y para el conjunto de la Unión Europea, decididamente negativo, a la luz de sus secuelas políticas, económicas, sociales y hasta culturales, terrenos todos ellos degradados en mayor o menor medida. EL PRIMER PERIODO DE GOBIERNO (1994-1995) En 1994 Berlusconi irrumpió de manera espectacular en la política italiana en un momento crucial para el país: el hundimiento, socavado por la campaña judicial Mani Pulite contra la corrupción institucionalizada, del edificio de partidos que había dominado la República parlamentaria de la posguerra. -

Italian Politics
ABOUT THE EDITORS AND CONTRIBUTORS Lucio Baccaro is a researcher at the International Institute for Labor Studies (ILO) in Geneva. Massimiano Bucchi is a researcher in the Faculty of Sociology at the University of Trento, where he teaches the sociology of science. Osvaldo Croci is Associate Professor of International Politics in the Department of Political Science at Memorial University of New- foundland in Canada. Donatella della Porta is Professor of Sociology in the Department of Political and Social Sciences of the European University Institute in Fiesole. Vincent Della Sala is Associate Professor of Political Science in the Faculty of Sociology at the University of Trento. Mario Diani is Professor of Sociology in the Faculty of Sociology at the University of Trento, and he is Visiting Research Professor at Strathclyde University in Glasgow. Mark Donovan is Senior Lecturer in European Politics in the School of European Studies at the University of Cardiff, and he is editor of the journal Modern Italy. Sergio Fabbrini is Professor of Political Science in the Faculty of Soci- ology at the University of Trento, and he is editor of the journal Riv- ista Italiana di Scienza Politica. Editors and Contributors 269 Matthew Hibberd is Director of the Online Masters in Public Rela- tions and Vice-Director of the Department of Cinema and Media Stud- ies at the University of Stirling in Scotland. Guido Legnante conducts research and teaches sociology at the Uni- versity of Pavia. Francesc Morata is Professor of Political Science at the Free Univer- sity of Barcelona, where he teaches policy and multi-level governance in the European Union. -

Rapporto Di Attività
ISTITUTO LUIGI STURZO RAPPORTO DI ATTIVITÀ ANNO 2012 1 2 PREMESSA DEL PRESIDENTE Nel presentare l’attività svolta dall’Istituto nel corso del 2012, non è possibile non fare riferimento alla profonda crisi che il nostro Paese sta vivendo e che il settore della cultura, in modo particolare, soffre ormai da diversi anni. Tutte le realtà istituzionali che operano nella conservazione, nella tutela e nella promozione dei patrimoni culturali hanno visto, negli ultimi anni, una progressiva riduzione delle risorse e con esse delle opportunità di progettare e realizzare una adeguata promozione delle proprie attività, delle proprie funzioni, del proprio ruolo, di tutto quello, cioè, che particolarmente nei momenti di difficoltà, potrebbe costituire risorsa, stimolo intellettuale e morale. Il contesto nazionale ed europeo in cui ci troviamo a operare chiede invece un impegno di resistenza, di sopravvivenza quasi, e a questo impegno anche l’Istituto Sturzo ha dedicato tutte le proprie forze. Le attività del 2012 sono state infatti caratterizzate da un indirizzo di consolidamento e di approfondimento di quanto avviato negli anni precedenti, attraverso un riassetto strutturale interno e l’individuazione di progetti più significativi ed efficaci. In questa prospettiva credo di poter ritrovare, in quello che abbiamo portato avanti, una conferma delle scelte fatte nel passato e un potenziale intrinseco di cui l’Istituto è indubbiamente portatore, con il suo patrimonio e con le competenze maturate nella sua lunga storia. La gestione del patrimonio - Archivio, Biblioteca e Palazzo - costituisce infatti il nucleo centrale dell’attività dell’Istituto. In particolare quest’anno, la sede di Palazzo Baldassini, dimora prestigiosa della storia dell’Istituto, da molti anni oggetto di interventi di recupero e restauro, ha trovato la sua definitiva riqualificazione, con la conclusione dei lavori esterni e interni e l’apertura al pubblico della nuova sala studio della Biblioteca. -

Speciale NOMOS Ministri E Sottosegretari Governo Draghi
I ministri e i sottosegretari del Governo Draghi 25 febbraio 2021 Mario Draghi Nato a Roma il 3 settembre 1947. Rimase orfano di entrambi i genitori quando aveva 15 anni. Si è laureato in Economia nel 1970 all’Università La Sapienza di Roma con una tesi su Integrazione economica e variazione dei tassi di cambio. Si è poi specializzato al Massachusetts Institute of Technology di Boston dove ha conseguito un PhD con una tesi intitolata Essays on Economic Theory and Applications. Nel 1982 comincia una brillante carriera pubblica come consigliere del ministro del Tesoro Giovanni Goria, fino a diventare direttore generale del Tesoro nel 1991. La sua carriera prosegue poi in Goldman Sachs fino al 2005 quando viene nominato Governatore della Banca d’Italia, diventando promotore di diverse riforme e di un profondo processo di modernizzazione dell’Istituto. Nel maggio del 2011 viene nominato presidente della Bce, in un momento in cui l’Unione Europea si trova a fronteggiare gli effetti della crisi economica del 2008 e successivamente di quella del 2012. In quest’ultimo frangente, Draghi pronunciò il discorso più importante della sua carriera e uno dei più importanti della storia Europea. Durante un forum di investitori a Londra annunciò che la Bce avrebbe fatto «whatever it takes» per salvare l’euro. Grazie a quell’intervento oggi viene celebrato come il salvatore dell’Europa e viene elogiato da tutti i leader europei per l’uscita dalla crisi e il successivo consolidamento economico e politico dell’Unione Europea stessa. Il suo nome è emerso con forza per superare la crisi politica del Governo Conte II. -

Bossi: Berlusconi Mi Manderà Una Lettera Con I Tempi Delle Riforme. Entro La Fine Del Prossimo Anno. Follini
6 oggi domenica 6 luglio 2003 Natalia Lombardo le. Fini, ieri, ha sdoganato il sistema elet- torale proporzionale già sponsorizzato da Buttiglione. Di più, Fini ha annuncia- ROMA È sfuggito un codicillo, nel fax che Bossi: Berlusconi Fassino: una verifica to un disegno di legge sul modello delle ha sugellato la Pax nella Casa delle Liber- elezioni provinciali o regionali, di pari tà. Manca una cosa da poco, la voce «ri- passo con il premierato. Altro che ammi- mi manderà una desolante e sconcertante, un ‘‘ forma fiscale», sempre annuciata dal go- nistratore unico Berlusconi, dentro An le verno come il mitico taglio delle tasse. lettera con i tempi delle programma banale e generico ambizioni sono altre. Lo dice chiaramen- Agitatissimo, ieri il ministro dell’Econo- te Mario Landolfi: «Da oggi non c’è più il mia, Giulio Tremonti, si è disperato per riforme. Entro la fine del Si sono riuniti per decidere governo Berlusconi, ma Berlusconi-Fini. un «errore di battitura di cui mi assumo ‘‘ Non c’è più una coalizione di governo, la responsabilità», che ha fatto saltare il prossimo anno. Follini: basta che per fare la pasta ma un governo di coalizione. La Cdl è passaggio nel documento faxato notte- morta e al suo posto è nata un’alleanza tempo da Berlusconi agli alleati. Ecco le con i malumori della Lega va bollita l’acqua tra FI, An, Lega e Udc, quattro partiti parole perdute, spiega il ministro: «Quan- con identità diverse, piuttosto che quella do si dice graduale riforma della scuola, vecchia cosa indistinta che era la Cdl». -

Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi Italia, Primer ministro (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011); miembro del Parlamento Europeo (1999-2001, 2019-) Duración del mandato: 08 de Mayo de 2008 - de de Nacimiento: Milán, región de Lombardía, 29 de Septiembre de 1936 Partido político: Forza Italia (anteriormente, del Pueblo de la Libertad, PdL) Profesión : Empresario Resumen Ya en el poder, ya en la oposición, Silvio Berlusconi, el más atípico de los líderes europeos, ha dominado la escena política italiana de los últimos 17 años, período que abren y cierran unas circunstancias históricas muy concretas. Su cuasi década en el Ejecutivo, dividida en tres legislaturas y cuatro gobiernos, fue una anomalía democrática permanente, a saber: la reunión en una misma persona de la mayor fortuna privada del país y del cargo de primer ministro. Una situación insólita que este empresario-político, maestro del espectáculo y el ardid, capaz de mantener unas altas cotas de popularidad pese al cúmulo de desaguisados, no hizo más que agudizar en la medida que convirtió el conflicto de intereses y la prevaricación encubierta en principios consuetudinarios de gobierno. Al terminar 2011, el balance de esta singular experiencia es, para Italia y para el conjunto de la Unión Europea, decididamente negativo, a la luz de sus secuelas políticas, económicas, sociales y hasta culturales, terrenos todos ellos degradados en mayor o menor medida. EL PRIMER PERIODO DE GOBIERNO (1994-1995) En 1994 Berlusconi irrumpió de manera espectacular en la política italiana en un momento crucial para el país: el hundimiento, socavado por la campaña judicial Mani Pulite contra la corrupción institucionalizada, del edificio de partidos que había dominado la República parlamentaria de la posguerra. -

Sp-Continua La Crisi Del Berlusconi-2
Anno 3 - n° 74 WWW.GIUSTIZIA -e-LIBERTA.CO M 20 Luglio 2004 Giustizia e Libertà Distribuzione telematica Periodico Politico Indipendente Copia gratuita Sp. Continua la Crisi del Berlusconi-2 La crisi è nelle cose di Luigi Barbato La situazione politico istituzionale italiana oramai da oltre tre anni si è incamminata su una strada che solo in termini eufemistici può essere definita “poco corretta”. L’Italia è governata da un premier che non potrebbe essere neanche membro del parla- mento, ma dovrebbe essere inquisito per una serie di reati che tramite il suo governo ha fatto derubricare, depenalizzare, cancellare. Premier che può essere tale solo in una nazione come l’Italia -una volta definita “patria del Diritto”- perché in qualsiasi altra nazione dell’emisfero boreale, in cui vigesse un clima anche solo nominalmente democratico poteva mai illudersi di … spuntarla. E’ necessario ormai che prendessimo coscienza che se è vero come è vero che la civiltà umana ha purtroppo dovuto attraversare periodi di tetro oscurantismo, e sarebbe quindi necessario che ci ren- dessimo conto che l’Italia ha iniziato a vi- vere uno di questi infau- sti periodi dal momento che si è incamminata in quest’era berlusconiana. Una maggioranza che fa un en plein in Sicilia (61 eletti su 61),quando neanche nei peggiori periodi di commistione politico-affaristica un partito politico è riusci- to a tanto; Ministri o vi- ceministri che nel chiu- so dei loro uffici mini- steriali vengono visitati da “pusher” siculi, mi- nistri che dichiarano che si deve “convivere con -

Associazione Openpolis E Contribuisci Anche Tu Alla Rivoluzione Della Trasparenza in Italia
CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2011 Sostieni l’unica trasparenza che si vede! RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO APRILE 2008 / DICEMBRE 2011 DIVENTA SOCIO/A DELL’ASSOCIAZIONE OPENPOLIS E CONTRIBUISCI ANCHE TU ALLA RIVOLUZIONE DELLA TRASPARENZA IN ITALIA. L’ISCRIZIONE ONLINE È APERTA PER STUDENTI/PRECARI, CITTADINI, POLITICI E ORGANIZZAZIONI PRESSO IL SITO ASSOCIAZIONE.OPENPOLIS.IT associazione associazione Via Dei Sabelli 215 - 00185 Roma [email protected] Tel.: 06.83608392 Sommario CAMERE APERTE 2011 Il progetto openpolis 3 Camere Aperte - Secondo Anno 4 Associazione openpolis 5 Obiettivo trasparenza ››› La trasparenza dei Parlamenti a confronto L’Indice della Produttività parlamentare 6 Premessa 7 I Criteri 9 I Parametri L'Agenda del Parlamento 11 Temi a confronto 12 Italie a confronto La produttività dei parlamentari 14 ››› Gruppi parlamentari 16 ››› Uomini e donne ››› Regioni I ruoli e i personaggi 20 Classifiche per tipo di attività Una Repubblica parlamentare? 24 ››› Chi fa davvero le leggi ››› Doppi incarichi 26 ››› L’interrogato (non) risponde Appendici 28 Classifica dei Deputati per indice di produttività 33 Classifica dei Senatori per indice di produttività A cura dell'associazione http://associazione.openpolis.it Via Dei Sabelli 215 - 00185 Roma Tel.: 06.83608392 Progetto grafico: KOOK - ARTGENCY http://www.kook.it Si ringrazia per il contributo alla stampa del presente volume http://www.actionaid.it Un ringraziamento particolare ai 14.716 iscritti alla community di openpolis.it Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia (CC BY-NC-SA 2.5) Puoi riprodurre, distribuire e usare liberamente quest'opera. Vedi le condizioni legali in Creative Commons Italia: www.creativecommons.it Il progetto openpolis CAMERE APERTE - SECONDO ANNO La prima edizione di Camere Aperte coincideva con il debut- to del sito openparlamento.it, nel giungo del 2009. -
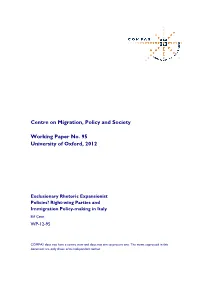
Centre on Migration, Policy and Society Working Paper No. 95
Centre on Migration, Policy and Society Working Paper No. 95 University of Oxford, 2012 Exclusionary Rhetoric Expansionist Policies? Right-wing Parties and Immigration Policy-making in Italy Elif Çetin WP-12-95 COMPAS does not have a centre view and does not aim to present one. The views expressed in this document are only those of its independent author Abstract: Immigration has become an issue often framed with reference to the protection of external borders, welfare state, cultural and ethnic identity, increased risk of terrorism in most of the major receiving countries in Europe. Yet, despite restrictive immigration controls and exclusionary rhetoric in these countries, population inflows continue. Building on the literature which points out that migration policies often ‘fail’ to achieve restrictive objectives due to various institutional constraints preventing governments to realise their electoral promises (Boswell 2003; Calavita 2004; Castles 2004a, 2004b; Freeman 1995; Geddes 2008), this paper analyses the relation between policy debates and policy-making in migration domain. The processes through which immigration debates and policies evolved in Italy are analysed by drawing on qualitative data for the period covering 1996 to 2010. The paper elaborates on how, faced with the so-called immigration pressures, different discursive categories of immigrants and immigration are created by the right-wing political parties in Italy, the extent to which nodal points of the right-wing immigration debates were reflected in the design of -
Il Brutto Anatroccolo Si Trasforma in Moroteo Atto Di Clemenza Verso I Carcerati
lunedì 9 dicembre 2002 oggi 7 Natalia Lombardo gli ex Dc; «per la legge elettorale c’è tem- po», sogghigna Mario Baccini. Senza nominarlo, a Bossi il segreta- ROMA Barra al centro, Berlusconi cambi Vicesegretario Berlusconi bilanci gli equilibri rio Udc non risparmia gli affondo: «Nes- la rotta del governo che sta naufragando suna indulgenza verso le «correnti euro- nelle derive estremiste e non parla più a scettiche» che vaneggiano Spectre di Bru- D’Antoni di maggioranza. La devolution ‘‘ quella «Italia di mezzo, moderata, solida- xelles, o verso chi «considera il Capo le, ragionevole di cui facciamo parte». presidente Buttiglione. E una non si farà sulla punta dello Stato come parte in causa e non Berlusconi, insomma, molli Bossi e guar- riferimento istituzionale». E la Devolu- di al centro. All’Udc nata ieri alla Fiera pletora di 250 consiglieri delle baionette padane tion è un impegno, ma «non un ukase di Roma e che ha eletto per acclamazio- ‘‘ zarista», una riforma costituzionale ne Marco Follini segretario. Scongiurato nazionali. Tra cui il gotha Giù il cappello davanti «non si fa sulla punta delle baionette il rischio di dare vita a un partito a tre padane». Si può fare, ma «entro i confi- teste, è lui stesso a proporre al congresso della vecchia Balena bianca alla storia della Dc ni» della sussidiarietà e dell’unico Stato, di «acclamare» anche Rocco Buttiglione senza divisioni fra «italiani nati con la presidente. E Sergio D’Antoni vicesegre- camicia e altri predestinati alla valigia di tario. I due si avvi- cartone». cinano al palco La Frontiera, dal cui parla Folli- comunque, resta ni: Buttiglione rad- marcata. -

Domenico Siniscalco
Domenico Siniscalco Il Foglio, 2 ottobre 2004 La levitas creativa del ministro della concordia La prima volta in cui il professor Domenico Siniscalco rischiò di incrociare la famigliarità delle masse popolari, la circostanza si verificò nel ramo showbiz. Fu provinato per una trasmissione tv di soggetto economico, poi non se ne fece nulla. Ma nello studio della sua vita e avventure la minaccia di un esordio televisivo è compatibile con la sua essenza di uomo complesso ma medio, mille lati, e ciascuno iperbole di una specie di italianità portata alle massime conseguenze. Ecco – in una selezione di punti di vista – come lo vedono gli altri: simpatico, piacione, swatchista, brookbrotherista, golfista (talentuoso ma avrebbe bisogno di giocare di più), un po’ traditore e un po’ amico di tutti, mangiatore di pesce, intelligente e intellettualmente ubiquo, mammone ai massimi (parla con sua madre fino a tre volte al giorno), neweconomista, tifoso assai di calcio (Juve), rabelaisiano, all’occorrenza bestemmiatore, cinico, colto (sebbene di letture disordinate: legge Forsythe e pure Martyn Mistère), curioso, argentea brillantezza, onesto, fantasioso, sicuramente paraculo, non immune da forme di snobismo, seduttore, conversatore, oratore, e poi revigliano, amatiano, dalemiano, rutelliano, anche realacciano, anche meomartiniano, e anche “tipo Mastella, ma più chic”, e tremontiano, e anche motociclista, buelliano (da Buell, un bolide americano) e ducatiano (una Monster e una 916 Desmo). E tutto ciò riesce a essere anche contemporaneamente. Trai suoi libri preferiti – versante intrattenimento – “Educazione di una canaglia”, l’autobiografia di Edward Bunker, il bandito americano con il quoziente intellettivo di un genio che in carcere diventò scrittore e fu salvato dalla letteratura.