Annali Del Turismo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
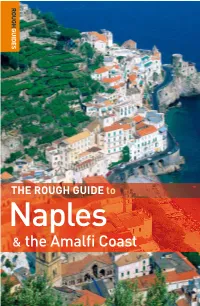
The Rough Guide to Naples & the Amalfi Coast
HEK=> =K?:;I J>;HEK=>=K?:;je CVeaZh i]Z6bVaÒ8dVhi D7FB;IJ>;7C7B<?9E7IJ 7ZcZkZcid BdcYgV\dcZ 8{ejV HVc<^dg\^d 8VhZgiV HVciÉ6\ViV YZaHVcc^d YZ^<di^ HVciVBVg^V 8{ejVKiZgZ 8VhiZaKdaijgcd 8VhVaY^ Eg^cX^eZ 6g^Zcod / AV\dY^EVig^V BVg^\a^Vcd 6kZaa^cd 9WfeZ_Y^_de CdaV 8jbV CVeaZh AV\dY^;jhVgd Edoojda^ BiKZhjk^jh BZgXVidHVcHZkZg^cd EgX^YV :gXdaVcd Fecf[__ >hX]^V EdbeZ^ >hX]^V IdggZ6ccjco^ViV 8VhiZaaVbbVgZY^HiVW^V 7Vnd[CVeaZh GVkZaad HdggZcid Edh^iVcd HVaZgcd 6bVa[^ 8{eg^ <ja[d[HVaZgcd 6cVX{eg^ 8{eg^ CVeaZh I]Z8Vbe^;aZ\gZ^ Hdji]d[CVeaZh I]Z6bVa[^8dVhi I]Z^haVcYh LN Cdgi]d[CVeaZh FW[ijkc About this book Rough Guides are designed to be good to read and easy to use. The book is divided into the following sections, and you should be able to find whatever you need in one of them. The introductory colour section is designed to give you a feel for Naples and the Amalfi Coast, suggesting when to go and what not to miss, and includes a full list of contents. Then comes basics, for pre-departure information and other practicalities. The guide chapters cover the region in depth, each starting with a highlights panel, introduction and a map to help you plan your route. Contexts fills you in on history, books and film while individual colour sections introduce Neapolitan cuisine and performance. Language gives you an extensive menu reader and enough Italian to get by. 9 781843 537144 ISBN 978-1-84353-714-4 The book concludes with all the small print, including details of how to send in updates and corrections, and a comprehensive index. -

93 Fari Dismessi. Dall'abbandono Alla
Annali del Turismo, V, 2016, n.1 Edizioni Geoprogress FARI DISMESSI. DALL’ABBANDONO ALLA RIGENERAZIONE Antonietta Ivona Abstract Lighthouses decommissioned. From abandonment to regeneration. - The Italian legislation on cultural heritage introduced, a few years ago, the concept of enhancement and enjoyment of cultural heritage through the outsourcing of cultural assistance and hospitality services for the public. Particularly, the national Project "Valore Paese" of the Agenzia del Demanio is dedicated to lighthouses and it intends to encourage the promotion of the Italian public real estate through the synergy between the sectors of tourism, art and culture, economic and territorial cohesion. In this sense, the recovery of public assets owned by the State and local authorities has the possibility to be considered not only in terms of cost to the community, but also as a significant lever for territorial and social development, in a logic of public- private partnership. 1. I fari nel tempo Opere di ingegneria umana, ammantate di miti e leggende, i fari sono parte della storia della navigazione. Dai bagliori dei primi fuochi accesi sulle torri di avvistamento fino ai recenti dibattiti sul futuro della rete dei fari, essi hanno da sempre rappresentato anche luoghi identitari. I primi fari che la storia conosce non erano altro che falò di legna accatastata situati nei luoghi più pericolosi per segnalare la rotta ai naviganti. “I primi fuochi, che dovevano restare accesi tutta la notte, richiedevano continua cura: occorreva combustibile, sapienza tecnica, presenza costante dell’uomo” (Mariotti, 2013, p. 10). Con l’evolversi della navigazione commerciale, occorse sostituire i falò con strumenti di segnalazione più sicuri e, quindi, più potenti da ubicare nei porti lungo le nuove rotte commerciali. -

Bridging Terrestrial and Marine Geoheritage: Assessing Geosites in Portofino Natural Park (Italy)
water Article Bridging Terrestrial and Marine Geoheritage: Assessing Geosites in Portofino Natural Park (Italy) Paola Coratza 1, Vittoria Vandelli 1,* , Lara Fiorentini 2, Guido Paliaga 3 and Francesco Faccini 3,4 1 Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Campi 103, 41125 Modena, Italy; [email protected] 2 Settore Politiche delle Aree interne, Antincendio, Forestazione, Parchi e Biodiversità, Regione Liguria, Via D’Annunzio 111, 16121 Genova, Italy; lara.fi[email protected] 3 CNR Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, sede di Torino, Strada delle Cacce 73, 10135 Torino, Italy; [email protected] (G.P.); [email protected] (F.F.) 4 Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, Università degli Studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova, Italy * Correspondence: [email protected] Received: 28 August 2019; Accepted: 8 October 2019; Published: 11 October 2019 Abstract: Interest in geoheritage research has grown over the past 25 years and several countries have issued laws to encourage improvement and conservation. Investigations on geosites are prevalently carried out on land environments, although the study of underwater marine environments is also of paramount scientific importance. Nevertheless, due to the constraints of underwater environments, these sites have been little explored, also on account of the higher costs and difficulties of surveying. This research has identified and assessed the terrestrial and marine geosites of the Portofino Natural Park and Protected Marine Area, which are internationally famous owing to both the land scenic features and the quality of the marine ecosystem. -

Mise En Page 1
C IESM Workshop Monographs Marine geo-hazards in the Mediterranean Nicosia,2-5February2011 CIESM Workshop Monographs ◊ 42. To be cited as: CIESM, 2011. Marine geo-hazards in the Mediterranean. N° 42 in CIESM Workshop Monographs [F. Briand Ed.], 192 pages, Monaco. This collection offers a broad range of titles in the marine sciences, with a particular focus on emerging issues. The Monographs do not aim to present state-of-the-art reviews; they reflect the latest thinking of researchers gathered at CIESM invitation to assess existing knowledge, confront their hypotheses and perspectives, and to identify the most interesting paths for future action. A collection founded and edited by Frédéric Briand. Publisher : CIESM, 16 bd de Suisse, MC-98000, Monaco. MARINE GEO-HAZARDS IN THE MEDITERRANEAN - Nicosia,2-5February 2011 CONTENTS I-EXECUTIVE SUMMARY ................................................7 1. Introduction 2. Volcanoes 2.1 Tyrrhenian Sea 2.2 Aegean Sea 2.3 Gaps of knowledge related to volcanic activity 3. Earthquakes 3.1 Geodynamics and seismo-tectonics 3.2 Distribution – short history 3.3 Seismic parameter determination – data bases 3.4 Associated marine hazards 4. Submarine landslides 4.1 Slope movement stages and physical mechanisms 4.2 Observation, detection and precursory evidence 4.3 Gaps of knowledge associated with sedimentary mass movements 5. Tsunamis 6. Risk reduction: preparedness and mitigation 7. Recommendations II – WORKSHOP COMMUNICATIONS - Geo-hazards and the Mediterranean Sea. J.Mascle.............................................................23 • Eastern Mediterranean - Marine geohazards associated with active geological processes along the Hellenic Arc and Back-Arc region. D.Sakellariou ........................................................27 3 CIESM Workshop Monographs n°42 MARINE GEO-HAZARDS IN THE MEDITERRANEAN - Nicosia,2-5February 2011 - Potential tsunamigenic sources in the Eastern Mediterranean and a decision matrix for a tsunami early warning system. -

Horizon 2020 SME Instrument Phase 1 Beneficiaries
Horizon 2020 SME Instrument Updated in June 2017 Phase 1 beneficiaries Call Deadline Country City Beneficiary Website Proposal Acronym Long name Date Topic May 2017 cut off Small business innovation Novel, automated charging infrastructure for Austria Graz easE-Link GmbH http://ease-link.com/ MATRIX CHARGING 03/05/2017 research for Transport and electric vehicles Smart Cities Mobility Small business innovation Austria Linz My Esel GmbH MI-BIKE World's Most Individual Bikes and e-bikes 03/05/2017 research for Transport and Smart Cities Mobility Boosting the potential of small Metallurgical patented Process Transforming businesses in the areas of Austria Leoben UrbanGold GmbH www.urbangold.at METALLICA Residues from the Electronic Industry into 03/05/2017 climate action, environment, Valuable Precious Metals resource efficiency and raw Accelerating market Pridiktiv - Exploring European expansion introduction of ICT solutions Belgium Roosdaal Pridiktiv NV www.pridiktiv.care PRIDIKTIV 03/05/2017 through 4 pilot studies for Health, Well-Being and Ageing Well Full scale demonstration of an Innovative Small business innovation Denmark Hedehusene BBHS A/S www.bbhs.dk IBiS solution for Baggage Handling Systems at 03/05/2017 research for Transport and airports (IBiS) Smart Cities Mobility Accelerating the uptake of A disruptive air filtration system for cleaning- nanotechnologies advanced Denmark Herning MULTI AIR Aps http://www.multiair.dk JetConveyor free operation in dust-intensive process 03/05/2017 materials or advanced industrial environments -
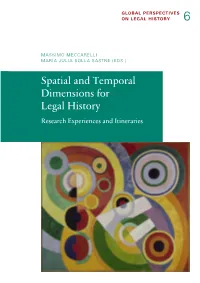
Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research
GLOBAL PERSPECTIVES ON LEGAL HISTORY 6 MASSIMO MECCARELLI MARÍA JULIA SOLLA SASTRE (EDS.) Spatial and Temporal Dimensions for Legal History Research Experiences and Itineraries GLOBAL PERSPECTIVES ON LEGAL HISTORY 6 Global Perspectives on Legal History A Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication http://global.rg.mpg.de Series Editors: Thomas Duve, Stefan Vogenauer Volume 6 Global Perspectives on Legal History is a book series edited and published by the Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, Germany. As its title suggests, the series is designed to advance the scholarly research of legal historians worldwide who seek to transcend the established boundaries of national legal scholarship that typically sets the focus on a single, dominant modus of normativity and law. The series aims to privilege studies dedicated to reconstructing the historical evolution of normativity from a global perspective. It includes monographs, editions of sources, and collaborative works. All titles in the series are available both as premium print-on-demand and in the open-access format. MASSIMO MECCARELLI MARÍA JULIA SOLLA SASTRE (EDS.) Spatial and Temporal Dimensions for Legal History Research Experiences and Itineraries MAX PLANCK INSTITUTE FOR EUROPEAN LEGAL HISTORY 2016 ISBN 978-3-944773-05-6 eISBN 978-3-944773-15-5 ISSN 2196-9752 First published in 2016 Published by Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main Printed in Germany by epubli, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin -
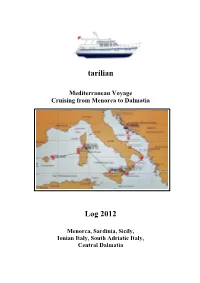
Tarilian Log 2012
tarilian Mediterranean Voyage Cruising from Menorca to Dalmatia Log 2012 Menorca, Sardinia, Sicily, Ionian Italy, South Adriatic Italy, Central Dalmatia Part 1 May/June : Menorca to Sicily page 7 July : Palermo and surroundings page 37 Part 2 August/September : Palermo to Croatia page 51 Disclaimer IPR: All texts and photographs in this document belong to Wilhelm Hartl, 40 Prebend Mansions, London W4 2LU. Web: www.whartl.com (2012) This document represents the personal view of the author at the time of writing. No responsibility will be accepted in relation to the information provided. None of the material must be used for commercial purposes . Menorca to Dalmatia – Cruise Log 2012 Page 2 of 102 Introduction to the Log 2012 In 2010 I started thinking about taking our motorboat Tarilian, a used Trader 535, from the UK to the Central Mediterranean and Adriatic Sea under its own steam, as an alternative to commercial transportation services. The idea was to take our time, as a cruising couple, and, as far as practically possible, do sensible coastal day journeys and enjoy seeing interesting places en route. The preferred route was around the Iberian peninsula, and then via the major Mediterranean islands rather than taking detours along continental coasts. Given the periods of time we wanted to spend on board, the journey would be done over two seasons. I was aware that it would mean a major effort in preparation and execution, as well as costs, but the time seemed right and we expected to gain valuable and unique experience. In our first cruising season, 2011, we took our boat from her home port of Falmouth in Cornwall to the Biscay, around the Iberian peninsula and via Gibraltar into the Mediterranean Sea. -
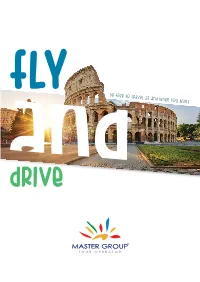
Mastergroupflyanddrive.Pdf
Monumento al Marinaio di Taranto Dedicated to the sailors of the Italian Navy. Apulia Tour / Apulia Baia delle Zagare - FG 1st Day 4th Day Arrival at Bari Airport. Arrival and check-in at hotel in Bari area. In the Breakfast at hotel. Transfer on your own by car to the Itria Valley - land of afternoon visit of Bari. The program of visit, includes among others, fairy trulli. Drive to Martina Franca, a charming town, where besides the Romanesque Basilica of St. Nicholas, Romanesque - Gothic cathedral of famous trulli there is also the center of the city. Walk around the town and San Sabino, a medieval castle of the Emperor Frederick II, Teatro visit the beautiful Basilica of San Martino. Transfer to Ostuni the white Petruzzelli. Dinner on your own and overnight stay at your hotel picturesque town situated on top of a hill. Walk around the city, a visit to accommodation. the baroque Cathedral and the ruins of the twelfth-century castle. Then 2nd Day drive to Alberobello, a town inscribed on the World Heritage List of Breakfast at hotel. Transfer on your own by car to Trani, visiting the UNESCO, for the famous trulli, unique little houses with conical roofs of beautiful cathedral of St. Nicholas, the most outstanding example of gray slate. In the evening return to your hotel. Dinner on your own and Romanesque apulian architecture and Castello Svevo. Return to Bari. The overnight stay at your hotel accommodation. program of visit, includes among others, Romanesque Basilica of St. 5th Day Nicholas, Romanesque - Gothic cathedral of San Sabino, a medieval castle Breakfast at hotel. -

Guide of Lighthouses and Semaphores
Guide of lighthouses and semaphores TM References Guide of lighthouses and semaphores. Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (France), Agence pour la protection et l’Aménagement du Littoral en Tunisie (Tunisia), Société pour la Protection de la Nature au Liban (Lebanon), Municipality of Tyre (Lebanon). Legal note These guidelines have been written under the MED-PHARES project "Integrated Management Strategies to develop the heritage of lighthouses, semaphore stations and maritime signaling systems of the Mediterranean", funded by the EU within the framework of the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin. The contents of this document are the sole responsibility of the beneficiary of the project and partners and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of the management structures of the Programme. Guide of lighthouses and semaphores Italy France Tunisia Lebanon Preface The MED-PHARES project is a cross-border cooperation project, funded by the European Union through the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) for the Mediterranean Maritime Basin (ENPI- CBC MED). The project brings together countries of North, South and East of the Mediterranean area with the Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna (beneficiary of the project - Italy) and four other partners: Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (France), Agence pour la protection et l'Aménagement du Littoral en Tunisie (Tunisia), Société pour la Protection de la Nature au Liban and the Municipality of Tyre (Lebanon). The project aims to develop a model that is applicable in every country of the Mediterranean area, with the purpose of emphasizing the unique material and immaterial features of this heritage including the coastal areas with the presence of lighthouses and semaphore. -

Nurturing the Olympic Dream Page 38
2021 ISSUE 10 WINTER ROLEX MIDDLE SEA RACE: NURTURING THE TOE IN THE MAKING MALTA INSPIRING PERFORMANCE OLYMPIC DREAM WATER A SECOND HOME PAGE 6 PAGE 38 PAGE 48 PAGE 56 Welcome to SPINNAKER The Covid-19 pandemic made us change, overnight, the way with Slovenian Vasilij Žbogar, who also has the honour of having we went about our daily lives. Adapting to new norms, being been on RMSR Line Honours winner Esimit Europa 2 several times. challenged from various facets. Have we grown more resilient ? I sincerely hope so. As the pandemic gave us a bit of respite throughout the summer months, the Club was able to host a number of sailing events. Amongst the many blows dealt by the pandemic, sport was one The 60th Edition of the Malta – Syracuse Race took place – again of the first activities to be negatively impacted. Sailing was no numbers we less than expected but quaratine conditions imposed exception. The majority of our events were cancelled or had to be on Italians did not help. Post RMSR the Club hosted the BOV toned down. Gone were the social events tied around each sailing Autumn Regatta, which saw the biggest fleet for the past few event. We all understood that it was for the greater good that the years, the Raymarine Double Handed Figure of Eight and the Rolex Middle Sea Race Crew Party did not take place. Medcomms Round Malta race. But that was a small price to pay if it meant that the Rolex As you might recall, last year we did not publish a summer edition Middle Sea Race fleet could race. -

Pad Pubblicato Trocchianesi.Pdf
17 PAD. Pages on Arts and Design Lia Krucken International, peer-reviewed, Creative Change, Brazil and Germany open access journal Carla Langella Colophon founded by Vanni Pasca in 2005 Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Italy Giuseppe Lotti Editor-in-Chief Università di Firenze, Italy Marinella Ferrara Tomas Macsotay Design Professor, Politecnico di Milano, Italy Pompeu Fabra University, Spain Nicola Morelli Advisory Board Aalborg University, Copenhagen, Denmark Tevfik Balcıoğlu Alfonso Morone Yaşar University, Izmir, Turkey Università Federico II, Napoli, Italy Murat Bengisu Raquel Pelta Izmir University of Economics, Turkey Universidad de Barcelona, Barcelona, Spain Isabel Campi Anna Cecilia Russo Design History Foundation, Barcelona, Spain Politecnico di Milano, Italy Eduardo Corte Real Daniele Savasta UNIDCOM/IADE, Lisbon, Portugal Yaşar University, Izmir, Turkey Antonio da Cruz Rodrigues Rosanna Veneziano Universidad Lusofona, Lisbon, Portugal Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Italy Soumiya Mikou Artemis Yagou Moroccan Design Association, Casablanca, Morocco ICOHTEC, Munich, Germany Vanni Pasca Li Zhang Italian Association of Design History, Milan, Italy Beijing Information Science and Technology University, China Ely Rozenberg IED Rome and Ely Rozenberg Design, Italy and Israel Publishing Consultant Mireia Frexia Serra Vincenzo Castellana, Architect, Italy Gracmon, Universitat de Barcelona, Spain Andreas Sicklinger Art Direction Università di Bologna, Italy Francesco E. Guida Fedja Vukić -

Campania/Rv Schoder. Sj
CAMPANIA/R.V. SCHODER. S. J. RAYMOND V. SCHODER, S.J. (1916-1987) Classical Studies Department SLIDE COLLECTION OF CAMPANIA Prepared by: Laszlo Sulyok Ace. No. 89-15 Computer Name: CAMPANIA.SCH 1 Metal Box Location: Room 209/ The following slides of Campanian Art are from the collection of Raymond V. Schader, S.J. They are arranged alpha-numerically in the order in which they were received at the archives. The notes in the inventory were copied verbatim from Schader's own citations on the slides. CAUTION: This collection may include commercially produced slides which may only be reproduced with the owner's permission. I. PHELGRAEA, Nisis, Misenum, Procida (bk), Baiae bay, fr. Pausilp 2. A VERNUS: gen., w. Baiae thru gap 3. A VERNUS: gen., w. Misenum byd. 4. A VERN US: crater 5. A VERN US: crater 6. A VERNUS: crater in!. 7. AVERNUS: E edge, w. Baths, Mt. Nuovo 1538 8. A VERNUS: Tunnel twd. Lucrinus: middle 9. A VERNUS: Tunnel twd. Lucrinus: stairs at middle exit fl .. 10. A VERNUS: Tunnel twd. Lucr.: stairs to II. A VERNUS: Tunnel twd. Lucrinus: inner room (Off. quarters?) 12. BAIAE CASTLE, c. 1540, by Dom Pedro of Toledo; fr. Pozz. bay 13. BAIAE: Span. 18c. castle on Caesar Villa site, Capri 14. BAIAE: Gen. E close, tel. 15. BAIAE: Gen. E across bay 16. BAIAE: terrace arch, stucco 17. BAIAE: terraces from below 18. BAIAE: terraces arcade 19. BAIAE: terraces gen. from below 20. BAIAE: Terraces close 21. BAIAE: Bay twd. Lucrinus; Vesp. Villa 22. BAIAE: Palaestra(square), 'T.