La Storia Del Casoncello
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SEZIONE B - ELENCO in ORDINE ALFABETICO PER PRODOTTO Aggiornato Al 01/09/2021 B.2 ALIMENTI SENZA GLUTINE
SEZIONE B - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO PER PRODOTTO aggiornato al 01/09/2021 B.2 ALIMENTI SENZA GLUTINE PRODOTTO IMPRESA CODICE ABONETT GALLETTE DI SAPORI DELLE MARCHE 14407 PANE BIO MAIS ABONETT GALLETTE DI SAPORI DELLE MARCHE 14410 PANE CON FARINA DI MIGLIO ACCHIAPPI FARMO S.P.A. 7227 Adele - biscotti rotondi glassati MSG ITALIA S.R.L.S. 905 al cioccolato AFARABELLA GNOCCHI DI BIOALIMENTA - S.R.L. 3836 PATATE SG Agluten Baci di dama NOVE ALPI S.R.L. 457 Agluten Bacioni vari gusti NOVE ALPI S.R.L. 486 Agluten Bastoncini all'olio NOVE ALPI S.R.L. 466 extravergine di oliva Agluten Bianconeri frolla e NOVE ALPI S.R.L. 467 cioccolato AGLUTEN BISCOTTI AL NOVE ALPI 17044 CACAO AGLUTEN BISCOTTO DEL NOVE ALPI 17048 MATTINO AL BURRO AGLUTEN BRIOCHE NOVE ALPI 18268 Agluten Brioche con gocce di NOVE ALPI S.R.L. 312 cioccolato Agluten Brioche con uvetta NOVE ALPI S.R.L. 316 AGLUTEN BRIOCHE SENZA NOVE ALPI 18269 ZUCCHERO AGLUTEN CANESTRELLI AL NOVE ALPI 17873 CIOCCOLATO SENZA GLUTINE AGLUTEN CANESTRELLI NOVE ALPI 17871 ALLA MELA SENZA GLUTINE AGLUTEN CANESTRELLI NOVE ALPI 17872 ALL'ALBICOCCA SENZA ZUCCHERO SENZA GLUTINE Agluten Ciambelline allo yogurt NOVE ALPI S.R.L. 468 Agluten Cioccocake NOVE ALPI S.R.L. 494 Agluten Cioccocake plum cake NOVE ALPI S.R.L. 469 al cioccolato Agluten Coccosfizi con cocco NOVE ALPI S.R.L. 470 rapè AGLUTEN CROISSANT NOVE ALPI 18272 Agluten Croissant ai frutti di NOVE ALPI S.R.L. 596 bosco Pagina 1 PRODOTTO IMPRESA CODICE Agluten Croissant al Pistacchio NOVE ALPI S.R.L. -

EDITION the Fresh Pasta CATALOGUE
22nd EDITION the fresh pasta CATALOGUE 22nd EDITION Deep-frozen product (refrigerate at -18°C) The images are only intended to show the product. For further details about product characteristics, list of ingredients and possible allergens, please refer to the technical datasheets. A LEGACY OF TRADITION a tiny artisan workshop, we were first inspired In with the courage to believe in our passion: a deep affection and love for the traditions of our native Romagna. Just an old family recipe to start with. Then the experience of four generations of pasta makers. Plus a passion for getting things just right. quality tradition deep-freezing And finally our dream: to bring traditional fresh Italian pasta to the dining tables of the whole world. To do this we have studied every Over the past 40 years, Our only friend - the freezing ® last detail: from the quality of our intensive research and cold. Laboratorio Tortellini 's the ingredients to the ability of analysis has enabled us to build expertly deep-frozen pasta Cappelletti Romagnoli, Tortellini Bolognesi, Tagliatelle, advanced machines capable up a catalogue of over 100 products - increasingly the Garganelli, Strozzapreti, Gnocchetti... As you browse of repeating the gestures of products: the heritage of the preferred choice of quality through this catalogue, you will discover that the human hands and offering you entire Italian peninsula. restaurants and now coming shape of each and every pasta in your most exquisite a pasta that retains every single to kitchens all over the world. characteristic of fresh artisanal recipes has a unique story to tell of its origin, history pasta. -

Grana Padano Or Parmigiano Reggiano, and Dressed with Garlic and Sage That Are Lightly Fried in Butter Together
ITALIAN TIPICAL FOOD AND DRINK SECOND COURSE FIRST COURSE CHEESE FOOD SPECIALITY DESSERT WINE DRINK LIQUEUR CAFFÉ FIRST COURSES PASTASCIUTTA Pasta is a staple food of traditional Italian cuisine, now worldwide renowned and it comes in a variety of different shapes that serve both for decoration and as a carrier for the different types of sauce and foods. There are hundreds of different types of pasta. All of you certainly know spaghetti, maccheroni, fusilli and lasagne. LASAGNE Lasagne is a wide and flat type of pasta and possibly one of the oldest shapes. The word also refers to a dish made with this type of pasta. Featuring layers of pasta, ragout and béchamel sauce. RISOTTO ALLO ZAFFERANO Risotto is rice cooked in broth to a creamy consistency. It is one of the most common ways of cooking rice in Italy. Risotto is normally a first cours (primo) but risotto alla milanese is often served together with ossobuco alla milanese (marrow bone). PIZZOCCHERI Pizzoccheri are a type of short tagliatelle, cooked along with greens and cubed potatoes. This mixture is layered with pieces of Valtellina Casera cheese and ground Grana Padano or Parmigiano Reggiano, and dressed with garlic and sage that are lightly fried in butter together. CASONCELLI Casoncelli are a kind of stuffed pasta, typical of the culinary tradition of Lombardy. The shell typically consists of two sheets of pasta, pressed together at the edges. While the stuff can vary according to local traditions. They are typically served with burro e salvia: melted butter flavored with sage leaves. SECOND COURSE POLENTA E SPIEDO Polenta, also known as corn omelette, is a dish made from boiled cornmeal. -

Clicca Qui Per Scaricare Il Ricettario Dei Casoncelli Bresciani In
il Festival e il 1° Concorso dei Casoncelli della Provincia di Brescia - Fiera di Orzinuovi 2 Settembre 2018 1948-2018 FIERA di ORZINUOVI Settembre 2018 1° Concorso dei Casoncelli della Provincia di Brescia il Ricettario 1 il Festival e il 1° Concorso dei Casoncelli della Provincia di Brescia - Fiera di Orzinuovi 2 Settembre 2018 il Festival e il 1° Concorso dei Casoncelli1948-2018 della Provincia di Brescia - Fiera di Orzinuovi 2 Settembre 2018 FIERA di ORZINUOVI Settembre 2018 1° Concorso dei Casoncelli della Provincia di Brescia assieme allo spiedo, il piatto della festa, un piatto che ricorda gli avvenimenti È più importanti della vita familiare e comunitaria. Non c’è ricorrenza che non veda i casoncelli protagonisti, non c’è santo che non li porti in tavola: Sant’Antonio, San Faustino, Sant’Andrea, San Giovanni, San Vincenzo, Sant’Anna, San Bartolomeo… Non c’era occasione migliore dei 70 anni della Fiera Regionale di Orzinuovi per proporre un concorso a loro dedicato. Detto, fatto. Nuova Orceania, ente organizzatore della rassegna fieristica, dà il via al 1° Concorso dei Casoncelli Bresciani. Una varietà di casoncelli, proveniente da diversi paesi della provincia, è stata cucinata e servita ad una giuria di esperti, giornalisti e visitatori, guidata da Marino Marini È un evento di cuoco, giornalista enogastronomico e bibliotecario di Alma Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Comune di Libertà di proporre il casoncello tradizionale delle valli, città o della Bassa Bresciana ORZINUOVI Provincia di Brescia e spazio libero alla fantasia, con solo una richiesta: ingredienti bresciani. Ciò che a noi interessa è il mantenimento di una antica tradizione tramandata ORZINUOVI da generazioni e intravedere, con l’aiuto dei concorrenti, le innovazioni. -
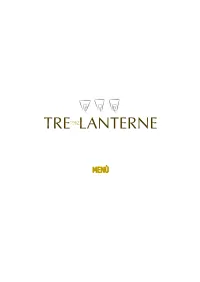
MD-Document-620Dc7b6-3B7e-4F61-Ba8e
MENÙ Fondato da Annita Vecchierelli e Vincenzo Nozza nel 1962, il ristorante Tre lanterne rappresenta da sempre un punto di riferimento per la buona cucina italiana nel territorio della bassa pianura bergamasca. Nel tempo il ristorante Tre lanterne è divenuto anche pizzeria, con le sue ormai famose schiacciate, proposte in più di ottanta diverse farciture. Espressione di una tradizione del gusto, i piatti conservano ancora oggi la semplicità e la genuinità di una cucina familiare, dove la qualità è assicurata dalla passione per il “buon mangiare” e per il “buon bere”. Hamburgheria Hamburger di carne Classic burger € 12,00 150g macinata scelta, cipolla caramellata, maionese, salsa pomodoro e mozzarella Sfizioso burger € 12,00 150g macinata scelta, foglia di spinacino, crema di formaggio tartufato e philadelphia Gallinaccio burger € 12,00 150g macinata scelta, insalata iceberg, mozzarella, uovo fritto, bacon e maionese Hamburger vegetariani Bufalo burger € 12,00 burger di verdure grigliate, mozzarella di bufala, rucola e maionese Ligure burger € 12,00 burger di verdure grigliate, philadelphia, pesto e pomodori secchi Tutti i nostri hamburger sono serviti con patatine fritte, ketchup e maionese Antipasti Tagliere di salumi lombardo con scamorza alla brace e polenta € 10,00 (salame bergamasco, pancetta steccata, fiocco di crudo, lonzino, mortadella del Berlinghetto) Culatello di Parma con bufala e gnocco fritto € 13,00 Tartare di fassona con vinegrette al tartufo e € 13,00 insalatina di carciofi Uovo fritto con asparagi e bacon croccante € -

TASTING MENU 3 COURSE TASTING MENU $45 (Per Person)
PASTE FATTE IN CASA (Fresh homemade pasta) FIORELLINI DI TARTUFI AL BURRO FUSO 15/22 Fresh eggs and porcini homemade pasta stuffed with mascarpone & truffle paste drizzled with butter & Parmesan RAVIOLI ALLA MOZZARELLA HaLf order 15 Homemade ravioli stuffed with fresh FuLL order 22 mozzarella and basil; tossed in a fresh and sundried tomato sauce TASTING MENU CASONCELLI BERGAMASCA Half order 15 Sausage ravioli, pancetta, butter, sage Full order 22 3 COURSE TASTING MENU And Parmesan cheese $45 (per person) AGNOLOTTI DI ZUCCA Half order 15 (CHOICE OF SALAD OR APPETIZER, Butternut squash ravioli, walnuts Full order 22 MAIN COURSE AND DESSERT Parmesan cheese, brown butter sage sauce CARAMELLE ARAGOSTA E BACON Half order 15 NO SHARING PLEASE) Lobster and bacon ravioli Full order 22 Vodka tomato cream sauce PIATTI PICCOLI RAVIOLI DI PERE Half order 15 Grilled pears and mascarpone ravioli Full order 22 BURRATA E PROSCIUTTO 16 Cream and parmesan sauce with walnuts Thinly sliced cibatta parmesan crouton; GNOCCHI SORRENTINA Half order 16 Topped with Burrata cheese prosciutto and arugula Homemade potato dumplings Full order 22 FRITTO MISTO ALLA MIKELE 14 In a sauce of fresh tomatoes, marinara &mozzarella Calamari, shrimp, broccoli & zucchini fried, with 3 sauces LASAGNA TRADIZIONALE 21 CARPACCIO 14 Fresh egg pasta layered with bolognese sauce, Thin sliced beef, lemon olive oil Parmesan capers Bechamelle sauce and Parmesan cheese COSTINE DI MAIALE PICCANTI 14 ASSAGGIO 24 Pork ribs dry marinated with Cajun spices; Tasting of 3 homemade ravioli and -

Dipartimento Di Prevenzione
MENU’ ANNO SCOLASTICO 2020-2021 BREMBATE MATERNA E PRIMARIA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI PRIMA SETTIMANA Ravioli di magro Pasta al ragù di verdure Risotto alla parmigiana Pasta integrale al Pizza margherita Formaggio fresco ½ porz Merluzzo gratinato Fesa di tacchino al forno pomodoro Formaggio ½ porz Carote grattugiate Finocchi al vapore Insalata Frittata al forno Fagiolini Pane Pane Pane Zucchine Pane Frutta Frutta Frutta Pane Frutta 01/03 02/03 03/03 Frutta 05/03 04/03 SECONDA SETTIMANA Pasta alla ricotta Gnocchi al pesto Riso olio e salvia lasagne al ragù di carne Pasta pomodoro e olive Polpette alla pizzaiola Formaggio asiago Platessa/totani gratin ½ porz formaggio Farinata di ceci Carote al vapore Insalata mista Patate al forno Insalata verde Zucchine Pane Pane Pane Pane Pane Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 TERZA SETTIMANA Pasta pomodoro e pesto Riso al pomodoro Polenta Quadrucci alla zucca Pasta agli aromi Frittata al forno Bocconcini di pollo Brasato di manzo Form. fresco ½ porz Merluzzo gratinato Spinaci Finocchi al vapore Fagiolini al vapore Insalata mista Carote al vapore Pane Pane Pane Pane Pane Frutta Frutta Frutta Frutta Frutta 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 QUARTA SETTIMANA Risotto alla milanese Pasta al tonno Pizza margherita Pasta al ragù di verdure Pasta all’olio Polpette alla pizzaiola ½ porz tacchino freddo Formaggio ½ porz Merluzzo olio e limone Farinata di lenticchie Patate al forno Carote grattugiate Fagiolini al vapore Finocchi al vapore Insalata Pane Pane Pane Pane Pane -

Soup Pasta Risotto
ANTIPASTI FREDDI- COLD APPETIZER Caprese al profumo di tortufo -Toasted bread with fresh Datterini tomato, buffalo mozzarella and truffle oil 480 Burrata con pomodorini, basilico e olio di olive- Burrata with Roma & cherry tomato, rucola salad, olive oil with fried basil 580 Insalata di carciofi-(GF)- Artichoke, avocado, parmesan, rucola 480 Carpaccio di Manzo-(B)- Cured raw Chianina beef, rocket, tomatoes, Parmesan cheese, caramelized onion 580 La Cucina antipasto-(P)- Italian air dried meats, grilled artichokes, sun flush tomato, melon & pickled vegetables 880 ANTIPASTI CALDI- WARM APPITZER Fungi di bosco barbeque-(GF) - Sautéed assorted wild mushrooms 580 Asparagi alla contessa-(GF)- Warm asparagus with caramelized shallots 620 Calamari alla luciana-(S)(GF)- Squid in tomato, garlic & chili 680 Polpo arrosto, patata schiacciata, olive, pomodorini secchi-(S)(GF) - Roasted octopus, crushed potato, olives, sundried tomatoes, pesto 820 ZUPPE- SOUP Minestrone - Vegetable soup with basil pesto 380 Zuppa di asparagi - Asparagus soup 480 Seafood “cacciucco” soup(S) - Tuscan style calamari, shrimp, mussels, clams, lobster bisque, fresh tomato, basil in olive oil bread 520 PASTA Tortelini ripeni di spinaci e ricotta- Spinach ricotta totelllini tossed in walnut butter, served with cherry tomatoes 880 Gnocchi di patate e ricotta in salsa di fungi-Potato, ricotta gnocchi in shimeji mushroom sauce 720 Gnocchi alla sorentina- Potato gnocchi with tomato sugo, basil oil bocconcini 720 Casoncelli d agnello, salsa funghi fonda d agnello-(M)- Lamb casoncelli -

| Hai Lala at Tata Ta Mo Na Atau
|HAI LALA AT TATAUS009883690B2 TA MO NA ATAU HUT (12 ) United States Patent ( 10 ) Patent No. : US 9 , 883 ,690 B2 Weinberg - Sehayek et al. (45 ) Date of Patent: * Feb . 6 , 2018 (54 ) READY - TO - EAT FRESH SPAGHETTI -LIKE (56 ) References Cited FISH PRODUCTS , METHODS OF MANUFACTURE THEREOF U . S . PATENT DOCUMENTS 4 , 704 , 291 A * 11/ 1987 Nagasaki A23L 17 / 70 (71 ) Applicant: GRADIENT AQUACULTURE 426 /513 ( 72 ) Inventors : Noam Weinberg -Sehayek , Shenzhen 4 ,806 , 378 A 2 /1989 Ueno et al. ( CN ) ; Avraham Weinberg , Kiryat Yam (Continued ) ( IL ) FOREIGN PATENT DOCUMENTS ( 73 ) Assignee : GRADIENT AQUACULTURE , CN 101011164 A 8 /2007 Shenzhen (CN ) CULTURE, CN 101209113 A 7 /2008 (Continued ) ( * ) Notice : Subject to any disclaimer , the term of this patent is extended or adjusted under 35 U . S . C . 154 ( b ) by 0 days . OTHER PUBLICATIONS This patent is subject to a terminal dis Rolls B . J . et al ., “ How flavour and appearance affect human claimer . feeding ” , Proceedings of Nutritions Society , Jun . 1982, Great Brit ain , vol. 42 , No. 109 , pp . 109 - 117 . (21 ) Appl. No. : 15 / 262 , 211 (Continued ) (22 ) Filed : Sep . 12 , 2016 Primary Examiner — Robert A Wax Assistant Examiner — Melissa Mercier (65 ) Prior Publication Data US 2017 /0049138 A1 Feb . 23 , 2017 (57 ) ABSTRACT The present invention provides a pasta - like shaped edible Related U . S . Application Data product comprising surimi, fish or portions thereof, prepared (63 ) Continuation - in -part of application No . 14 /601 , 765 , by a process consisting of the steps of: a . chopping frozen surimi to chips ; filed on Jan . 21 , 2015 , which is a continuation - in - part b . -

Menu Degustazione $110
MENU DEGUSTAZIONE $110 STUZZICHINI FOIE GRAS PASTRAMI WITH TOASTED BRIOCHE AND MOSTARDA $24 18 mo. PROSCIUTTO, MAPLE SMOKED DUCK BREAST, GRISSINI AND PICKLED VEGETABLES $24 ANTIPASTI OCTOPUS CARPACCIO WITH GRAPES, CHICORIES AND HAZELNUTS BEEF TENDERLOIN TARTARE WITH GNOCCHI FRITTI, NORI SALT AND HORSERADISH SWEET ONION CREPE WITH TRUFFLE AND PARMESAN FONDUE SWEETBREAD “TONNATO” CRISPY SWEETBREADS WITH BACCALÀ CREMA AND THINLY SLICED LARDO SEAFOOD FANTASIA - BEAUSOLEIL OYSTER WITH TOMATO GRANITA; HAMACHI CRUDO WITH OSETRA CAVIAR; CARABINEROS PRAWN WITH FENNEL AND PRESERVED BERGAMOT ($22pp SUPPLEMENT) PASTA SWISS CHARD GNOCCHI WITH SHAVED RICOTTA SALATA AND BROWN BUTTER ALMOND TORTELLINI WITH TRUFFLE BUTTER CASONCELLI ALLA BERGAMASCA WITH PANCETTA & SAGE HAND CUT PAPPARDELLE WITH RABBIT BOLOGNESE TAGLIOLINI WITH LOBSTER AND ‘NDUJA CHESTNUT FETTUCCINE WITH WILD BOAR RAGU ADDITIONAL PASTA ($22 SUPPLEMENT) SECONDI WHOLE ROASTED FLUKE WITH CHERRY TOMATOES, OLIVES AND POTATO GALETTE GUINEA HEN STUFFED WITH FOIE GRAS AND PROSCIUTTO WITH LOCAL MUSHROOMS PECORINO RISO AL SALTO WITH CHARRED SPIGARELLO KALE SALT CRUSTED BRANZINO WITH CHARRED BRUSSELS SPROUTS AND BLACK TRUFFLE BUTTER FOR TWO ROASTED BABY GOAT WITH SOFT POLENTA AND JUS ($35 SUPPLEMENT) DOLCI CHOCOLATE POLENTA SOUFFLE WITH VANILLA GELATO MOLTEN PEANUT BUTTER CAKE WITH CONCORD GRAPE GELATO BLACK MISSION FIG AND ALMOND CROSTATA COCONUT SEMIFREDDO WITH GREEN APPLE SORBETTO AND JASMINE TEA SELECTION OF CHEESE WITH TOASTED HAZELNUT STRAWBERRY BREAD AND ACCOMPANIMENTS ($12 SUPPLEMENT) . -

Eccellenza E Passione in Cucina
listino2017 Eccellenza e passione in cucina indice prodotti i tartufi i surgelati Tartufi freschi 03 Verdure surgelate 31 Tartufi conservati e derivati 03/04/05 Le sfoglie 31 Tagliatartufi 05 I mignon 31 i funghi I fritti 32 Funghi freschi spontanei e coltivati 06 Dim sum 33 Funghi surgelati 07 i prodotti asiatici Funghi secchi 07 Prodotti asiatici 33 Funghi secchi confezionati 07 le decorazioni Funghi sott’olio in vasi grandi e piccoli 08 Oro e argento alimentari 34 i prodotti ittici Perle di sapore 34 Caviale fresco 09 i dessert Bottarga 09 Dessert gelo 35/39 Baccalà dissalato surgelato 09 macarons Astice crudo surgelato 10 Macarons dolci e salati 40 Prodotti ittici surgelati e affumicati 10 il tè e lo zucchero Salmoni affumicati 10 Tè biologico 41/42 Prodotti ittici in conserve 11 Zucchero di canna - La perruche 43 Tonno sott'olio 11 le tartellette Alghe di bretagne e confettura di alghe 11 Tartellette croc'in 44/45 Ittici del Mar Cantabrico 12 il cioccolato il foie gras Cioccolato 46 Fegato d’oca e d'anatra fresco 13 la pasta e il riso Prodotti Valette oca e anatra 13 Pasta artigianale fresca s/v 47 le bevande Ravioli freschi fatti a mano 47 Vini da dessert 14 Pasta fresca 47 Champagne dumenil 14 Pasta artigianale ripiena surgelata 48 Altri vini 14 Pasta barilla selezione oro 48 Succhi e soft drink 15 Pasta senza glutine 49 i prosciutti e i salumi Primo grano (100% abruzzese) 49 Prosciutti e salumi spagnoli 16 Riso 50 Carni di suino iberico Bellota surgelate 16 Cous-cous 50 Prosciutti e salumi Joselito 17 i grissini e taralli Salumi -

Takeaway Monte Cassino 2020
Pasta (All our pasta is hand made fresh daily) (Gluten free pasta available on request) Spaghetti al filetto Pan fried chopped fillet steak, garlic, rich tomato sauce and a splash of cream £10.90 Spaghetti Vongole (Fish market availability) – Fresh clams in the shells, garlic, cherry tomato and a drizzle of olive oil £12.90 Spaghetti Carbonara £9.50 Spaghetti Bolognese £9.90 Fettuccine alla Norcia Blend of fresh Italian sausage, mushrooms, porcini and cream reduction £10.90 Fettuccine al pasticcio Bolognaise sauce, spicy sausage, mushroom and a touch of cream £10.90 Monte Penne Piccanti Tomato, garlic, olive oil and fresh homemade chilli £8.90 Scarpariello Cherry tomato, garlic, olive oil, fresh basil and shredded buffalo mozzarella £8.90 Penne quattro formaggi – Four Italian cheese sauce - £8.90 Penne Papa’Alfonso £9.90 Sundried tomato, mushrooms, porcini, rich tomato and garlic sauce presented with shaving of fresh parmesan cheese Tortelloni Large tortelloni stuffed with goat cheese and peppers in a cream sauce £10.90 Ravioli al porcini Homemade pasta stuffed with porcini mushroom, cooked in a blend of cream and mushroom reduction £10.90 Casoncelli Stuffed with meat, amaretto biscuit, cooked with ham, mushroom and cream £10.90 Lasagna Traditional homemade meat lasagna £9.90 Ravioloni di Ricotta Cassino Stuffed ravioli with ricotta cheese and parmiggiano in a tomato and cream sauce £9.90 Spaghetti Mare Mixed shellfish, garlic, cherry tomato, olive oil and a touch of chilli £13.90 Takeaway Menu Spaghetti con Polpettine Baby meatballs cooked